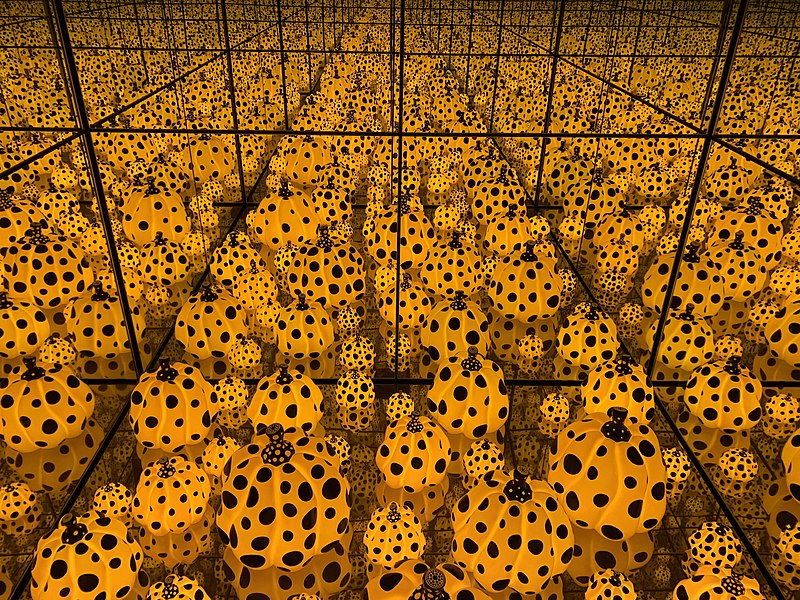Il Decameron di Giovanni Boccaccio, scritto probabilmente tra il 1349 e il 1351, subito dopo la terribile peste del 1348, è un’opera fondamentale della letteratura del Trecento europeo. Quest’opera, una sorta di commedia umana, presenta una struttura complessa in cui possiamo individuare una cornice e una supercornice, elementi che le donano grande modernità. Boccaccio fotografa la società del suo tempo, mettendone in luce vizi e virtù con uno sguardo ironico e, a tratti, dissacrante.
Indice dei contenuti
| Elemento Strutturale | Descrizione e funzione |
|---|---|
| Supercornice | Lo spazio dell’autore (Boccaccio) che interviene nel Proemio, nell’Introduzione alla IV giornata e nella Conclusione per rivolgersi ai lettori. |
| Cornice | La storia della “onesta brigata” di dieci giovani che fuggono dalla peste di Firenze e decidono di raccontare novelle. |
| Novelle | Le cento storie raccontate dai dieci giovani, che costituiscono il corpo centrale dell’opera. |
La struttura del Decameron e i livelli di narrazione
Il Decameron è una raccolta di cento novelle narrate da una lieta brigata di dieci giovani (sette ragazze e tre ragazzi) nel corso di dieci giornate. Il titolo stesso, dal greco déka hēmérōn, significa “di dieci giorni”. A ogni giornata, tranne la prima e la nona, corrisponde un tema specifico, scelto dal re o dalla regina eletto per quel giorno. All’interno dell’opera sono presenti tre livelli di narrazione:
- Primo livello: la voce dell’autore (la supercornice).
- Secondo livello: i dieci giovani narratori della brigata (la cornice).
- Terzo livello: i personaggi delle novelle che, a volte, raccontano a loro volta storie.
Supercornice del Decameron: la voce dell’autore
Il primo livello di narrazione fa riferimento alla voce dell’autore reale, Giovanni Boccaccio. In tale livello ritroviamo la supercornice, cioè lo spazio che l’autore riserva a sé. Essa è composta dal Proemio, dalla conclusione e dagli interventi in cui l’autore fa riflessioni sulla sua opera, sulla letteratura e sul ruolo dello scrittore. Nella supercornice Boccaccio si rivolge direttamente ai lettori.
Il Proemio e la dedica alle donne
Nel Proemio, Boccaccio espone i motivi per cui ha scritto l’opera e la sua dedica: questa è indirizzata alle donne afflitte da pene d’amore, allo scopo di offrire loro intrattenimento e diletto. Le donne, infatti, rispetto agli uomini, hanno meno possibilità di svago per alleviare le loro sofferenze. Boccaccio vuole offrire loro, attraverso la lettura, una fonte di consolazione.
L’autodifesa di Boccaccio
Poiché il tema dell’amore, e in particolare dell’eros, è centrale, Boccaccio sente la necessità di difendersi dalle possibili critiche, e lo fa nell’introduzione alla IV giornata (nella “novella delle papere“) e nella conclusione. L’autore si difende dalle accuse di eccessiva licenziosità, affermando che la letteratura deve essere libera di trattare ogni argomento. La rappresentazione dell’amore, in tutte le sue forme, rientra a pieno titolo nel suo campo d’azione.
La cornice del Decameron: la fuga dalla peste
La struttura “a incastro” del Decameron prevede che la supercornice contenga la cornice, ovvero lo spazio e il tempo in cui si muovono i dieci novellatori: Pampinea, Fiammetta, Filomena, Emilia, Elissa, Neifile, Lauretta, Dioneo, Filostrato e Panfilo. La cornice funziona come macro-racconto, composto dall’antefatto e dalla descrizione della peste.
La peste a Firenze e il locus amoenus
Nella Firenze del 1348, devastata dalla peste, un gruppo di giovani, la brigata, si incontra nella Basilica di Santa Maria Novella e decide di ritirarsi in campagna per sfuggire al contagio, in un luogo idilliaco, un vero locus amoenus. La descrizione della peste è estremamente realistica e serve a introdurre il tema della fragilità umana. Durante queste giornate, per passare il tempo, ogni giovane racconta una novella, creando un rituale di narrazione.
La funzione della cornice narrativa
La funzione della cornice è dare una struttura ordinata alle cento novelle e contestualizzarle, creando un filo conduttore che le unisce. La cornice ha anche lo scopo di dare compattezza alla narrazione, collegando le varie novelle attraverso i commenti e i dialoghi dei novellieri. Così come la supercornice comprende la cornice, questa, a sua volta, comprende il racconto, in un gioco di scatole cinesi. Ogni novella può essere considerata un exemplum, un racconto che racchiude un esempio di comportamento. La cornice, in definitiva, crea un contesto unitario e coerente per le cento novelle.
Fonte immagine in evidenza: Pixabay
Articolo aggiornato il: 28/08/2025