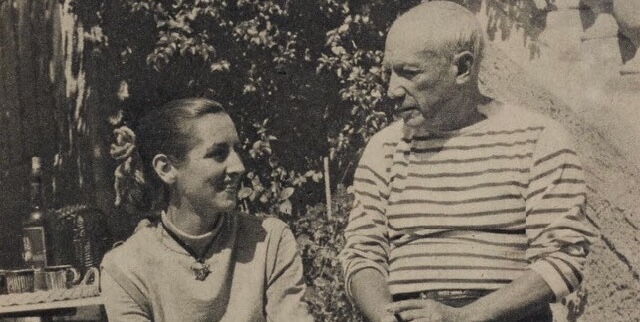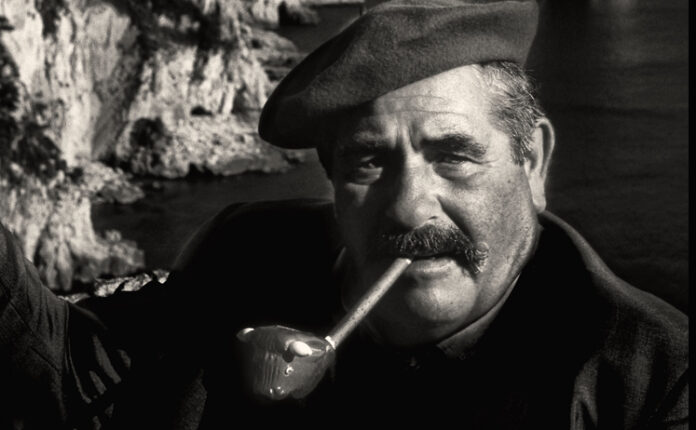La cromofobia è un termine coniato dall’artista e scrittore scozzese David Batchelor per descrivere una radicata e persistente resistenza al colore nella cultura occidentale. Nel suo saggio omonimo, Batchelor analizza come questa “paura del colore” si sia manifestata storicamente attraverso il tentativo di purgare, sminuire o controllare il colore, associandolo a concetti considerati alieni o superficiali. Il libro esplora questo fenomeno dalla letteratura del XIX secolo all’architettura e all’arte del XX, dalla Pop Art al Minimalismo, fino ai giorni nostri.
Indice dei contenuti
Quali sono le strategie di marginalizzazione del colore?
| Strategia di marginalizzazione | Come viene percepito il colore |
|---|---|
| Associazione all'”altro” | Il colore è visto come proprietà di un corpo “estraneo”: il femminile, l’orientale, il primitivo, l’infantile o il patologico. In questo modo, viene percepito come alieno e pericoloso. |
| Relegazione al superficiale | Il colore è ridotto a elemento inessenziale, cosmetico o supplementare. Viene considerato una qualità secondaria dell’esperienza, non meritevole di seria considerazione intellettuale. |
L’origine della cromofobia: forma contro colore
La paura del colore in Occidente affonda le sue radici nella filosofia classica, in particolare nella storica disputa tra disegno e colore. La forma e la linea erano associate alla razionalità, all’intelletto e all’ordine (maschile), mentre il colore era legato all’emozione, alla sensualità e al caos (femminile). Questa gerarchia, come analizzato in diversi studi accademici disponibili su piattaforme come JSTOR, ha portato a considerare il colore come un elemento secondario, decorativo e potenzialmente corrotto.
Il predominio del bianco come sintomo
Secondo Batchelor, il sintomo più evidente della cromofobia è l’ossessione per il bianco, un colore che nella cultura occidentale diventa aggressivo e totalizzante. Questo “bianco puro” è visto come un tentativo di imporre ordine e controllo. Esempi letterari come la balena bianca in Moby Dick di Melville o il quasi esclusivo bianco e nero in Cuore di tenebra di Conrad non sono casuali, ma riflettono questa tendenza a usare il bianco come snodo narrativo fondamentale, spesso in opposizione a una “tenebra” colorata e minacciosa.
Le due strategie della cromofobia occidentale
Batchelor sostiene che la cultura occidentale ha adottato due strategie principali per respingere e svalutare il colore (sintetizzate nella tabella precedente). In entrambi i casi, conclude Batchelor, “il colore è di solito escluso dalle più elevate occupazioni della mente. È altro rispetto ai più alti valori della cultura occidentale”.
Il grande equivoco: il bianco della scultura classica
L’esempio più emblematico della cromofobia occidentale è la nostra percezione dell’arte classica. Per secoli, a partire dal Rinascimento, si è creduto che le sculture greche e romane fossero originariamente di un bianco marmoreo puro, simbolo di perfezione e razionalità. In realtà, oggi sappiamo che erano vivacemente policrome. Come dimostrano le ricostruzioni scientifiche di musei come il British Museum, le statue erano dipinte con colori sgargianti. La perdita dei pigmenti nel tempo ha creato l’illusione di un’antichità acromatica, un’idea che si adattava perfettamente al pregiudizio cromofobico della cultura occidentale, che ha così proiettato sul passato il proprio ideale di purezza formale.
Articolo aggiornato il: 18/12/2025