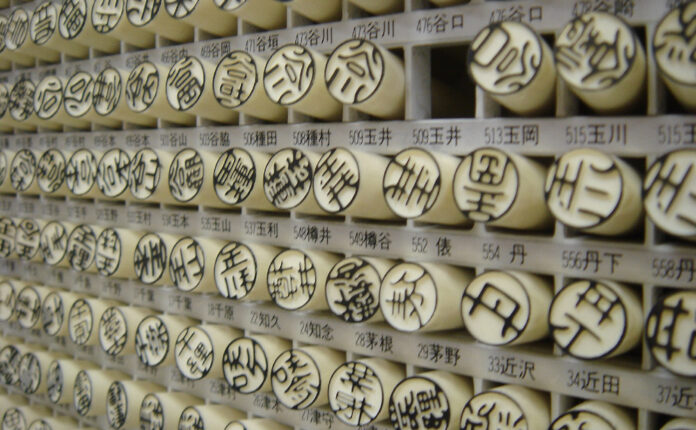Con la resa del 15 agosto 1945 inizia un periodo fondamentale per la storia giapponese: l’occupazione alleata. Guidata dagli americani sotto il comando del generale Douglas MacArthur, questa occupazione mirava a “migliorare” le condizioni di vita in Giappone, introducendo riforme democratiche e promuovendo i diritti civili. Se da una parte l’intervento dello SCAP (Supreme Commander for the Allied Powers) portò a riforme positive, dall’altra si aprì una pagina oscura. Nonostante gli ordini formali, le violenze da parte dei soldati furono diffuse, e le principali vittime furono le donne giapponesi.
Indice dei contenuti
La paura delle violenze e la creazione della RAA
La risposta del governo giapponese alla paura di violenze di massa fu la creazione dell’Associazione per le Attività Ricreative e il Divertimento (RAA). Il timore era che i soldati americani potessero replicare le atrocità commesse dall’esercito giapponese in Cina, come il Massacro di Nanchino. La RAA istituì una rete di case di tolleranza per “incanalare” gli istinti dei soldati. Di fatto, il governo, con la tacita approvazione delle autorità di occupazione, organizzò un sistema di prostituzione su larga scala, reclutando migliaia di donne, spesso con l’inganno di un lavoro onesto, per fungere da “argine umano” contro stupri indiscriminati sulla popolazione civile.
La chiusura dei bordelli e l’escalation degli stupri
Alcuni resoconti, come quelli analizzati dalla scrittrice Terese Svoboda, suggeriscono che questi bordelli istituzionalizzati riuscirono inizialmente a limitare i casi di violenza casuale. Questa soluzione, tuttavia, ebbe vita breve. Già nel 1946, a causa della rapidissima diffusione di malattie veneree tra le truppe, il generale MacArthur ordinò la chiusura di tutte le strutture della RAA. La conseguenza fu immediata e drammatica: senza più questi centri “controllati”, le violenze sessuali contro le donne comuni aumentarono in modo esponenziale in tutto il paese.
| Occupazione del Giappone: obiettivi vs. realtà | Conseguenze per la popolazione femminile |
|---|---|
| Obiettivo: democratizzazione e promozione dei diritti civili, inclusa l’emancipazione femminile. | Realtà: violenze sessuali diffuse e creazione di un sistema di prostituzione istituzionalizzato (RAA). |
| Obiettivo: mantenimento dell’ordine e della sicurezza da parte delle forze alleate. | Realtà: impunità per i soldati colpevoli di crimini, con la complicità della censura imposta dallo SCAP. |
| Obiettivo: ricostruzione pacifica della nazione giapponese. | Realtà: un trauma collettivo per le donne, le cui sofferenze sono state a lungo negate o nascoste. |
I “corsi di sopravvivenza”: una protezione illusoria
Con l’aumento delle violenze, alle donne veniva consigliata l’iscrizione a corsi di sopravvivenza. Qui veniva insegnato loro come vestirsi, come comportarsi e come “difendersi” durante gli attacchi. I consigli includevano l’indossare abiti lunghi e a più strati per rendere difficile lo svestimento, farsi sempre accompagnare da figure maschili e urlare per attirare l’attenzione. Questi metodi, sebbene potessero offrire un minimo deterrente, si rivelarono del tutto inadeguati a fermare gli abusi sistematici.
Censura dello SCAP e impunità dei crimini
La maggior parte delle vittime non denunciava per paura e vergogna, ma anche perché l’intero sistema politico e militare del Giappone dipendeva dallo SCAP. Quando la stampa giapponese provò a riportare i casi di violenza, lo SCAP rispose con una ferrea censura. Come documentato da fonti storiche, tra cui la Biblioteca della Dieta Nazionale del Giappone, furono emesse direttive che proibivano la pubblicazione di notizie “distruttive per la pubblica tranquillità” o critiche verso le forze di occupazione, nascondendo di fatto ogni attività criminale. Nella sola prefettura di Kanagawa furono documentati 1.336 stupri nei primi dieci giorni di occupazione, ma i condannati furono pochissimi. I tentativi giapponesi di formare corpi di vigilanza furono repressi duramente.
Le conseguenze a lungo termine delle violenze
Le violenze lasciarono ferite profonde nella società nipponica. Oltre al trauma individuale, si generò un clima di paura e sfiducia. La censura dello SCAP, come analizzato dall’Ufficio Storico del Dipartimento di Stato USA (Office of the Historian), impedì un’elaborazione pubblica del trauma, lasciando le vittime sole e senza supporto. Una delle conseguenze più visibili fu la nascita di migliaia di bambini nippo-americani (konketsuji), spesso frutto di stupri o relazioni forzate, che dovettero affrontare una vita di discriminazione e stigma sociale. Ancora oggi, questo rimane un argomento controverso, e solo negli ultimi decenni la ricerca storica e le testimonianze delle sopravvissute hanno iniziato a far luce su questa pagina oscura della storia.
Fonte immagine: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 07/10/2025