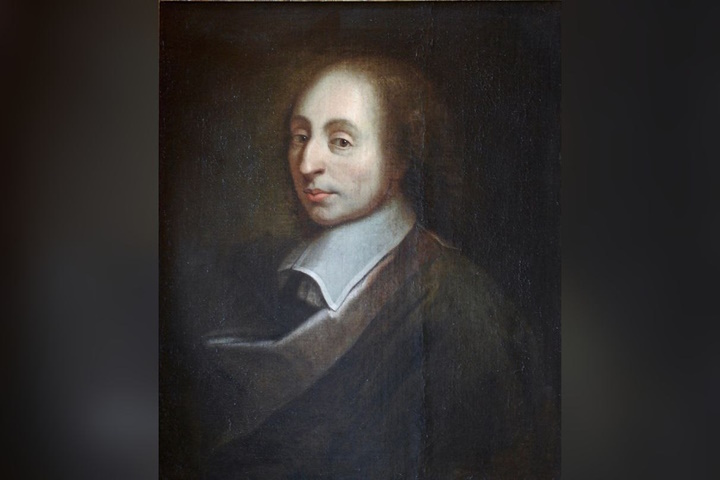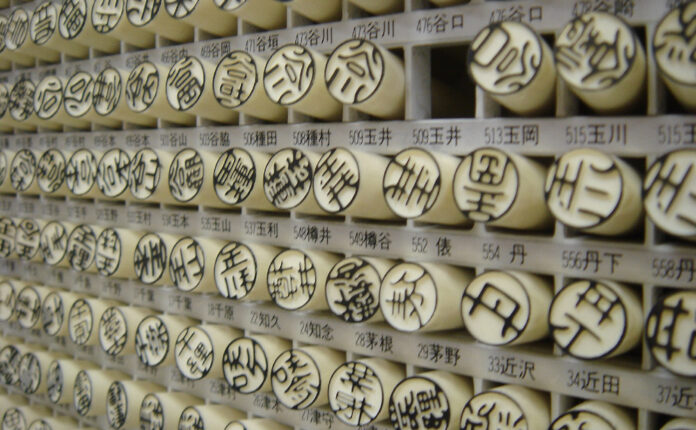Mina Loy (Mina Gertrude Löwy 1882-1966) è stata una scrittrice e poetessa americana, una delle voci femminili più originali del modernismo angloamericano spesso però lasciata ai margini. Il suo nome compare di frequente nei racconti delle biografie di figure centrali del periodo come, ad esempio, Ernest Hemingway, James Joyce e William Carlos Williams. Oggi studiosi e studiose hanno riscoperto i suoi scritti che delineano la figura di una donna colta e intellettualmente indipendente.
Indice dei contenuti
Chi è Mina Loy: sintesi biografica e opere
| Dati biografici | Dettagli chiave |
|---|---|
| Nome completo | Mina Gertrude Löwy |
| Nascita e morte | Londra, 1882 – Aspen, 1966 |
| Movimenti letterari | Modernismo, futurismo |
| Opera celebre | Feminist Manifesto (1914) |
| Coniugi | Stephen Haweis, Arthur Cravan |
La vita di Mina Loy: un continuo viaggio tra arte e cultura
Mina Loy nacque a Londra il 27 dicembre del 1882. Era la figlia di un sarto ebreo ungherese, Sigmund Felix Löwy, e di una madre protestante inglese, Julia Bryan. Il matrimonio di Löwy e Bryan non fu semplice, anzi esso fu oggetto di tensioni: sua madre, non ancora sposata, rimase incinta di sette mesi di Mina e sposò Löwy per via della pressione sociale che ne derivò.
L’educazione artistica e formale di Loy iniziò alla fine del 1897 alla St. John’s Wood School, dove rimase per circa due anni. Il padre di Loy insistette molto affinché sua figlia frequentasse la scuola d’arte, nella speranza che ciò l’avrebbe resa più adatta al matrimonio. Successivamente, Mina Loy si iscrisse all’ Accademia di Belle Arti di Monaco di Baviera. La città di Monaco affascinava molto l’autrice poiché risultava aperta alle stravaganze e Mina Loy, una persona fuori dal comune, si presentava spesso in giro con abiti inconsueti per l’epoca e una pipa di terracotta in bocca.
Nel 1906 convinse i suoi genitori a spostare la sua formazione artistica a Parigi immergendosi, così, nella vita bohémien degli artisti internazionali. Conobbe un pittore e fotografo inglese, Stephen Haweis con cui si sposò. Dopo il matrimonio, i due si stabilirono in Costa S. Giorgio, a Firenze, che ospiterà la nascita dei loro figli. In Italia, Mina Loy si affascinò al Movimento Futurista e partecipò anche alla Prima Esposizione Internazionale Futurista Libera a Roma nel 1911. Durante quel periodo, Loy fu coinvolta in un complicato triangolo amoroso tra Papini e Marinetti – di cui avrebbe scritto ampiamente nelle sue poesie.
Nel 1914 Mina Loy scrisse il Manifesto Femminista, una polemica contro la posizione subordinata delle donne in società. Disillusa dagli elementi macho e distruttivi del futurismo, e desiderosa di essere partecipe a una comunità artistica modernista, Loy si trasferì a New York nell’inverno del 1916. L’anno successivo incontrò il poeta-pugile Arthur Cravan, nipote della moglie di Oscar Wilde, Constance Lloyd. I due si sposarono a Città del Messico nel 1918 e poi di Arthur non si seppe più nulla, scomparve misteriosamente mentre tentava di attraversa il Golfo del Messico su una piccola barca. Di ritorno dal Sud America, Mina Loy si fermò a vivere a New York e nel 1923 pubblicò Per Guida alla Luna, il suo unico libro di poesie.
Analisi del Feminist Manifesto: un testo femminista?
Feminist Manifesto fu scritto da Mina Loy nel 1914 ma la sua pubblicazione avvenne soltanto nel 1982 nell’edizione di The Last Lunar Baedeker. L’autrice scrisse il manifesto mentre si trovava in una comunità di espatriati a Firenze, in Italia. Il periodo che va dal 1914 al 1918 è quello della Prima Guerra Mondiale che fece non pochi danni sia in ambito economico che sociale. Mentre gli uomini furono mandati al fronte per combattere, le donne dovettero sostituirli nella forza lavoro. Nel 1918 il Parlamento votò a favore del Representation of the People Act, una legge che consentì alle donne in Inghilterra il diritto di voto ma a patto che avessero un certo status sociale o economico. Fu in risposta a questi eventi che Mina Loy scrisse il Manifesto Femminista.
Il testo di Mina Loy rifiuta l’idea che la sessualità femminile debba essere vissuta con vergogna e respinge fortemente l’idea che una donna debba limitarsi al ruolo di una buona madre o una buona amante. Con le sue parole, l’autrice stava andando contro i precetti sociali della sua epoca, incoraggiando le donne a non avere il matrimonio come unica aspirazione nella vita. Loy invita il genere femminile a non percepirsi come un oggetto sessuale di proprietà maschile, ma a sganciarsi da una visione patriarcale che ne limita l’identità e la libertà.
Tuttavia, è importante porre attenzione ad un aspetto cruciale: sebbene questo testo manifesti una chiara posizione femminista, esso escludeva diverse categorie di donne. Nel manifesto, infatti, Mina Loy si rivolge solo ed esclusivamente a donne bianche dotate di una “certa intelligenza”. C’è un passaggio del manifesto esplicitamente razzista e poco inclusivo, che mostra i limiti della visione femminista proposta dall’autrice:
«Every woman of superior intelligence should realize her race–
responsibility, in producing children in adequate proportion to
the unfit or degenerate members of her sex»
La scrittrice intende il termine di “razza” nel senso eugenetico del termine. Secondo Mina Loy, tutte le donne avrebbero diritto alla maternità ma soltanto le “donne intelligenti” dovrebbero avere un numero maggiore di figli per compensare la parte di donne “meno intelligenti”, considerate “inadatte”. Si tratta di un’affermazione che è ben distante da un’idea femminista inclusiva.
Conclusioni sul pensiero di Mina Loy
Il Feminist Manifesto di Mina Loy è sicuramente rivoluzionario ma alcuni passaggi lo rendono problematico e contradditorio, suggerendo la necessità di una lettura critica e attenta. Le sue idee sfidano le convenzioni sociali e maschiliste del suo tempo ma, allo stesso tempo, mostrano anche come le idee più progressiste possono cadere nella trappola degli stereotipi radicati in quel determinato contesto storico. In questo caso, si tratta di pregiudizi razzisti e di una classificazione del genere femminile in base all’intelligenza, su chi è intellettualmente colta e chi no, ponendo confine tra chi è ritenuto “superiore” e chi non lo è. Il Feminist Manifesto di Mina Loy deve farci riflettere su quanto sia di vitale importanza l’idea che il femminismo debba essere inclusivo, coinvolgendo tutte le donne senza tracciare limiti in base alla razza, allo status sociale o alla cultura.
Fonte immagine: Wikimedia commons
Articolo aggiornato il: 04/01/2026