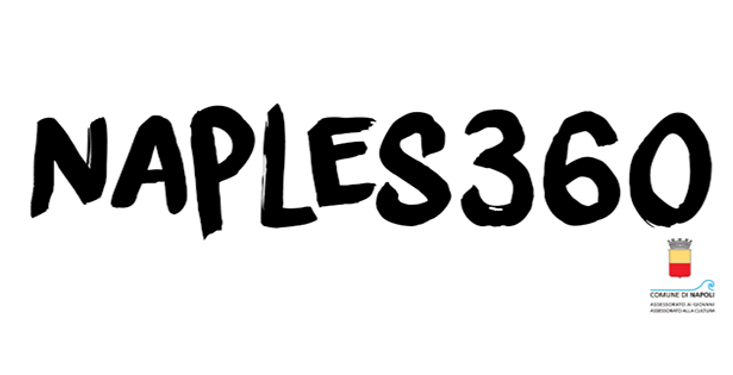Se anche tu, durante le ore di storia al liceo, eri distratto e non hai mai ben compreso la differenza tra guelfi bianchi e neri, ma solo ora senti il bisogno di colmare questa lacuna culturale, sei nel posto giusto. Oggi ti spiegheremo, una volta per tutte, cosa distingue queste due importanti fazioni della Firenze medievale.
Indice dei contenuti
Chi erano i guelfi bianchi e neri?
| Caratteristica | Guelfi bianchi | Guelfi neri |
|---|---|---|
| Famiglia capofila | Cerchi | Donati |
| Classe sociale | Popolo grasso (ricchi mercanti) | Aristocrazia e nobiltà |
| Posizione sul Papa | Sostegno al papato ma con indipendenza politica di Firenze | Pieno appoggio a Bonifacio VIII, anche con ingerenze politiche |
| Esponente famoso | Dante Alighieri | Corso Donati |
L’origine delle fazioni: dai guelfi e ghibellini alla divisione interna
Per comprendere appieno la distinzione tra guelfi bianchi e neri, dobbiamo fare un passo indietro al XII secolo. Il termine “guelfi” deriva da “Welfen”, il nome delle casate bavaresi in conflitto con i “Waiblingen”, i ghibellini, sostenitori della casata degli Hohenstaufen. In Italia, per guelfi si intendevano coloro che sostenevano il papato, mentre i ghibellini appoggiavano l’impero. Dopo la cacciata dei ghibellini da Firenze nel 1289, il partito guelfo, rimasto egemone, si divise in due nuove fazioni: i bianchi e i neri.
Le differenze ideologiche e politiche
Entrambe le fazioni sostenevano il Papa, ma erano divise da profonde divergenze politiche, economiche e ideologiche, che portarono a violenti scontri interni per il controllo della città.
Le famiglie Cerchi e Donati: due visioni opposte per Firenze
I guelfi bianchi, guidati dalla potente famiglia dei Cerchi, rappresentavano gli interessi del “popolo grasso”, ovvero i ricchi mercanti e finanzieri. Essi aspiravano a una maggiore autonomia di Firenze da Roma, limitando l’influenza del Papa nelle decisioni politiche e governative. I guelfi neri, invece, capeggiati dalla famiglia dei Donati, incarnavano gli interessi delle famiglie aristocratiche fiorentine, strettamente legate a Papa Bonifacio VIII per ragioni economiche e di potere. Essi erano disposti a concedere maggiore influenza al pontefice negli affari della città. Inizialmente, i bianchi sembrarono prevalere, ma nel 1301, con l’intervento delle truppe francesi guidate da Carlo di Valois, sostenitore di Bonifacio VIII, i neri presero il sopravvento. Questo evento segnò l’inizio dell’esilio per molti esponenti dei guelfi bianchi.
Dante Alighieri e l’esilio dei guelfi bianchi
Dante Alighieri, il sommo poeta autore della Divina Commedia, si schierò apertamente con i guelfi bianchi, difendendo l’autonomia politica di Firenze dal potere papale. Questa sua posizione ebbe conseguenze dirette sulla sua vita. Dopo una prima condanna per baratteria il 17 gennaio 1302, il 10 marzo dello stesso anno Dante fu condannato all’esilio e addirittura al rogo, rendendo di fatto il suo allontanamento da Firenze definitivo. Trascorse la prima parte dell’esilio tra Forlì, Verona e Treviso, per poi stabilirsi a Ravenna, ospitato da Guido Novello da Polenta, dove morì tra il 13 e il 14 settembre 1321. Per approfondire le vicende politiche del Sommo Poeta, puoi consultare la voce dedicata sull’Enciclopedia Treccani. L’esilio di Dante è uno degli eventi storici più famosi legati alle dinamiche tra guelfi bianchi e neri.
L’eredità storica del conflitto
La lotta tra guelfi bianchi e neri rappresenta un capitolo fondamentale della storia di Firenze e dell’Italia medievale. Questo conflitto non era solo una disputa per il potere, ma rifletteva profonde divergenze ideologiche e sociali che caratterizzarono l’epoca. Questa divisione influenzò non solo la politica, ma anche la cultura e la letteratura, come dimostra proprio l’esperienza di Dante. Le conseguenze di questa lotta si riverberarono sulla composizione sociale della città, con l’ascesa di nuove famiglie e il declino di altre. Comprendere la storia dei guelfi bianchi e neri è essenziale per capire il contesto storico in cui visse e operò Dante Alighieri e per apprezzare appieno la sua opera.
Articolo aggiornato il: 28/11/2025