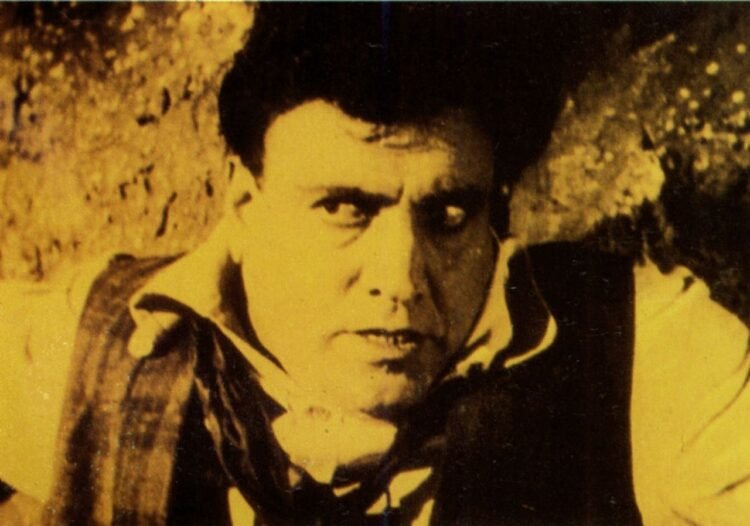Il termine “epifania” ha un significato profondo e multiforme, che si estende dalla sfera religiosa a quella letteraria. In letteratura, l’epifania rappresenta un momento di improvvisa rivelazione, un’illuminazione che permette a un personaggio (o al lettore) di comprendere una verità profonda sulla realtà, su se stesso o sul mondo circostante. Ma qual è l’origine di questo termine? E come è stato utilizzato da alcuni dei più grandi scrittori della letteratura, come James Joyce e Gabriele D’Annunzio?
Indice dei contenuti
L’Epifania a confronto: Joyce e D’Annunzio
| Contesto | Autore / Origine | Significato dell’Epifania |
|---|---|---|
| Religioso | Grecia Antica / Cristianesimo | Manifestazione diretta o indiretta di una divinità. |
| Letterario (Modernismo) | James Joyce | Improvvisa rivelazione spirituale scatenata da un gesto o un oggetto banale, che svela la paralisi interiore. |
| Letterario (Decadentismo) | Gabriele D’Annunzio | Manifestazione del divino nella natura e nell’arte (Panismo), unione tra uomo e mondo naturale. |
Che cos’è l’epifania: dal significato religioso a quello letterario
Il termine epifania deriva dal greco ἐπιϕάνεια (epiphàneia), che significa “manifestazione”, “apparizione”, “venuta”. Nell’antica Grecia, il termine era utilizzato in senso religioso per indicare la manifestazione di una divinità agli uomini, attraverso un segno, un sogno o una visione. Con l’avvento del cristianesimo, il termine ha assunto un nuovo significato, riferendosi alla festa che commemora la manifestazione di Gesù Cristo ai Magi. In letteratura, invece, il termine “epifania” indica un momento di improvvisa rivelazione, un’illuminazione che permette di comprendere una verità profonda sulla realtà, su se stessi o sul mondo. L’epifania letteraria può essere scatenata da un evento apparentemente banale, da un oggetto o una parola, che assumono improvvisamente un significato nuovo e inaspettato.
James Joyce e l’epifania come rivelazione del quotidiano
Il primo scrittore a utilizzare il termine “epifania” in senso letterario è stato l’irlandese James Joyce (1882-1941), uno dei più importanti autori del XX secolo, noto per la sua tecnica narrativa innovativa, lo stream of consciousness (flusso di coscienza). Joyce utilizza il concetto di epifania in particolare nella sua raccolta di racconti Dubliners (Gente di Dublino), pubblicata nel 1914. Nei racconti, Joyce descrive la vita quotidiana di personaggi comuni in una Dublino che l’autore percepisce come paralizzata e stagnante. I personaggi di Joyce sono spesso intrappolati in una routine monotona, incapaci di realizzare i propri sogni. L’epifania, in questo contesto, rappresenta un’improvvisa presa di coscienza della propria condizione, che può portare a un cambiamento o, più spesso, a una dolorosa consapevolezza.
Esempi di epifania in Gente di Dublino
Un esempio di epifania in Dubliners si trova nel racconto “Eveline“, in cui la protagonista, una giovane donna che sogna di fuggire da Dublino, all’ultimo momento, paralizzata dalla paura e dal senso del dovere, rinuncia alla sua fuga. Un altro esempio si trova nel racconto “The Dead” (“I morti”), in cui il protagonista, Gabriel Conroy, ha un’epifania sulla sua relazione con la moglie e sulla sua vita, dopo aver ascoltato una canzone che evoca un amore passato di lei.
Gabriele D’Annunzio e l’epifania come manifestazione del divino
Anche nella letteratura italiana, il termine è stato utilizzato con accezioni diverse. Gabriele D’Annunzio (1863-1938), uno dei maggiori esponenti del decadentismo, utilizza il termine “epifania” in senso religioso, ma anche per indicare la manifestazione del divino nella natura e nell’arte. Questo concetto è un chiaro esempio di panismo dannunziano, ovvero la tendenza a percepire la presenza del divino in ogni elemento naturale e a fondersi con esso.
L’epifania ne I Re Magi
Nella poesia I Re Magi, contenuta nella raccolta Alcyone (terzo libro delle Laudi), D’Annunzio descrive l’arrivo dei Magi a Betlemme. Nella poesia, la natura stessa sembra partecipare all’evento miracoloso, con una luce vermiglia che risplende nella notte e con i fiori che sbocciano come se fosse primavera. L’epifania, in D’Annunzio, è quindi una rivelazione della bellezza e della potenza della natura, con cui l’uomo può entrare in comunione attraverso l’arte. Ecco un estratto della poesia:
Una luce vermiglia
risplende nella pia
notte e si spande via
per miglia miglia e miglia.
Oh nova meraviglia!
Oh fiore di Maria!
Passa la melodia
e la terra si ingiglia.
L’importanza dell’epifania nella letteratura moderna
L’epifania, in letteratura, è un concetto chiave per comprendere la modernità e la crisi dell’individuo contemporaneo. Sia in Joyce che in D’Annunzio, pur con significati diversi, l’epifania rappresenta un momento di rottura, di rivelazione e di presa di coscienza, che può portare a una trasformazione o a una maggiore consapevolezza della propria condizione esistenziale. L’epifania è quindi un tema ricorrente nella letteratura del Novecento e continua a essere utilizzato da molti scrittori contemporanei.
Articolo aggiornato il: 29/12/2025