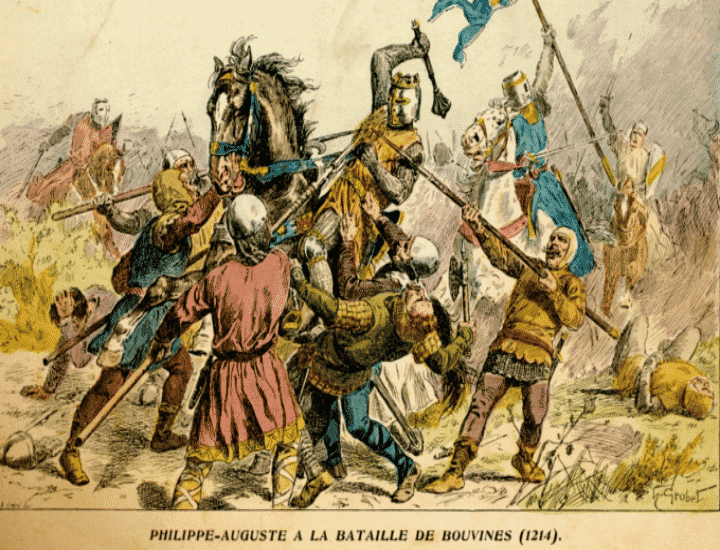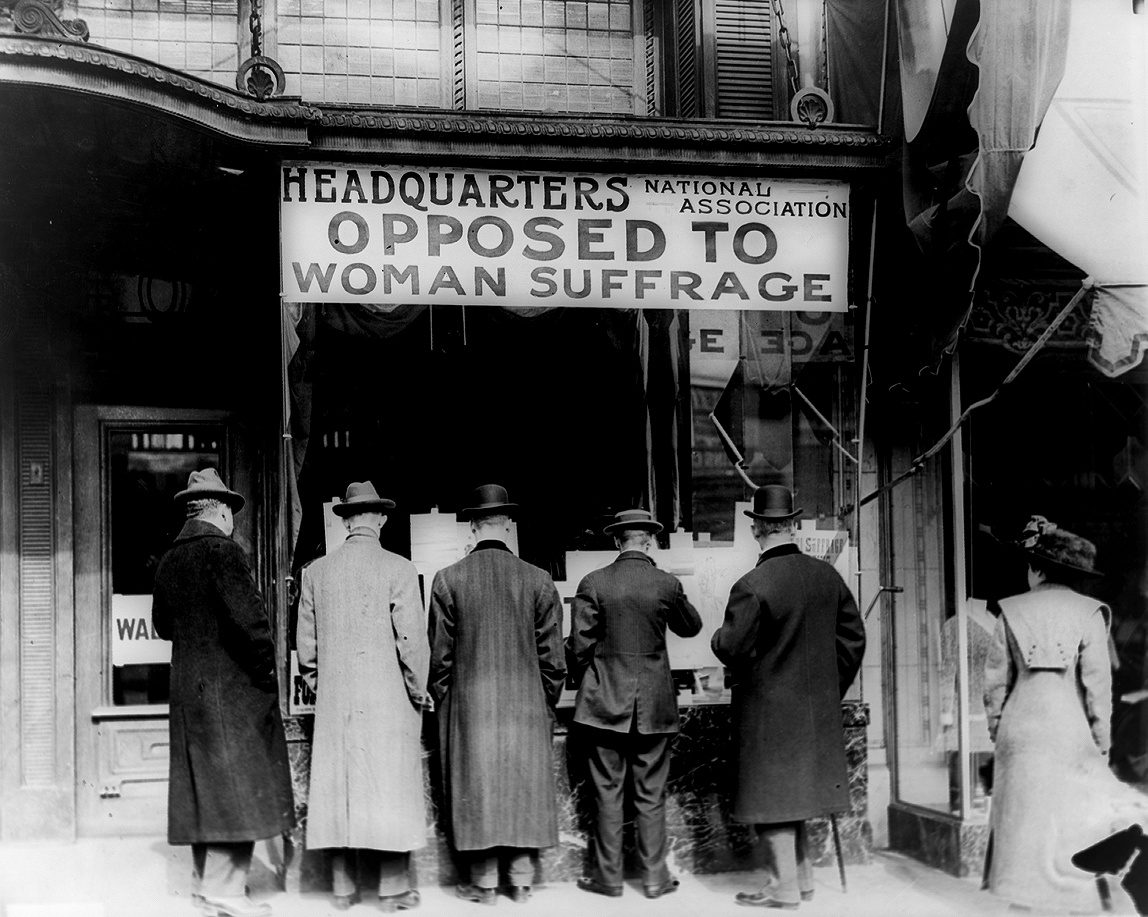I motti dannunziani sono espressioni coniate dal celebre poeta e politico Gabriele D’Annunzio, una figura che ha profondamente influenzato la cultura italiana tra il XIX e il XX secolo. Il suo impatto, definito dannunzianesimo, non si limitò alla letteratura, dove spiccano le opere in prosa più belle e concetti come il panismo, ma si estese alla lingua, alla politica e al costume. Oltre a introdurre parole nuove, D’Annunzio creò frasi e slogan che sono entrati nell’immaginario collettivo, spesso legati alle sue imprese militari e politiche, influenzando generazioni di intellettuali (come evidenziato nel confronto tra Pasolini e D’Annunzio).
Indice dei contenuti
Quali sono i motti dannunziani più famosi?
| Motto (Sentence case) | Significato | Contesto principale |
|---|---|---|
| Memento Audere Semper | Ricordati di osare sempre | Prima guerra mondiale (MAS) |
| Eia! Eia! Eia! Alalà! | Grido di guerra/esultanza | Prima guerra mondiale (aviazione) |
| Bis Pereo | Muoio due volte | Bombardamento di Pola (1918) |
| Cosa fatta capo ha | Un’azione compiuta è irreversibile | Impresa di Fiume (1919) |
| Hic manebimus optime | Qui staremo benissimo | Impresa di Fiume (1919) |
| A noi! | Grido di appartenenza degli Arditi | Prima guerra mondiale / Fiume |
| Me ne frego! | Sprezzo del pericolo e delle regole | Prima guerra mondiale / Fiume |
Non solo motti: i neologismi di D’Annunzio
Prima di analizzare i motti, è utile ricordare l’impatto di D’Annunzio sul lessico italiano. Fu lui a introdurre o popolarizzare parole e concetti ancora oggi in uso.
| Parola/Concetto | Contributo dannunziano |
|---|---|
| Automobile | Stabilì che il genere della parola dovesse essere femminile. |
| Tramezzino | Italianizzò la parola inglese “sandwich”. |
| Velivolo | Creò un termine poetico e tecnico per indicare l’aereo. |
| Milite Ignoto | Coniò l’espressione per onorare il soldato sconosciuto simbolo di tutti i caduti. |
Analisi dei motti dannunziani più famosi
Memento Audere Semper
Significato: “Ricordati di osare sempre“.
Origine e contesto: è il più celebre tra i motti dannunziani. D’Annunzio lo creò giocando con l’acronimo MAS, che indicava i Motoscafi Armati Siluranti della Regia Marina, da lui usati durante la Prima guerra mondiale. L’espressione divenne il simbolo del suo approccio eroico e audace alla vita e alla guerra, incarnando lo spirito degli incursori della Xª Flottiglia MAS.
Eia! Eia! Eia! Alalà!
Significato: grido di esultanza e combattimento.
Origine e contesto: D’Annunzio lo propose come grido di battaglia per i soldati italiani durante la Grande Guerra, per sostituire l'”Hip Hip Hurrà” di origine straniera. “Eia” è un’interiezione latina, mentre “Alalà” riprende un grido di guerra della Grecia omerica. Lo inserì nella Canzone del Quarnaro per celebrare la Beffa di Buccari e fu poi ampiamente adottato dal fascismo.
Me ne frego!
Significato: sprezzo del pericolo, indifferenza verso le conseguenze.
Origine e contesto: questo motto divenne famoso durante l’impresa di Fiume, ma la sua origine risale alla Prima guerra mondiale. La frase “Signor comandante io me ne frego” fu pronunciata da un soldato prima di una missione pericolosa durante la Battaglia del Solstizio sul Piave. D’Annunzio la sentì, la fece sua e la impresse sul distintivo dei legionari fiumani. Simboleggiava la totale dedizione alla causa, fino al sacrificio della vita.
Hic manebimus optime
Significato: “Qui staremo benissimo”.
Origine e contesto: D’Annunzio utilizzò questa frase, attribuita da Tito Livio a un centurione romano, durante l’occupazione di Fiume nel 1919. Con questo motto, intendeva comunicare la ferma intenzione dei suoi legionari di non abbandonare la città annessa all’Italia, sottolineando la legittimità e la durata della loro presenza, in aperta sfida alla gestione della cosiddetta vittoria mutilata.
Perché i motti dannunziani sono così importanti?
L’importanza dei motti dannunziani risiede nella loro capacità di sintetizzare un intero universo di valori: l’azione, l’audacia, il disprezzo per la mediocrità e un nazionalismo eroico. D’Annunzio fu un maestro della comunicazione e capì il potere degli slogan. Le sue frasi, brevi, musicali e cariche di storia, erano perfette per infiammare gli animi dei soldati e dei suoi seguaci. Molti di questi motti, nati in un contesto bellico o legati all’impresa di Fiume, furono poi ripresi e strumentalizzati dal regime fascista, che ne fece un elemento centrale della propria propaganda, legandoli indissolubilmente a quel periodo storico.
Fonte immagine: Wikimedia Commons
Articolo aggiornato il: 04 Febbraio 2026