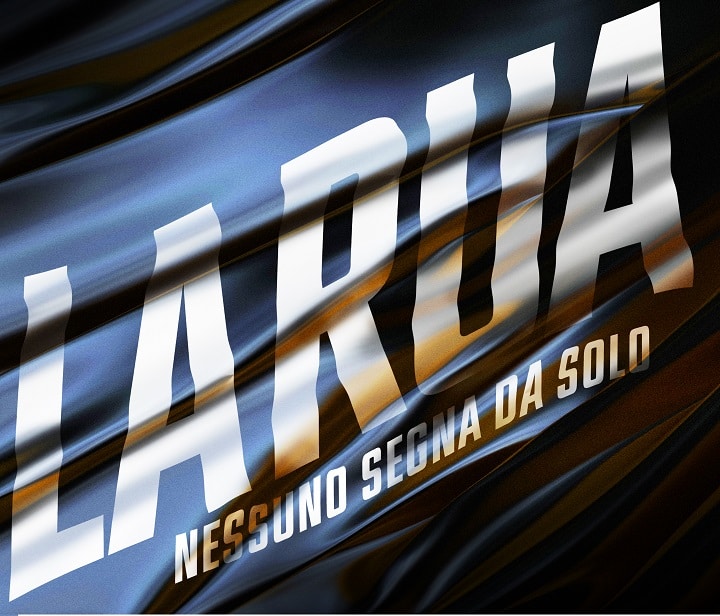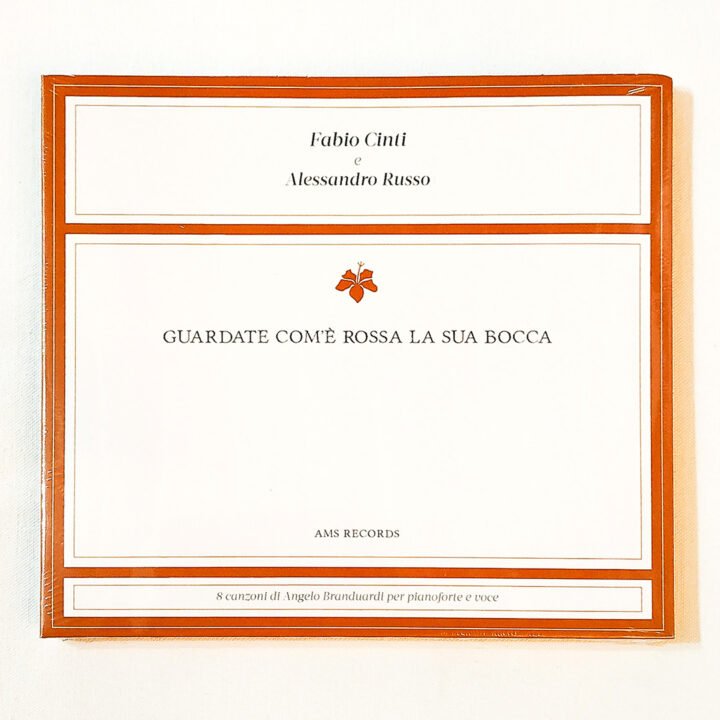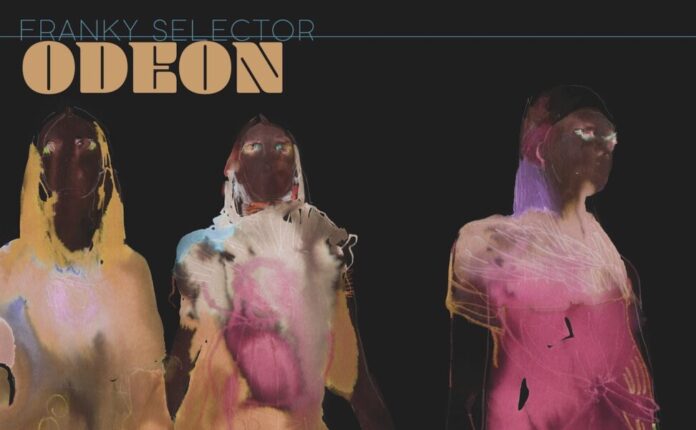“Siamo all’inizio e solo da qui si comincia” Daniele Incicco de La Rua
La Rua è un gruppo originario di Ascoli Piceno, fin dall’esordio discografico nel 2015 con l’omonimo album, la band capitanata da Daniele Incicco ha fatto delle esibizioni live il suo punto di forza, dando vita a spettacoli musicali di grande impatto
Lo scorso 26 Aprile, il gruppo ha pubblicato il suo terzo album “Nessuno vince mai da solo”, un lavoro targato Universal Music che conferma un sound folk solido e convincente, adornato con una veste pop di matrice radiofonica.
Nessuno segna da solo segue il precedente album Sotto Effetto Di Felicità ed è stato anticipato il 19 dicembre dal singolo Alla mia età si vola che può essere considerato un po’ come il ‘manifesto teorico’ del disco ma anche della carriera della band, sempre ‘on the road’ per suonare sui palchi di tutto il mondo.
“Non importa se in discesa o in salita/ o se stiamo rallentando da una vita/ l’importante è non fermarsi più//”
In queste parole tutta l’energia de La Rua che in questi anni ha freneticamente inanellato, una dopo l’altra, tantissime esperienze: dalla partecipazione ad Amici alle esibizioni sul palco del Primo Maggio nel 2015, nel 2017 e anche quest’anno; al recente tour intercontinentale del Sanremo Giovani World Tour un tour mondiale con i finalisti di Sanremo Giovani 2018 organizzato dalla Rai e dal MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); al collaborazione con Cristina D’Avena per la reinterpretazione di “È quasi magia Johnny!”; all’apertura del concerto degli Imagine Dragons nel 2013 a Milano.
Per l’occasione dell’uscita di Nessuno segna da solo, abbiamo intervistato Daniele Incicco, frontman della band, che ha condiviso con noi alcune delle tante esperienze de La Rua.
Intervista a Daniele Incicco, frontman de La Rua
Avete partecipato al concertone del Primo Maggio nel 2015, nel 2017 ed anche quest’anno. Cosa puoi dirmi di questo evento?
Il Primo Maggio è il palco più importante che c’è in Italia e salire in quel palco rende molto felici. È anche una prospettiva di lavoro molto diversa. Per noi era molto importante salire su quel palco anche per la mission che quel palco porta, ovvero andare a difendere i diritti dei lavoratori. Quindi in un certo senso ci siamo sentiti anche responsabilizzati doppiamente da quello che il Primo Maggio ci stava offrendo in quel momento.
Quindi pensi che riesca ancora a ricoprire questo ruolo il concerto del Primo Maggio?
Secondo me il ruolo lo ha sempre anche perché, in un certo senso, ci si mette al servizio del lavoro. Poi, lo si fa attraverso la musica, la musica è fatta di canzoni e le canzoni dicono tante altre cose, quindi non è molto facile trovare un brano che possa avere un messaggio che possa rappresentare quello. Noi abbiamo portato canzoni leggere ma con la presenza abbiamo cercato di giustificare il nostro appoggio a questo messaggio che il Primo Maggio dà.
Cosa mi puoi dire invece della vostra esperienza ad Amici?
È stato un passaggio importante della nostra carriera artistica dove abbiamo potuto studiare per un anno musica, ci siamo potuti apportare a un determinato tipo di lavorazione, di cover e brani inediti. Piano piano ci siamo adoperati per lavorare così pesantemente alle canzoni.
C’è un’opinione negativa e molto diffusa riguardo i talent che sono considerati la rovina della musica. Tu che li hai vissuti dall’interno, cosa ne pensi?
Chi è che fa i talent deve sapere quello che fa e quello a cui va incontro, deve avere già il percorso avviato e avanzato e deve sapere che deve andare lì e portare la propria musica e la propria personalità. Noi abbiamo cercato di farlo senza creare troppa tensione, senza creare polemiche per fare share o cose del genere. Quindi credo che è fatta in quella maniera, dove si mette la musica al centro non credo che possa creare problemi. Poi se lo si fa meramente per scopi televisivi, lì il discorso cambia.
Una delle maggiori critiche è che favoriscono gli interpreti a discapito degli autori, dunque viene meno la dimensione autoriale della musica.
Ma la musica italiana sta cambiando, ci sono dei progetti che partono dal niente e arrivano ovunque senza nemmeno l’apporto dei talent, quindi già questo ci fa capire in che periodo storico siamo e quale importanza viene data a chi scrive. L’unica cosa è che dovrebbe cambiare collettivamente la percezione, se uno fa un talent non vuol dire nulla, perché va a mettere la propria musica va in evidenza. Poi se quel progetto non vince, non vuol dire che non è un progetto valido.
Io non vedo i talent come una problematica, anzi, io vedo che hanno di nuovo tutti fame di nuova musica.
Mentre da poco avete concluso il Sanremo Giovani World Tour, in cosa consiste?
È stata una grande esperienza, è stato molto piacevole, abbiamo girato Tunisi, Sidney, Tokyo, Buenos Aires, Toronto, Barcellona, Bruxelles… è stato veramente mondiale. Ci siamo trovati a suonare a persone che non conoscevamo a culture diverse ed è stato molto formativo perché hanno accolto positivamente la nostra musica. Siamo stati felicissimi.
Avete anche reinterpretato “È quasi magia Johnny!” insieme a Cristina D’Avena.
Ci ha chiamato Cristina perché aveva bisogno di una band che avesse un certo tipo di suono, a lei piacevamo moltissimo e noi abbiamo risposto immediatamente presenti a questa chiamata. Non potevamo fare a meno di non rispondere in questa maniera. È stato amore a prima vista, l’arrangiamento lo abbiamo fatto in due giorni e Cristina è stata super felice di farlo diventare subito il brano che ha poi inserito nel disco (Duets, nda).
Parliamo invece del vostro ultimo album, come è nato?
È un album che porta due anni di lavorazione nei quali abbiamo cercato di portare dentro più brani possibili. Poi i ragazzi hanno lavorato alla produzione e hanno cercato di rispettare quella che era la personalità di ognuno di loro. Poi è arrivato il nostro produttore Dario Faini (Dardust, nda) con il quale abbiamo cercato di lavorare le canzoni e altrettanto Elisa Toffoli è intervenuta su alcuna di esse, ma è stato un lavoro collettivo comunque. Anche il titolo stesso già lo enuncia.
Che differenza c’è stata nella composizione di Nessuno vince da solo rispetto ai precedenti album?
C’è stato molto più lavoro, un lavoro fatto con molta più calma e tranquillità a differenza per esempio dell’album uscito dopo Amici (Sotto effetto di felicità, nda) che lo abbiamo dovuto fare in dieci giorni. Questo lo abbiamo fatto in due anni, è questa la differenza sostanziale
Dopo tre album e le tante esperienze fatte, che giudizio ti sentiresti di dare alla vostra carriera?
Siamo all’inizio e solo da qui si comincia. Ogni giorno lo vedo come una nuova partenza dove bisogna reinventarsi tutto e bisogna costruire ancora.
Qual è dunque l’obbiettivo?
L’obbiettivo è fare concerti sempre più grandi, con più pubblico e fare sempre più canzoni.
Ringraziamo Daniele Incicco de La Rua per la disponibilità.