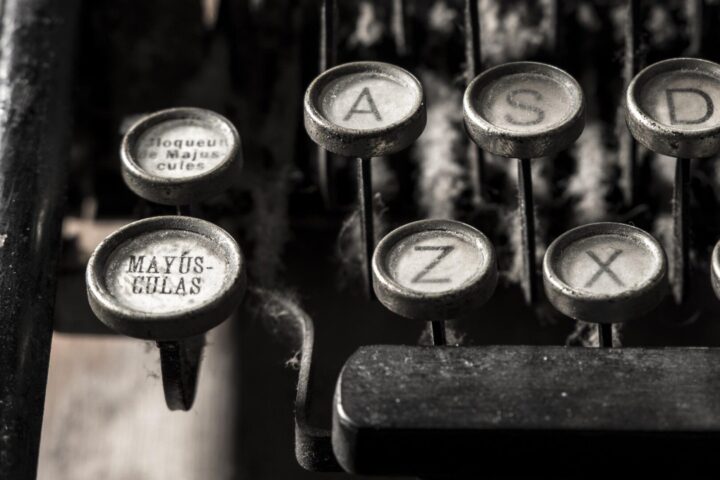Maria Luisa Spaziani (1922-2014) è stata una poetessa, traduttrice e aforista italiana, tra le figure letterarie più importanti del secondo Novecento. Innamorata della cultura francese e amica di Eugenio Montale, la sua poesia si distingue per un linguaggio limpido e musicale, ma capace di esplorare con profondità i temi dell’amore, del divino, della memoria e dell’indifferenza. Analizziamo sei delle sue poesie più belle.
In questo approfondimento:
Le 6 poesie in sintesi: un percorso tematico
| Poesia | Tema |
|---|---|
| Voce | Il divino nella natura e il mistero della creazione. |
| L’indifferenza | La responsabilità individuale e il rifiuto dell’apatia esistenziale. |
| Sono venuta a Parigi per dimenticarti | La memoria ossessiva dell’amore e l’impossibilità della dimenticanza. |
| La corolla del papavero | L’amore come trasfigurazione e sogno dal quale non ci si vuole svegliare. |
| Non sa, la barca, risalire il fiume | Il potere salvifico della parola di fronte allo scorrere inesorabile del tempo. |
| A sipario abbassato | La meraviglia che si nasconde nell’intimità e nei sogni dell’altro. |
Testo e analisi delle poesie più belle
1. Voce
Natale è un flauto d’alba, un fervore di radici
che in nome tuo sprigionano acuti ultrasuono.
Anche le stelle ascoltano, gli azzurrognoli soli
in eterno ubriachi di pura solitudine.
Perché questo Tu sei, piccolo Dio che nasci
e muori e poi rinasci sul cielo delle foglie:
una voce che smuove e turba anche il cristallo,
il mare, il sasso, il nulla inconsapevole.
Analisi: in questa poesia, il divino non è una figura astratta, ma una “voce” che pervade l’universo. Il Natale diventa il simbolo di un ciclo eterno di nascita e rinascita che si manifesta nella natura (“sul cielo delle foglie”). Questa voce divina è così potente da smuovere ogni elemento, dall’inerte (“il sasso”) all’inconsapevole (“il nulla”). È una visione panteistica in cui la divinità è una vibrazione sonora che dà vita a tutte le cose.
2. L’indifferenza
L’indifferenza è inferno senza fiamme,
ricordalo scegliendo fra mille tinte
il tuo fatale grigio.
Se il mondo è senza senso
tua solo è la colpa:
aspetta la tua impronta
questa palla di cera.
Analisi: la poesia è un potente monito contro l’apatia esistenziale. L’indifferenza è paragonata a un “inferno senza fiamme”, una condizione di non-vita. La seconda strofa introduce il tema della responsabilità individuale: il mondo è una “palla di cera” informe che attende di essere plasmata dall’azione di ognuno. Il senso del mondo non è dato, ma deve essere creato. Scegliere il “fatale grigio” dell’indifferenza è una colpa.
3. Sono venuta a Parigi per dimenticarti
Sono venuta a Parigi per dimenticarti
ma tu ostinato me ne intridi ogni spazio.
Sei la chimera orrida delle gronde di Notre-Dame,
sei l’angelo che invincibile sorride.
Veniamo a patti (il contadino e il diavolo):
lasciami il giorno per guardare, leggere,
sprecare il tempo, divertirmi, escluderti.
Notti e sogni, d’accordo, sono tuoi.
Analisi: la poesia descrive l’impossibilità di sfuggire alla memoria di un amore. Il tentativo di dimenticare a Parigi fallisce, perché la presenza dell’amato “intride ogni spazio”, trasformandosi sia in un mostro (“chimera orrida”) sia in una visione celestiale (“angelo invincibile”). L’unica soluzione è un ironico patto: la poetessa chiede di avere libero il giorno, concedendo all’ossessione amorosa il dominio della notte e dei sogni.
4. La corolla del papavero
Mi culla la corolla del papavero,
il mio sonno è lunghissimo. La strada
si agita laggiù da quattro ore.
Solo un tuo squillo potrebbe svegliarmi.
Non mi somiglia quest’inerzia, sono
da quando amo, tutt’altra persona.
Mi culli a lungo, mi culli il papavero,
se sarà lungo il mio sogno di te.
Analisi: l’amore è descritto come uno stato sognante e ipnotico, simile al sonno indotto dal papavero. La poetessa si sente trasformata (“sono tutt’altra persona”), immersa in un’inerzia dolce da cui non desidera essere svegliata, se non dalla voce dell’amato. Il mondo esterno (“la strada si agita”) è lontano. L’amore è un sogno volontario, un cullarsi nella propria trasfigurazione sentimentale.
5. Non sa, la barca, risalire il fiume
Non sa, la barca, risalire il fiume.
Nessun vento contrasta la rapida.
Felicità, gonfiavi le mie vele.
Ora smorte ricadono in lamenti.
Ma sarebbero ancora le parole
l’essenziale energia. Quel silenzio
che sempre è il limo fertile del verso,
ora è puro veleno.
Analisi: la poesia usa la metafora della barca che non può risalire la corrente per descrivere l’impossibilità di tornare a un passato felice. Le “vele smorte” simboleggiano la fine di un periodo gioioso. Di fronte a questo scorrere inesorabile, l’unica “essenziale energia” potrebbero essere le parole, la poesia. Ma il silenzio, un tempo fertile per la creazione, è diventato “puro veleno”, segno di un’aridità interiore.
6. A sipario abbassato
Quando ti amavo sognavo i tuoi sogni.
ti guardavo le palpebre dormire,
le ciglia in lieve tremito.
Talvolta
è a sipario abbassato che si snoda
con inauditi attori e luminarie
la meraviglia.
Analisi: in questa lirica, la vera “meraviglia” non si manifesta sulla scena pubblica della vita, ma nell’intimità, “a sipario abbassato”. La poetessa osserva l’amato dormire e immagina il mondo dei suoi sogni. È nel mondo interiore e nascosto dell’altro, inaccessibile alla vista, che si svolge lo spettacolo più straordinario, con “inauditi attori e luminarie”. L’amore diventa la capacità di intuire e partecipare a questo universo segreto.
Fonte immagine: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 27/08/2025