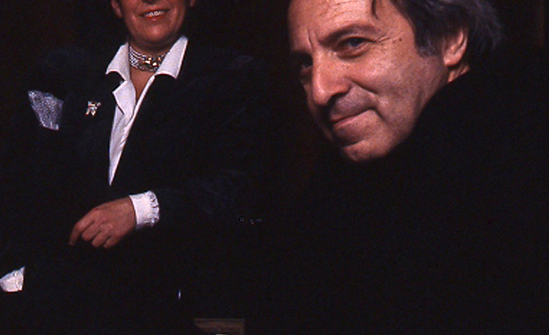Il teatro nacque nella Grecia antica come un vero e proprio rito civile, uno strumento pedagogico fondamentale per la vita della polis. Fin dalle sue origini nell’Attica (VIII-VII secolo a.C.), si distinse in due generi principali: la tragedia, che educava il cittadino attraverso i grandi miti, e la commedia, che rifletteva sulla vita quotidiana e criticava i costumi attraverso l’ironia. Il suo legame con la politica e il potere fu da subito profondo e complesso.
Indice dei contenuti
Il dibattito filosofico: Platone contro Aristotele
La funzione del teatro animò un acceso dibattito tra i due più grandi filosofi dell’antichità, con visioni diametralmente opposte.
| Platone: il teatro come elemento disgregatore | Aristotele: il teatro come funzione pedagogica |
|---|---|
| Sosteneva che il teatro suscitasse sentimenti irrazionali e incontrollabili, alimentando lo spirito di rivolta e minando l’autorità dello Stato. | Affermava che il teatro avesse un effetto purificatorio ed educativo. Suscitando emozioni come pietà e terrore, permetteva allo spettatore di liberarsene in un processo di catarsi. |
Teatro e democrazia: il theorikon di Pericle
Alla fine, prevalse la visione aristotelica. Il teatro divenne un evento collettivo a cui poteva partecipare gran parte della cittadinanza. Ai poeti spettava l’educazione degli adulti, così come ai maestri quella dei fanciulli. Per garantire che la sua funzione formativa fosse accessibile a tutti, nel V secolo a.C. Pericle istituì il theorikon: un fondo statale che rimborsava il biglietto ai cittadini meno abbienti, permettendo loro di partecipare agli spettacoli. Questo fondo, proveniente dalle eccedenze di bilancio, fu poi abolito da Demostene, che preferì destinare le risorse alle spese militari.
Il controllo politico: il ruolo dell’arconte e del corego
La messa in scena era strettamente legata alle istituzioni. L’arconte, il magistrato più importante, selezionava i poeti che avrebbero partecipato alle gare teatrali. Inoltre, sceglieva il corego, un cittadino ricco che si assumeva l’onere finanziario di allestire lo spettacolo, pagare il coro e gli attori. Poiché i cori erano le parti più dense di contenuto ideologico, la scelta combinata di poeta e finanziatore permetteva un controllo preventivo indiretto sui messaggi trasmessi al pubblico.
Esempi di teatro politico: da Frinico ad Aristofane
Un esempio eclatante dell’impatto del teatro sulla politica si ebbe nel 492 a.C. L’arconte Temistocle, convinto dell’imminenza di uno scontro con la Persia, scelse il poeta Frinico. La sua tragedia, “La presa di Mileto”, raccontava un evento recente e doloroso (la rivolta ionica) senza la consueta copertura mitologica. Il coinvolgimento emotivo del pubblico fu tale da causare disordini, e Frinico fu multato. Anche Euripide, pur essendo meno attratto dalla politica, svolse una funzione pedagogica attraverso l’agone verbale: i suoi dialoghi erano veri e propri dibattiti che insegnavano al pubblico l’arte della retorica, altrimenti accessibile solo ai ricchi allievi dei sofisti.
Nella commedia, Aristofane compiva attacchi diretti a esponenti politici dell’epoca. Nel 421 a.C., in pieno clima di speranza per la fine della Guerra del Peloponneso, inscenò “La pace” per sostenere la tregua appena firmata con la pace di Nicia, un ottimismo che purtroppo si rivelò illusorio.
L’eredità del teatro greco
Contrariamente a quanto temeva Platone, il teatro greco divenne una delle armi più potenti di aggregazione e un simbolo di democrazia partecipata. Sia la tragedia che la commedia, con la sua satira, educavano, criticavano e stimolavano il dibattito, formando i cittadini e rafforzando l’identità della polis.
Immagine di copertina: Pixabay
Articolo aggiornato il: 10/09/2025