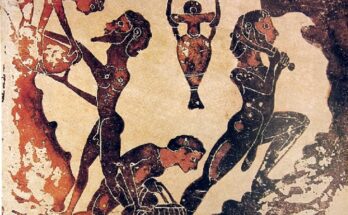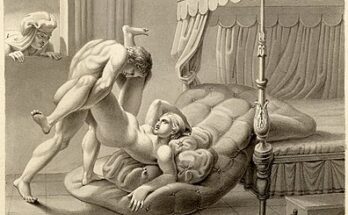Le città delle aree più dinamiche dell’Europa occidentale, a partire dalla seconda metà dell’XI secolo, furono protagoniste di un’originale esperienza politico-istituzionale di autogoverno: la formazione dei comuni. Questo fenomeno, che si sviluppò con tempi e modalità diverse, fu principalmente il risultato di tre fattori: l’indebolimento del potere centrale dell’imperatore; l’affrancamento del governo cittadino dalle autorità locali, come i vescovi; e la rinascita economica e culturale delle città, grazie all’attivismo dei ceti borghesi.
Indice degli argomenti
Le origini e la formazione dei comuni
Lo sviluppo dei comuni fu un fenomeno di respiro europeo, ma fu nell’Italia centro-settentrionale che la conquista delle autonomie cittadine assunse caratteri distintivi. Qui la vita urbana aveva mantenuto una certa vitalità anche durante l’Alto Medioevo e le istituzioni comunali mostrarono una durata eccezionale. Il Sud della penisola, invece, non fu interessato da questa esperienza, a causa della solida presenza della monarchia normanna che impedì lo sviluppo di poteri locali autonomi.
Tra l’XI e il XII secolo, l’autorità imperiale si indebolì a causa di conflitti interni e della lotta per le investiture contro il papato. Questo vuoto di potere favorì l’emergere di nuove forme di autogoverno nelle città. Inizialmente erano i vescovi a esercitare il potere, ma con la crescita economica, nuovi ceti sociali come mercanti e artigiani iniziarono a rivendicare maggiore autonomia, mettendo in discussione l’autorità vescovile.
La nascita del comune consolare in Italia
Tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo, i ceti urbani più influenti si organizzarono in libere associazioni private dette coniurationes. Si trattava di patti giurati per difendere i propri interessi e governare al di fuori del controllo imperiale o vescovile. A volte gli stessi imperatori riconobbero a queste associazioni ampie libertà, come armare un esercito, dichiarare guerra, coniare moneta e amministrare la giustizia, esautorando di fatto i vescovi.
Caratteristiche del comune consolare
Il primo secolo di storia dalla formazione dei comuni (fine XI – fine XII secolo) è definito età consolare. La principale magistratura era quella dei consoli: eletti dall’assemblea generale dei cittadini (l’arengo), restavano in carica per un periodo limitato (da sei mesi a un anno) per evitare l’instaurazione di un potere personale. Coadiuvati da un consiglio ristretto (il consiglio di credenza), i consoli amministravano la giustizia, mantenevano l’ordine pubblico e guidavano le milizie.
Dal comune consolare al comune podestarile
A godere di peso preponderante nel comune consolare era una ristretta oligarchia, composta principalmente dalla nobiltà feudale; per questo si parla anche di comune aristocratico. Le violente lotte tra fazioni rivali che si scatenarono al suo interno, tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, portarono il comune verso una nuova fase, quella del comune podestarile. Per porre fine ai conflitti, si decise di affidare il governo a una figura esterna e imparziale: il podestà, un professionista della politica che governava per un periodo limitato, solitamente un anno, applicando le leggi della città.
Le fasi del comune a confronto
| Fase Comunale | Caratteristiche principali |
|---|---|
| Comune Consolare (XI-XII sec.) | Governo affidato a consoli locali, eletti tra le famiglie aristocratiche. Caratterizzato da forti lotte interne tra fazioni. |
| Comune Podestarile (XIII sec.) | Governo affidato a un podestà, un magistrato forestiero chiamato per pacificare la città e garantire l’imparzialità della legge. |
La terza fase: il comune popolare
L’ascesa del podestà non placò del tutto le tensioni. Durante il XIII secolo, i ceti borghesi e artigiani, arricchitisi con i commerci e organizzati in corporazioni (le Arti), iniziarono a rivendicare un ruolo politico attivo. Questo ceto, noto come “popolo grasso”, si contrappose alla vecchia nobiltà, dando vita al comune popolare. In questa fase, alle istituzioni del podestà si affiancarono nuove figure, come il Capitano del Popolo, che difendeva gli interessi delle Arti, e il Consiglio degli Anziani, espressione del potere borghese.
L’eredità dei comuni: dove vederla oggi
L’esperienza dei comuni ha lasciato un’impronta indelebile nell’identità di molte città italiane. I palazzi comunali, le piazze e le torri che ancora oggi ammiriamo sono la testimonianza tangibile di quell’epoca di autogoverno e fermento culturale. Un esempio straordinario è Siena.
Un esempio da visitare: il Palazzo Pubblico di Siena
- Luogo: Palazzo Pubblico e Museo Civico
- Indirizzo: Piazza del Campo, 1 – 53100 Siena (SI)
- Cosa vedere: È uno dei massimi esempi di architettura gotica civile, costruito dal Governo dei Nove della Repubblica di Siena. Al suo interno, la Sala della Pace ospita il ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti sull’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo, una rappresentazione visiva perfetta degli ideali e delle paure della civiltà comunale.
- Sito Ufficiale: Pagina del Museo Civico
Foto immagine in evidenza: Wikipedia