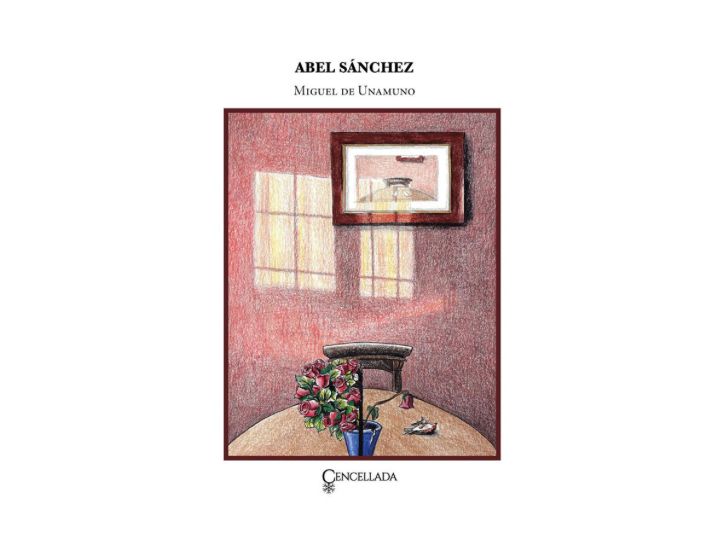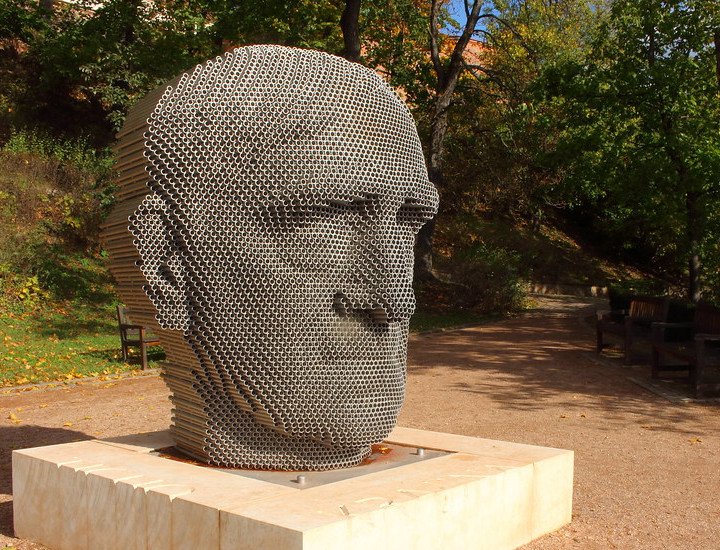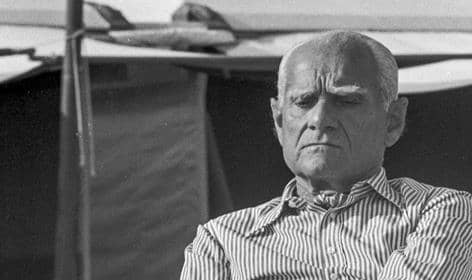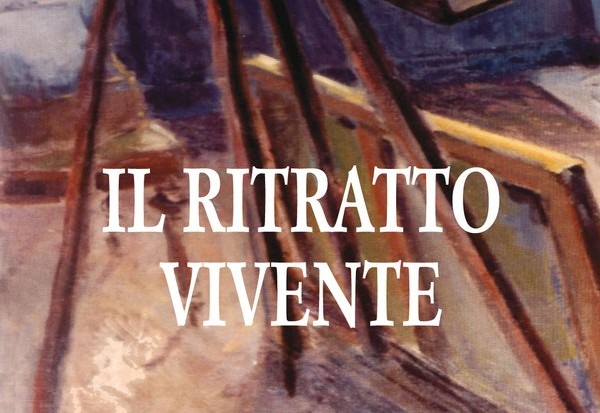La letteratura comparata è la disciplina che studia le relazioni tra opere letterarie di diverse culture, lingue e periodi storici. Come suggeriva il critico Remo Ceserani, il comparatista è un “signor dappertutto”, animato da un’inclinazione verso l’universale che lo porta a superare i confini tra le singole letterature nazionali e persino tra le discipline. Questa disciplina si fonda su un’idea fondamentale: un testo letterario esiste e acquista significato solo in rapporto ad altri testi, in un dialogo continuo che attraversa lo spazio e il tempo.
Indice dei contenuti
Definizione e campi d’azione della letteratura comparata
La letteratura comparata è una disciplina interdisciplinare, sovranazionale e trans-linguistica. Il suo scopo non è studiare una singola opera in isolamento, ma porla in relazione con altre, ricercando analogie, differenze, influenze e dialoghi. Come affermava Jean-Paul Sartre, un testo è come una trottola che ha bisogno del lettore per essere azionata; la comparatistica estende questo concetto, mostrando come un testo abbia bisogno di altri testi per rivelare la sua piena complessità. I suoi principali campi d’azione includono:
- La tematologia: lo studio di come temi e miti (es. il viaggio, l’eroe, l’amore impossibile) viaggiano e si trasformano attraverso diverse culture.
- Lo studio delle influenze: l’analisi dei rapporti di “debito” e “credito” tra autori e letterature (es. l’influenza di Shakespeare sul Romanticismo tedesco).
- L’imagologia: lo studio di come una cultura rappresenta l’immagine di un’altra nazione o popolo attraverso la letteratura.
- Lo studio dei generi letterari: l’analisi di come i generi (romanzo, poesia epica) si evolvono e si adattano in contesti diversi.
La storia della disciplina in quattro fasi
La letteratura comparata come disciplina accademica nasce a metà dell’Ottocento, in pieno Positivismo, ma le sue radici concettuali sono più antiche. La sua evoluzione può essere riassunta in quattro fasi principali.
| Fase e periodo storico | Scuola dominante e concetti chiave |
|---|---|
| Fase pionieristica (fine ‘700 – 1848) | Primi approcci cosmopoliti. Figura chiave: Goethe e il suo concetto di Weltliteratur (letteratura mondiale). |
| Fase positivista (1848 – 1945) | Scuola francese. Approccio storiografico ed eurocentrico. Ricerca di fonti, influenze e rapporti causa-effetto. Esponenti: Texte, Van Tieghem. |
| Crisi e rinnovamento (1945 – 1968) | Scuola americana. Critica al positivismo. Focus sull’analisi critica e teorica, superando i confini nazionali. Esponenti: Wellek, Remak. |
| Fase interculturale (dal 1968 in poi) | Apertura globale e interdisciplinare. Influenza dei Cultural Studies e del Postcolonialismo. Studio delle letterature non europee. |
Dalle origini alla crisi: le scuole francese e americana
Le origini della disciplina sono legate al concetto di Weltliteratur, o letteratura mondiale, teorizzato da Goethe. Dopo aver letto un romanzo cinese, egli comprese che l’epoca delle letterature nazionali stava finendo e che era necessario guardare a un orizzonte globale. Tuttavia, la disciplina si istituzionalizzò con la scuola francese, che adottò un metodo positivista: si cercavano scientificamente le fonti e le influenze tra letterature, in una prospettiva prevalentemente eurocentrica. Fu contro questo approccio che si scagliò Benedetto Croce, che definì tali ricerche meri esercizi di erudizione, privi di un vero giudizio estetico. La crisi di questo modello portò all’affermazione della scuola americana, con esponenti come René Wellek. Wellek sostenne la necessità di superare il paradigma storiografico per concentrarsi sull’analisi critica e teorica dei testi, liberando la comparazione da rigidi vincoli spaziali e temporali.
La letteratura comparata oggi: oltre l’eurocentrismo
A partire dagli anni ’70 e ’80, la letteratura comparata ha subito una profonda trasformazione, grazie all’influenza di correnti come i Cultural Studies e, soprattutto, i Postcolonial Studies. Studiosi come Edward Said hanno messo in discussione il canone letterario tradizionale, denunciandone l’eurocentrismo e aprendo lo studio a letterature e culture a lungo marginalizzate. Come definito dall’enciclopedia Treccani, oggi la disciplina si occupa delle dinamiche complesse di scambio culturale in un mondo globalizzato. La letteratura comparata, quindi, non è mai stata così rilevante: ci fornisce gli strumenti per comprendere l’alterità, per decostruire gli stereotipi e per riconoscere, nelle infinite differenze, gli elementi universali che uniscono l’esperienza umana, un concetto ben spiegato anche dall’enciclopedia Britannica.
Articolo aggiornato il: 03/10/2025