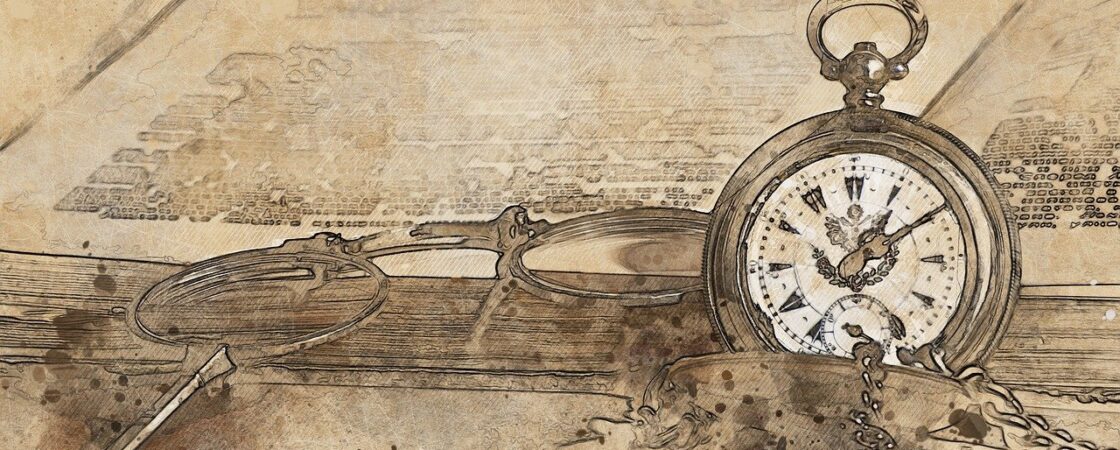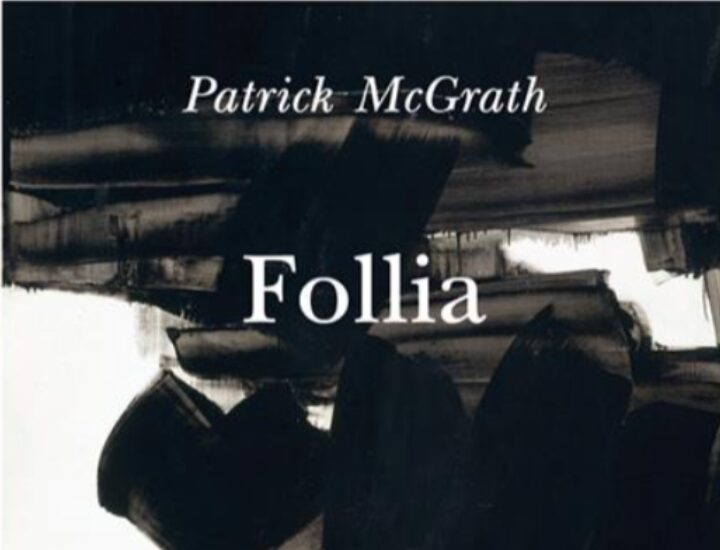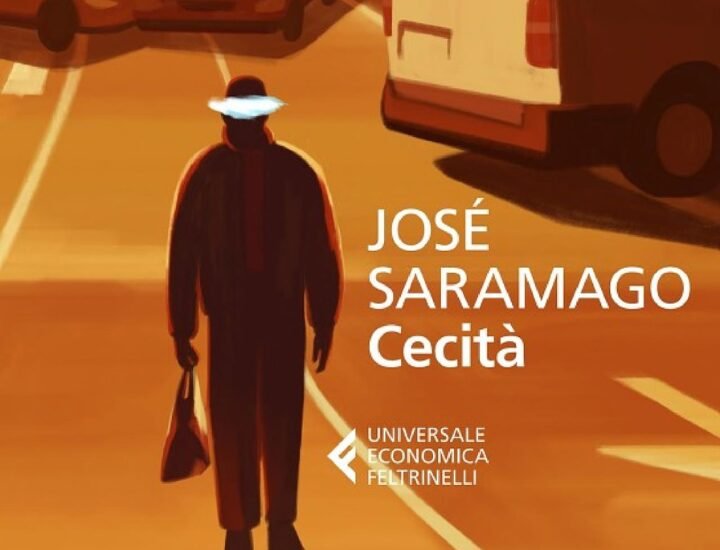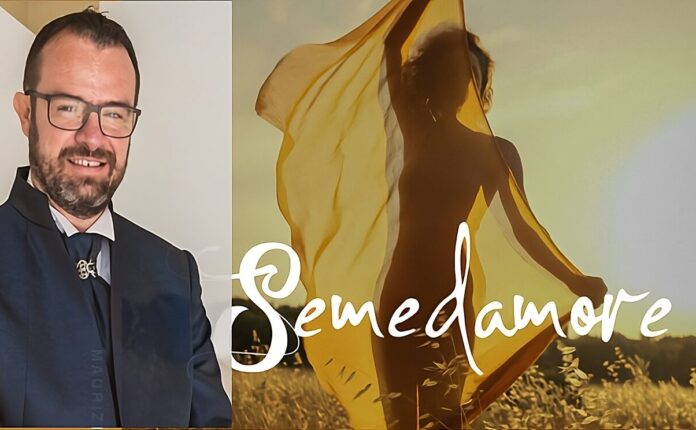Quante volte, leggendo un libro, si ha la sensazione di aver già incontrato una trama, un personaggio o uno stile simile? Si tratta di un dialogo intertestuale, un confronto tra opere in cui un modello viene ripreso e adattato, influenzando la letteratura successiva. In questo articolo analizzeremo i giochi metaletterari, esplorando le tecniche con cui gli autori dialogano tra loro attraverso il tempo, creando un testo potenzialmente infinito.
Indice dei contenuti
L’intertestualità: dal mito classico al testo infinito
Come sosteneva Calvino, sono soprattutto i classici a essere continuamente ripresi, vista la loro influenza. La metafora del testo come un tessuto, le cui trame si intrecciano, esiste da secoli. In Omero, Elena e Penelope tessono tele narrando le imprese degli eroi. Nelle Metamorfosi di Ovidio, Aracne tesse le storie degli dei. Ne Le mille e una notte, Sherazad è una tessitrice di racconti che prolungano il filo della sua vita, come le Parche. Fu Julia Kristeva a definire questo fenomeno come intertestualità, affermando che ogni opera è un “mosaico di citazioni” e che il testo è per sua natura aperto e infinito, arricchendosi di nuovi significati a ogni lettura. Un esempio lampante è Orlando, eroe della Chanson de Roland, che viene prima riscritto da Boiardo nell’Orlando Innamorato e poi trasformato da Ariosto nell’Orlando Furioso.
Le tecniche dei giochi metaletterari
Gli autori utilizzano diverse tecniche per creare questi dialoghi tra testi, manipolando i modelli preesistenti in modi creativi e spesso ironici.
| Tecnica metaletteraria | Esempio |
|---|---|
| Parodia / Appropriazione | Cervantes si appropria del cavaliere errante per creare Don Chisciotte, un eroe demitizzato e folle. |
| Manoscritto Fittizio (o Ritrovato) | Manzoni finge di aver trovato un manoscritto anonimo del Seicento da cui ha tratto la storia dei Promessi Sposi. |
| Autore come Personaggio | Paul Auster inserisce se stesso come personaggio all’interno della sua New York Trilogy. |
| Citazione e Allusione | Ariosto cita continuamente la tradizione cavalleresca, ma lo fa in chiave ironica per giocare con le aspettative del lettore. |
Parodia e appropriazione: riscrivere i classici
Una delle tecniche più comuni è la parodia. Il modello eroico di Orlando, ad esempio, viene demitizzato: i cavalieri di Ariosto non sono più eroi perfetti, ma umanissimi e pieni di debolezze. Questo processo è detto appropriazione: si prende un modello e lo si manipola per creare qualcosa di nuovo. Cervantes fa lo stesso nel costruire il suo Don Chisciotte, che incarna l’ideale del cavaliere ma in realtà è un povero vecchio impazzito per le troppe letture.
Il manoscritto fittizio: l’inganno dell’autore
Un altro celebre artificio è quello del manoscritto fittizio (o “ritrovato”). L’autore finge di non essere l’inventore della storia, ma un semplice trascrittore o traduttore. Manzoni lo fa con l’anonimo seicentesco da cui avrebbe tratto la storia dei Promessi Sposi. Cervantes attribuisce la storia di Don Chisciotte a un certo Cide Hamete Benengeli, mentre Ariosto incolpa un cronista di nome Turpino per le parti più inverosimili del suo poema. È un modo per giocare con il concetto di autorialità e di verità.
I giochi metaletterari nel postmoderno: Paul Auster
Nel postmoderno, l’intertestualità diventa quasi una “malattia endemica”: è impossibile scrivere senza dialogare con altri testi. Paul Auster, nella New York Trilogy, porta questo gioco alle estreme conseguenze. In Città di Vetro, l’investigatore Quinn viene ingaggiato per cercare un certo “Paul Auster”, che non è solo l’autore ma anche un personaggio del racconto stesso. In questi giochi labirintici, i ruoli di autore, narratore e personaggio si confondono, rendendo impossibile distinguere il vero dal falso.
Altre informazioni e curiosità sui giochi metaletterari
Cosa si intende esattamente per metaletteratura?
Per metaletteratura (o metanarrazione) si intende una scrittura che riflette su se stessa. È la letteratura che “parla di letteratura”. Un testo è metaletterario quando, invece di nascondere i propri meccanismi, li espone, attirando l’attenzione del lettore sul fatto che sta leggendo un’opera di finzione. Il manoscritto fittizio o l’autore che diventa personaggio sono esempi perfetti di questa tecnica.
Chi ha inventato il concetto di intertestualità?
Il termine “intertestualità” è stato coniato dalla critica letteraria e semiologa Julia Kristeva negli anni ’60. Basandosi sulle teorie del pensatore russo Michail Bachtin, Kristeva ha sostenuto che nessun testo è un’isola, ma è sempre un “mosaico di citazioni” di altri testi. Ogni opera assorbe e trasforma discorsi precedenti, creando un dialogo continuo nella cultura.
Qual è un famoso esempio di manoscritto ritrovato?
L’esempio più celebre nella letteratura italiana è l’introduzione de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. L’autore finge di aver trovato un vecchio manoscritto anonimo del Seicento e di essersi limitato a “tradurlo” in un italiano più moderno per i suoi lettori. Questo stratagemma gli permette di creare una distanza ironica dalla storia e di giocare con il concetto di fonte storica.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 04/09/2025