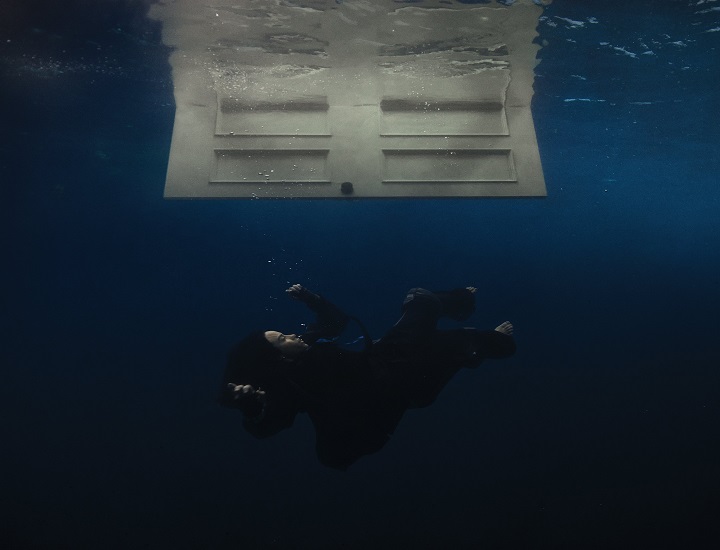Due anni di sperimentazioni, di chilometri e di incontri diventano oggi un punto di arrivo, una tappa obbligata e forse anche una ripartenza che ha lo stesso immaginario di un film girato in Super8. Dirlinger si ferma per un attimo, giusto il tempo di raccogliere le voci che abitano il suo primo album: “Contastorie” coccola in se otto canzoni come otto finestre su un Paese fragile e feroce, la provincia italiana in tutto il suo splendore, provincia che parla di fede e disillusione, di rabbia e poesia, di perbenismo e urgenza di libertà. C’è dentro la voglia di capire cosa resta, e cosa invece va lasciato andare. E che bello questo suono increspato come anche le belle tonalità seppia lungo tutto il viaggio…
Il “contastorie”… un po’ come il cantastorie, nome che ovviamente è radice del primo. Storie di cui tenere “conto”? Come nasce questo titolo?
Più che radice, direi che si tratta proprio di una storpiatura: prima dell’averle cantate, queste storie, è importante averle viste o sentite raccontare e averle “contate”, per poi metterle ordine in questa raccolta di canzoni.
E qui dunque torniamo al concetto di folk, di storytelling: quanto devi a questo tipo di traduzione? Cosa prendi dai padri del folk?
Devo tantissimo a quella tradizione: c’è proprio una grammatica della costruzione lirica (e musicale della canzone che ho interiorizzato fin da piccolo ascoltatore e dalla quale cerco di partire per andare a cercare fome nuove. Ma quello è il porto sicuro da cui parto e a cui torno volentieri: quello della forma canzone, del pop e del folk, che sono due termini meno distanti di quanto si possa credere.
E mutuando tutto questo nel futuro? Cosa diventa il folk e lo storytelling oggi?
Esattamente quello che era ieri, con l’aggiunta delle nuove sensibilità e dei suoni che partono lì. La tradizione sa essere inclusiva, stratificata e sfaccettata. La musica è bella perché rispecchia l’animo umano, che non è certamente bidimensionale, ma caleidoscopico.
Te lo chiedo perché questo disco sembra avere radici forti nel passato… vero?
C’è tanto cantautorato italiano e folk rock angloamericano dei tardi anni Sessanta e Settanta. Ma ci sono anche delle strutture o degli “ammiccamenti” verso l’indie o della canzone d’autore di qualche anno fa. Resta ovviamente predominante l’influenza della “vecchia guardia”.
E poi quel rock degli anni ’60-’70 americano torna nella viscosità dei suoni. Hai fatto un tipo di ricerca in tal senso?
No, in realtà è stato tutto molto naturale: l’idea era semplicemente quella di restituire l’effetto dell’avere davanti una band che suona. I suoni di basso e di chitarre semplici ma efficaci e le tastiere che richiamano a quei mondi musicali lì sicuramente aiutano a ricreare l’effetto desiderato.