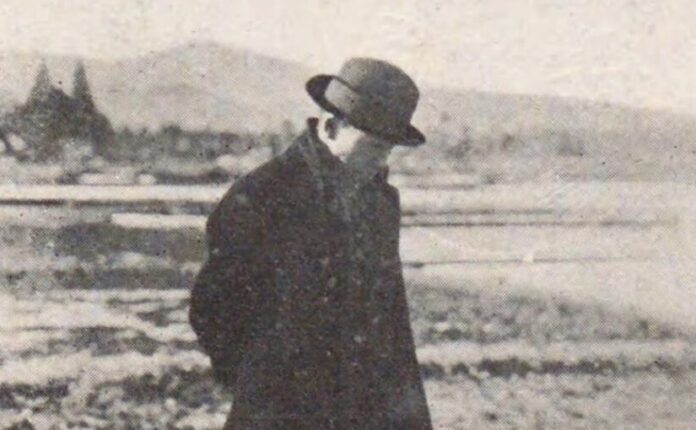Il ruolo degli intellettuali nella società è stato, ed è tuttora, oggetto di dibattito e di riflessione. Da sempre, ci si interroga su quale sia la funzione di coloro che, per formazione, cultura e sensibilità, sono chiamati a interpretare il mondo, a criticarlo e a proporre nuove visioni. Qual è la responsabilità degli intellettuali nei confronti del potere, della verità, della giustizia? E quale ruolo possono svolgere in un’epoca complessa e frammentata come la nostra?
Indice dei contenuti
Il ruolo degli intellettuali nella storia: un percorso evolutivo
Il dibattito sul ruolo degli intellettuali ha radici antiche e ha attraversato i secoli, assumendo forme e significati diversi. Già Platone, nella sua Repubblica, auspicava un governo guidato dai filosofi, unici in grado di guidare la società verso la giustizia. Il rapporto con il potere è sempre stato complesso: Seneca, precettore di Nerone, cercò di influenzare l’imperatore, ma fu accusato di collusione. Secoli dopo, Machiavelli, con Il Principe, fornì una visione realistica del potere, mentre Dante Alighieri testimoniò con la sua vita l’impegno civile dell’intellettuale.
L’evoluzione della figura dell’intellettuale
La funzione dell’intellettuale si è trasformata nel tempo, come riassunto in questa tabella.
| Periodo / Pensatore | Concetto chiave del ruolo dell’intellettuale |
|---|---|
| Platone | Il filosofo-re, che governa grazie alla sua conoscenza del vero e del bene. |
| Émile Zola | L’intellettuale come coscienza critica della nazione, che interviene pubblicamente per difendere la verità (j’accuse). |
| Jean-Paul Sartre | L’engagement: l’impegno politico e sociale come dovere esistenziale. |
| Antonio Gramsci | L’intellettuale organico, legato a una classe sociale per costruirne l’egemonia culturale. |
| Michel Foucault | L’intellettuale specifico, che critica il potere a partire dal proprio campo di sapere. |
| Noam Chomsky | La responsabilità di dire la verità al potere e smascherare la propaganda. |
Il novecento e la nascita dell’intellettuale moderno
La figura dell’intellettuale moderno nasce simbolicamente alla fine dell’Ottocento con l’Affaire Dreyfus. Émile Zola, con il suo celebre J’accuse in difesa dell’ufficiale ebreo Alfred Dreyfus, come documentato da fonti autorevoli quali l’Enciclopedia Britannica, dimostrò il potere della parola nella denuncia delle ingiustizie. Nel Novecento, Jean-Paul Sartre teorizzò l’engagement, l’impegno nella vita politica e sociale. In Italia, Antonio Gramsci elaborò il concetto di “intellettuale organico“, colui che, legato a una classe sociale, ne elabora la visione del mondo. Gramsci lo contrapponeva all'”intellettuale tradizionale“, che si percepisce come autonomo e al di sopra delle parti, una posizione che secondo il filosofo mascherava un’adesione implicita all’ordine esistente, come approfondito dall’Enciclopedia Treccani. Successivamente, Michel Foucault introdusse la figura dell'”intellettuale specifico”, che non parla più a nome dell’universale, ma lotta contro le forme di potere nel suo specifico settore di competenza.
Prospettive contemporanee: da Chomsky a Lévy
Noam Chomsky, in I nuovi mandarini, critica gli intellettuali asserviti al potere che contribuiscono alla “fabbrica del consenso”. Per Chomsky, essi hanno la responsabilità morale di dire la verità e smascherare le menzogne dei governi. Bernard-Henri Lévy, in L’elogio degli intellettuali, affronta la complessità del ruolo odierno, riconoscendo la crisi di autorevolezza ma invitando a difendere la ragione contro l’irrazionalismo.
Le sfide degli intellettuali nel mondo contemporaneo
Nel mondo contemporaneo, caratterizzato dalla frammentazione del sapere e dalla crisi dei valori, gli intellettuali sembrano aver perso la loro autorevolezza. La crescente specializzazione e il dominio della tecnocrazia rendono difficile un’interpretazione complessiva della società. Dire la verità al potere, come auspicato da Chomsky, è un compito arduo che può portare all’emarginazione, come dimostra il caso di Pasolini. Riprendendo la distinzione di Umberto Eco tra apocalittici e integrati, gli intellettuali oggi dovrebbero forse cercare di coniugare le due attitudini: essere competenti sulle nuove sfide (integrati), ma anche capaci di demistificare le narrazioni dominanti (apocalittici).
Quale futuro per gli intellettuali?
Nonostante le difficoltà, il ruolo degli intellettuali rimane fondamentale. Come scriveva Gore Vidal, sono come i “canarini nella miniera”: la loro voce critica è essenziale per individuare i pericoli della società. Forse, come suggeriva Franco Fortini in Extrema ratio, dovrebbero rivolgere la loro attenzione alle periferie e agli esclusi. O forse, come auspicava Nanni Balestrini, dovrebbero tornare a fare gruppo. In ogni caso, il loro compito rimane quello di analizzare la realtà, stimolare il dibattito e contribuire a una società più giusta e consapevole.
Per saperne di più sulla concezione di Chomsky riguardo al potere vi consigliamo di guardare questo video: Le 10 regole del potere.
Fonte immagine: Pexels
Articolo aggiornato il: 16/09/2025