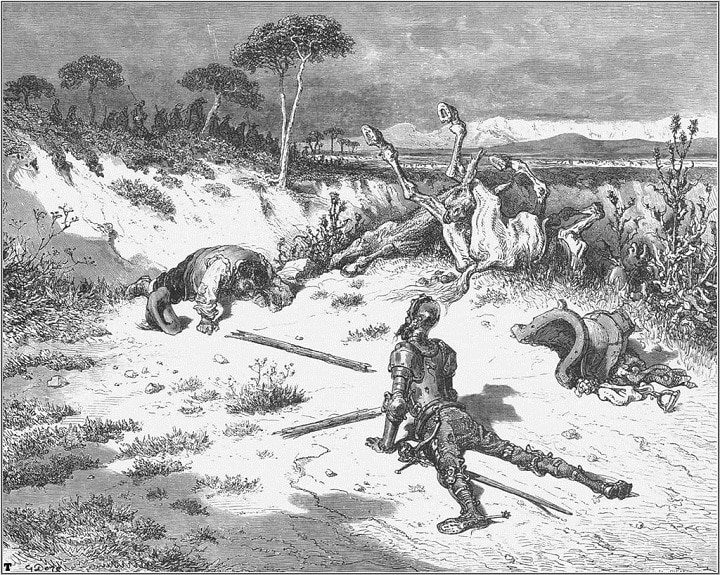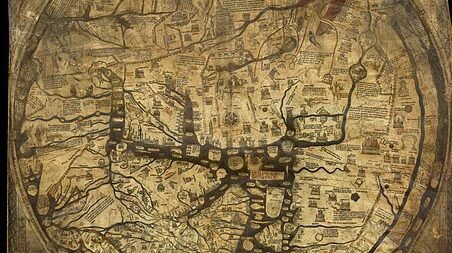Quando si parla di campi di concentramento, l’immaginario collettivo corre subito alla Germania nazista e ai nomi di Dachau o Auschwitz. In pochi sanno, però, che anche l’Italia ebbe una propria fitta rete di campi di internamento. Si trattava di strutture carcerarie, spesso ricavate da edifici preesistenti come ville o fabbriche, destinate alla detenzione di individui considerati una minaccia per il regime fascista. Sebbene con differenze sostanziali rispetto ai lager di sterminio tedeschi, questi luoghi rappresentano una pagina oscura della nostra storia, il cui obiettivo primario non fu l’annientamento sistematico, ma il controllo, la repressione e la “purificazione” della società.
Indice dei contenuti
- L’evoluzione storica: dal domicilio coatto all’internamento fascista
- Le tipologie dei campi di internamento italiani
- I campi per internati civili del Ministero dell’interno
- I campi del Regio esercito per prigionieri di guerra
- I campi di smistamento della Repubblica sociale: l’anticamera dei lager
- La fine dei campi e la memoria costituzionale
L’evoluzione storica: dal domicilio coatto all’internamento fascista
Sul territorio italiano, l’allontanamento di elementi sgraditi era una pratica già in uso. Dal 1863, per contrastare il brigantaggio, si utilizzava il domicilio coatto, uno strumento per deportare individui ritenuti pericolosi. Con le leggi fascistissime del 1926, questo strumento si evolse nel confino di polizia, usato sistematicamente contro gli oppositori politici. La vera svolta avvenne con lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Dal giugno 1940, il regime trasformò questa prassi nell’internamento civile, un provvedimento amministrativo che non richiedeva un processo e portò alla creazione di decine di campi di internamento in Italia. In queste strutture vennero rinchiusi dissidenti, popolazioni delle colonie e stranieri “nemici”: ebrei, sloveni, croati, rom, greci e molti altri.
| Tipologia di campo e periodo | Funzione principale ed esempio chiave |
|---|---|
| Campo di internamento civile (1940-1943) | Controllo e detenzione di civili “nemici” (ebrei stranieri, antifascisti). Esempio: Ferramonti di Tarsia. |
| Campo per prigionieri di guerra (1940-1943) | Detenzione di militari nemici e civili slavi in condizioni durissime. Esempio: Gonars. |
| Campo di transito e smistamento (1943-1945) | Raduno di ebrei e politici per la deportazione verso i lager nazisti. Esempio: Fossoli. |
| Campo di sterminio (1943-1945) | Detenzione, tortura ed eliminazione sistematica dei prigionieri. Unico esempio: Risiera di San Sabba. |
Le tipologie dei campi di internamento italiani
I campi sul suolo italiano, dislocati soprattutto nel centro-sud, non erano tutti uguali. Si distinguevano principalmente per l’autorità di gestione e per la popolazione reclusa.
I campi per internati civili del ministero dell’interno
Questi campi erano destinati a internati civili di guerra, come ebrei stranieri e antifascisti. Le condizioni di vita, pur durissime, non prevedevano la violenza e lo sterminio sistematico dei lager nazisti. Il più grande fu quello di Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza. Malgrado sovraffollamento, malnutrizione e malattie, la mortalità fu contenuta e legata alle precarie condizioni igienico-sanitarie. All’interno si sviluppò persino una forma di vita comunitaria, con scuole e sinagoghe.
I campi del regio esercito per prigionieri di guerra
Ben diverse erano le condizioni nei campi gestiti dal Regio esercito, che accoglievano prigionieri di guerra e civili deportati, soprattutto jugoslavi. Qui il regime detentivo era estremamente rigido, con un tasso di mortalità molto elevato. Il più noto fu il campo di Gonars, in provincia di Udine, dove in circa un anno morirono centinaia di prigionieri sloveni e croati a causa di fame, freddo e malattie. Pur senza un piano di sterminio esplicito, le condizioni imposte portavano a una morte quasi certa.
I campi di smistamento della repubblica sociale: l’anticamera dei lager
Con la caduta di Mussolini nel 1943 e la nascita della Repubblica sociale italiana, la funzione di alcuni campi cambiò drasticamente. Divennero campi di smistamento (Polizei- und Durchgangslager), gestiti in collaborazione con i nazisti. Il loro scopo era radunare gli ebrei per consegnarli ai tedeschi, che li avrebbero deportati verso i campi di sterminio, principalmente Auschwitz. I più importanti, come documentato dalla Fondazione Fossoli, furono quelli di Fossoli (Modena), da cui passò Primo Levi, e Bolzano-Gries. A questi si aggiunge l’unico vero campo di sterminio italiano, la Risiera di San Sabba a Trieste, dotato di un forno crematorio.
La fine dei campi e la memoria costituzionale
Dopo la Liberazione, i campi di internamento vennero smantellati. L’esperienza tragica lasciò un segno profondo, tanto che i padri costituenti vollero cancellare quella giustizia sommaria dall’ordinamento. Nella Costituzione della Repubblica italiana del 1948, in particolare nell’articolo 13, si sancì il principio che nessuna persona può essere privata della libertà se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Misure come il confino e l’internamento amministrativo vennero così rimosse, una lezione nata dalle ceneri di una delle pagine più buie della nazione.
Fonte immagine: Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia – Wikipedia
Articolo aggiornato il: 21/09/2025