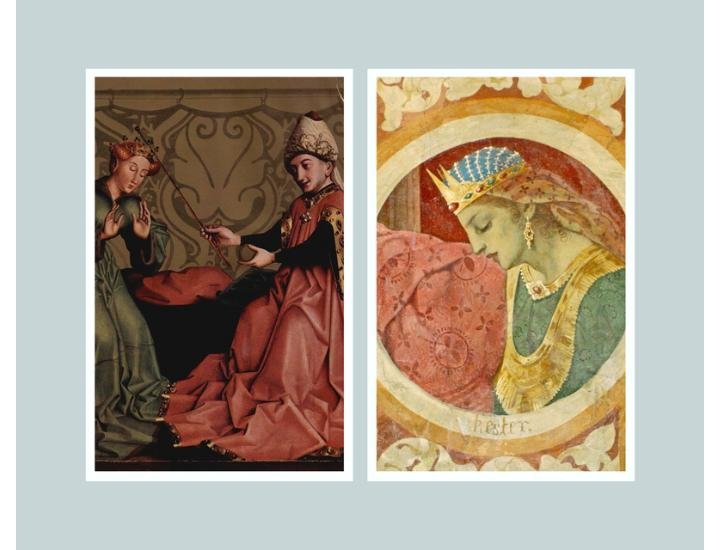I bunjin (文人) sono stati gli “uomini di lettere” del Giappone del periodo Tokugawa, intellettuali e artisti che scelsero una vita dedicata al sapere e all’espressione estetica al di fuori dei rigidi schemi professionali e politici. Il termine, derivato dal cinese “wenren“, non identifica semplicemente un “letterato”, ma delinea una precisa condizione esistenziale basata sulla versatilità artistica e sul distacco dalle ambizioni mondane.
Indice dei contenuti
Bunjin come stile di vita
Le personalità definite bunjin condividono caratteristiche peculiari che riflettono un innovativo modo di concepire se stessi e il mondo, in un contesto sociale che avvertiva i primi segnali di cambiamento. La loro identità si fondava su un’eccezionale versatilità. Un vero bunjin padroneggiava le cosiddette “Quattro Arti” di matrice cinese (琴棋書画, kin-ki-sho-ga): la musica, il gioco strategico del Go, la calligrafia e, soprattutto, la pittura. Proprio in ambito pittorico, essi diedero vita alla corrente nota come Bunjinga (文人画), o scuola Nanga (南画), che privilegiava l’espressione interiore e la spontaneità rispetto all’accademismo formale, come evidenziato da fonti autorevoli come l’enciclopedia Britannica. Figure come Yosa Buson (与謝蕪村) e Ike no Taiga (池大雅) sono esempi perfetti di questa poliedricità, essendo stati maestri sia nella pittura sia nella poesia haiku.
Questo eclettismo si traduceva in una scrittura più leggera, ricca di humor e satira, e talvolta di un benefico pizzico di cinismo. Tale approccio segnava un allontanamento dai dogmatici precetti confuciani su cui si fondava lo shogunato, come osserva Adriana Boscaro ne “La narrativa giapponese classica“. Un altro elemento cardine era la costante ricerca dello stile e dell’eleganza, che implicava un netto disprezzo per lo “zoku” (俗): la grossolanità, la volgarità. La dialettica tra la categoria del “ga” (雅), l’alto e il raffinato, e lo “zoku“, il basso e plebeo, alimentava una continua ricerca estetica. Era un’arte fine a se stessa, o, per usare le parole del poeta Matsuo Bashō (松尾 芭蕉), un’«arte come forno d’estate e ventaglio d’inverno».
Il bunjin non era interessato a integrarsi nel tessuto sociale a lui contemporaneo. La sua predilezione per una vita in solitudine non va confusa con il distacco ascetico della “letteratura di romitaggio” di Kamo no Chōmei o Kenkō Hōshi. Per il bunjin, la solitudine rappresentava un allontanamento ideologico e politico, non necessariamente fisico. All’etica del dovere civile si sostituiva l’idealismo, un distacco dalla materialità e dalla brama di guadagno, ispirato a principi di matrice taoista.
I principi e le arti dell’ideale bunjin
| Principio o arte | Descrizione e significato per il bunjin |
|---|---|
| Versatilità (le quattro arti) | Padronanza di pittura (bunjinga), calligrafia (shodō), musica (koto o qin) e go come espressione di un intelletto completo. |
| Idealismo e distacco | Rifiuto delle carriere ufficiali e della ricerca del profitto materiale per dedicarsi a una vita di arricchimento spirituale e artistico. |
| Ricerca del “ga” (雅) | Perseguimento della raffinatezza, dell’eleganza e della grazia in ogni aspetto della vita, in contrapposizione allo “zoku” (la volgarità). |
| Individualismo | L’arte come veicolo per l’espressione personale e soggettiva, piuttosto che come servizio a un potere politico o religioso. |
L’influenza cinese e l’apertura culturale
Durante il periodo di auto-isolamento del Giappone, noto come “sakoku” (鎖国), le riforme dell’era Kyōhō (享保), nei primi decenni del 1700, allentarono parzialmente le restrizioni sull’importazione di libri dall’estero, in particolare dalla Cina. Questo evento, come documentato da numerosi studi storici tra cui quelli dell’associazione AISTUGIA (Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi), fu fondamentale per la cultura bunjin. Oltre alle opere in cinese classico, iniziarono a circolare anche opere popolari in vernacolare, di genere fantastico. Particolare seguito ebbero le storie sui fantasmi. Il filosofo Ogyū Sorai (荻生 徂徠) rese rilevante lo studio del cinese parlato, fondando una scuola dove utilizzava proprio queste storie per l’insegnamento. Allo stesso modo, Asai Ryōi (浅井 了意), figura legata al genere letterario dell’ukiyo-zōshi (浮世草子), inserì nella sua raccolta Otogibōko (1666) adattamenti di racconti cinesi.
Questa influenza non si limitò alla letteratura. I bunjin adottarono anche pratiche culturali come il Senchadō (煎茶道), la “via del tè in foglie”, che si distingueva dalla più formale e ritualizzata cerimonia del tè (*Chanoyu*) legata alla classe guerriera. Il Senchadō, con la sua enfasi sulla semplicità e sull’apprezzamento intellettuale del tè, si allineava perfettamente con l’estetica e l’anticonformismo degli uomini di lettere.
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 27/09/2025