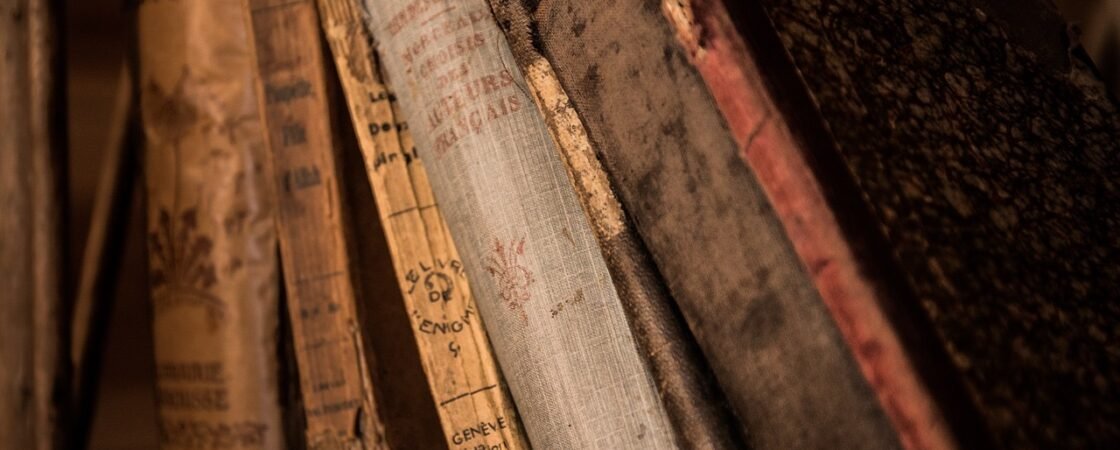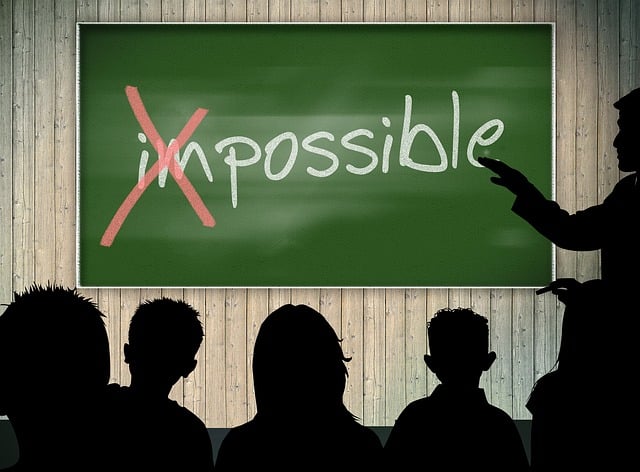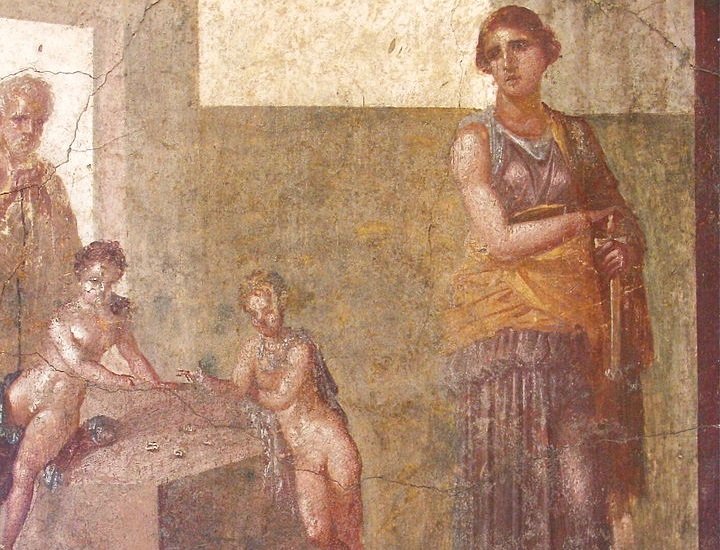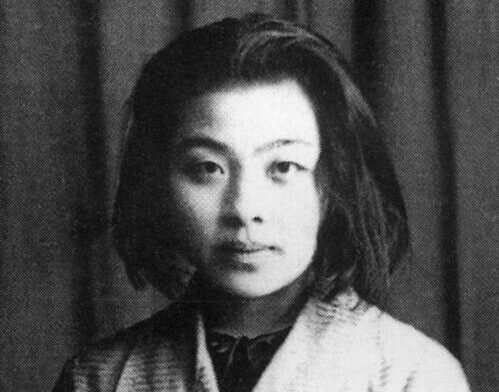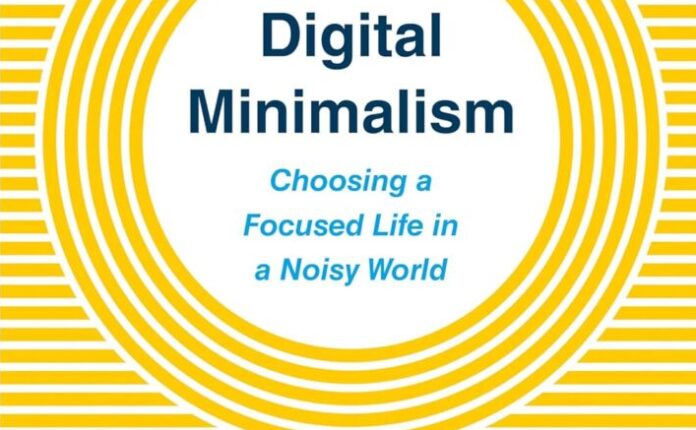Il Master di Bellantrae è un romanzo scritto da Robert Louis Stevenson e pubblicato nel 1888. La trama del libro ruota intorno al conflitto fra due fratelli, nobili scozzesi, la cui famiglia viene smembrata dall’insurrezione giacobita del 1745. È un’opera poligenerica e polimodale in cui Stevenson si basa su un complessivo di cinque modelli eterogenei:
- Il mito e il modo epico, che plasmano sia la base del romanzo che il suo ambiguo e grandioso protagonista.
- Il modo tragico, declinato nei vari motivi del fato, dei presagi nefasti, del conflitto insanabile.
- Il romanzo storico, che declina la situazione sociopolitica sottesa alla vicenda, dalla rivolta giacobita alla Guerra dei Sette Anni (1745-1763).
- Il modo romanzesco, nelle mirabolanti vicende del protagonista.
- Il romanzo psicologico, conflitto tra fratelli, dinamiche familiari ambigue e spesso deleterie.
Tutti questi materiali eterogenei vengono integrati in un complesso narrativo omogeneo presentato da un curatore, il quale pare sia stato messo al corrente della vicenda da un amico. L’intero incipit avviene in un continuo e dinamico shift tra prima e terza persona e viene usato l’espediente del documento ritrovato; in questo caso, le carte di un certo Mackellar, ritrovate da un curatore e poi pubblicate ben cent’anni dopo. Mackellar è una sorta di protagonista subordinato, abusivo. Tuttavia, lui è il narratore stesso dell’opera e chiede al lettore di sottoscrivere un patto narrativo, chiedendogli di dargli fiducia e credere alla sua versione dei fatti, in quanto lui è stato un testimone oculare delle vicende che sta per raccontare. A questo punto tratteggia la storia di questa famiglia scozzese.
Presentazione del nucleo familiare de Il Master di Bellantrae
Il nucleo familiare è composto dal padre, dai due figli (James, dissoluto e violento, e Henry/Lord Dirrisdeer, ombroso e appartato) e Alison, futura moglie di James; l’equilibrio viene sconvolto dallo sbarco nelle Ebridi di Charles Stuart, poiché la famiglia non sa se schierarsi o meno con lui.
Il padre stabilisce che ognuno dei figli stia con una fazione, Henry con la corona e James coi rivoltosi. Si nota sin da subito l’ambiguità: benché Mackellar all’inizio si professi testimone oculare, tutto questo è successo prima che egli conoscesse la famiglia, quindi tutto ciò che narra non è una testimonianza diretta ma è una ricostruzione compiuta attraverso deduzioni, racconti altrui. Siamo nel campo di quella che i narratologi chiamano funzione testimoniale del narratore. Giunge voce della morte di James nella battaglia di Culloden, il padre fa sposare Alison a Henry. Nel secondo capitolo Mackellar entra ufficialmente nella storia, la narrazione non è più eterodiegetica ma diventa omodiegetica: Mackellar è ormai sia voce narrante che personaggio agente, passa gran parte del secondo capitolo a smentire le maldicenze su Henry e a gettare fango su James, che non ha conosciuto e che, sebbene sia morto, costituisce la nemesi del fratello (anche perché il padre e Alison lo preferivano).
La presenza assente del Master James turba quindi tutti gli equilibri del nucleo familiare.
Il 1749 come anno da ricordare
Il 1749 è l’anno della visita del colonnello Burke, che rivela che James in realtà è vivo a Parigi e consegna a ogni membro familiare delle lettere. Racconto nel racconto, il colonnello e le lettere diventano narratori intradiegetici, narratori di secondo grado; Mac cerca di ottenere informazioni più dettagliate riguardo la vicenda del Master, facendosi inviare dal colonnello dei documenti da cui estrapola frammenti riguardanti James. Stevenson replica dinuovo l’espediente del manoscritto ritrovato, raddoppiando le voci narranti e i punti di vista: nel manoscritto di Mackellar sulla storia dei Durie, vengono inserite alcune parti del manoscritto di Burke. In questo disegno a cornici concentriche, Mackellar diventa sia narratore che curatore delle memorie fornitegli dal colonnello.
La svolta nel Master di Bellantrae
Il colonnello e il Master, in una scena un po’ comica, si incontrano e decidono di considerarsi amici dopo aver fatto testa o croce. I rimandi alla tradizione cavalleresca inseriscono nella narrazione il modo romanzesco. Man mano che la trama prosegue, la dicotomia buono/cattivo inizia a venir meno nel momento in cui il personaggio del Master inizia a delinearsi, screditando ironicamente il resoconto di Mac.
Nel caso di Mac, la sua inattendibilità è data dalla sua grettezza e attaccamento al denaro, dalla sua misoginia e mancanza di relazioni affettive, dalla sua visione del mondo ottusa. Alle sue spalle, Stevenson fornisce al lettore indizi che ne tradiscano l’inadattezza e la malafede, oltre che i difetti – misoginia, avarizia, scatti di rabbia.
Il duello tra i due fratelli
Il corpo del Master ferito scompare, viene dato per morto, Henry si ammala e inizia a svalvolare; il padre muore e il titolo passa a lui, Alison partorisce un figlio maschio, adorato dal padre e odiato da Mackellar. In seguito James torna, Henry e famiglia scappano in Nordamerica, James e Mackellar partono insieme per cercarli, fino al tragico epilogo in Canada.
In tutto ciò, malgrado la definizione recisa e univoca di Mac, la figura del Master assume una grande complessità umana e psicologica man mano che si va avanti; egli rappresenta perfettamente la problematicità legata al personaggio umano, soprattutto nel momento in cui egli diventa figura reale, non derivante dai racconti di terzi. Quindi, tutti gli elementi strutturali del libro gravitano in realtà intorno a quello che è il cardine della vicenda, cioè il conflitto tra ciò che è e ciò che appare, realtà e forma: il risultato di Stevenson è un romanzo a forte matrice filosofica, basato sull’impossibilita di giungere ad una effettiva comprensione della natura umana.
Fonte immagine per ‘Il Master di Bellantrae, di Robert Louis Stevenson’: Pixabay