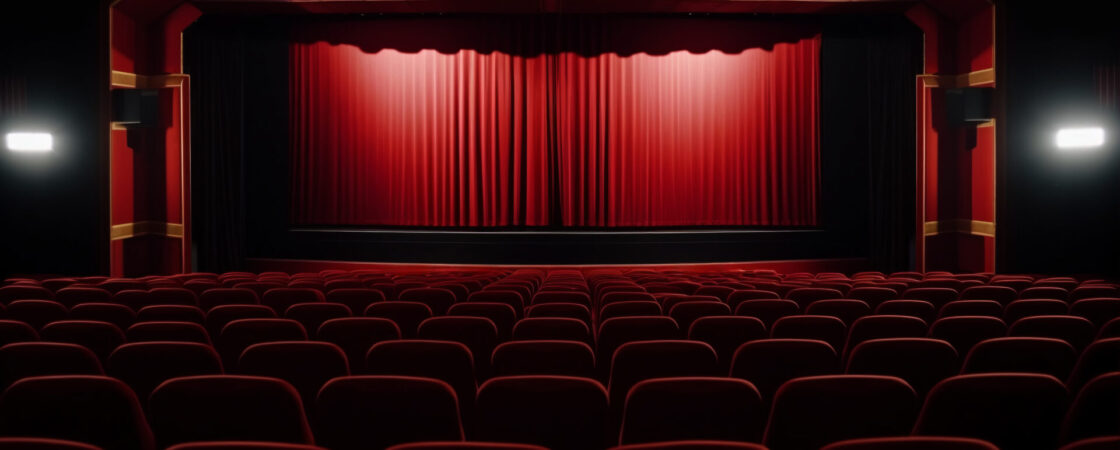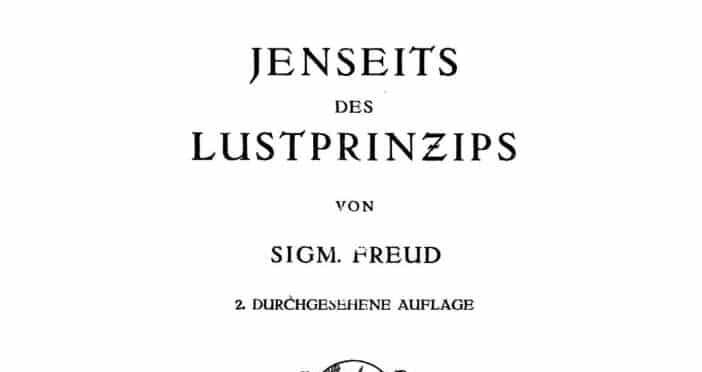Il teatro di Bertolt Brecht rappresenta una delle più importanti rivoluzioni della scena del Novecento. Nato ad Augusta nel 1898, Berthold Friedrich Brecht sviluppa il suo stile nella vivace Berlino della Repubblica di Weimar, entrando in contatto con i principali movimenti d’avanguardia. Da queste esperienze nasce il suo modello di Teatro epico, un teatro che rifiuta l’immedesimazione emotiva per stimolare nello spettatore una coscienza critica e politica.
Indice dei contenuti
Teatro Epico (Brecht) vs. Teatro Drammatico (Aristotelico)
Per capire l’innovazione di Brecht, è utile confrontare il suo modello con il teatro tradizionale, basato sulla catarsi emotiva.
| Teatro Drammatico (Tradizionale) | Teatro Epico (Brechtiano) |
|---|---|
| Scopo: coinvolgere lo spettatore, provocare emozioni (catarsi). | Scopo: rendere lo spettatore un osservatore critico, provocare ragionamento. |
| L’attore si immedesima nel personaggio. | L’attore “mostra” il personaggio, mantenendo una distanza. |
| Crea un’illusione di realtà (quarta parete). | Rompe l’illusione, mostra gli artifici teatrali. |
| Lo spettatore “sente” e “vive” la storia. | Lo spettatore “pensa” e “giudica” la storia. |
1. La funzione sociale e politica
Il teatro di Bertolt Brecht si caratterizza per una forte impronta sociale. Il suo desiderio è far riflettere gli spettatori, perché prima di essere tali, sono cittadini. Il compito più importante del teatro è scuotere la coscienza dello spettatore per formare buoni cittadini. Il teatro di Brecht riflette il contesto sociale del suo tempo, mostrandone i difetti in maniera diretta. Lo scopo è far pensare il pubblico alle problematiche della società, portandolo a desiderare una soluzione. Quando lo spettatore esce dal teatro, diventa un cittadino che può e deve agire per cambiare la società.
2. Lo straniamento (Verfremdungseffekt)
Per spingere gli spettatori a riflettere, Brecht introduce il concetto di “straniamento”. Se un attore si identifica completamente nel personaggio, il pubblico si immedesima, accettando senza critiche le sue azioni. Se, al contrario, l’attore stesso non si fonde con il ruolo, anche gli spettatori iniziano a interrogarsi su ciò che accade. Lo straniamento si ottiene presentando qualcosa di familiare, anche quotidiano, in modo innovativo e inaspettato. L’evento noto viene mostrato sotto una luce diversa, che lo rende “strano” e non più scontato, stimolando così il pensiero critico. Questo risultato fu particolarmente significativo nella Berlino del dopoguerra, una città che aveva bisogno di affrontare le tragedie con consapevolezza.
3. La rottura dell’illusione scenica
Nel teatro di Bertolt Brecht, ogni elemento scenico (testo, musica, scenografia) non deve fondersi in un tutto omogeneo, ma rimanere distinto e riconoscibile. Anzi, gli stessi strumenti teatrali (luci, macchinari) devono essere visibili. Questo perché il teatro non deve creare un’illusione di realtà, ma mostrarsi per quello che è: una finzione costruita per uno scopo educativo. Brecht riduce la finzione al minimo per rivelare costantemente “la verità delle cose”. Sostenitore di un teatro essenziale, contrario al barocco e all’eccesso, era disposto a mettere in scena qualsiasi cosa, anche le prove, se aveva una funzione didattica.
4. Il Gestus e il nuovo ruolo dell’attore
L’attore brechtiano non deve “diventare” il personaggio, ma “raccontarlo”. Per fare questo, Brecht sviluppa il concetto di Gestus. Non si tratta di un semplice gesto, ma di un atteggiamento fisico o verbale che rivela la condizione sociale del personaggio e le relazioni di potere in cui è inserito. Ad esempio, il modo in cui un personaggio porge il denaro o saluta un superiore non è un gesto psicologico, ma un “gesto sociale” che ne definisce il ruolo nella società. L’attore deve quindi studiare e mostrare questi gesti in modo quasi scientifico, aiutando il pubblico a comprendere le dinamiche sociali rappresentate.
Altre informazioni e curiosità sul teatro di Bertolt Brecht
Qual è la differenza tra teatro epico e drammatico?
Il teatro drammatico tradizionale (aristotelico) mira a creare immedesimazione ed emozione (catarsi). Il teatro epico di Brecht, al contrario, vuole creare distanza critica e ragionamento nello spettatore, come mostrato nella tabella comparativa in questo articolo.
Cos’è l’effetto di straniamento?
È la tecnica principale del teatro di Brecht. Consiste nel presentare situazioni o personaggi familiari in modo inaspettato, per rompere l’automatismo della percezione e costringere il pubblico a guardare la realtà con occhi nuovi e critici.
Che cos’è il Gestus per Brecht?
Il Gestus è un “gesto sociale”, un comportamento fisico o verbale che esprime la posizione e le relazioni sociali di un personaggio. Non è legato alla psicologia, ma alla sua funzione nella struttura della società. L’attore non lo “sente”, ma lo “mostra” al pubblico.
Fonte immagine: Freepik
Articolo aggiornato il: 01/09/2025