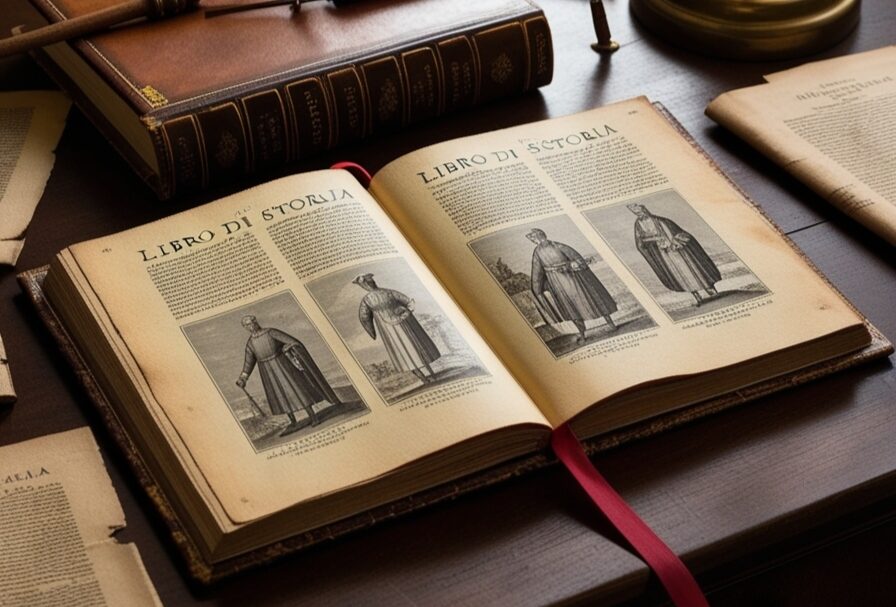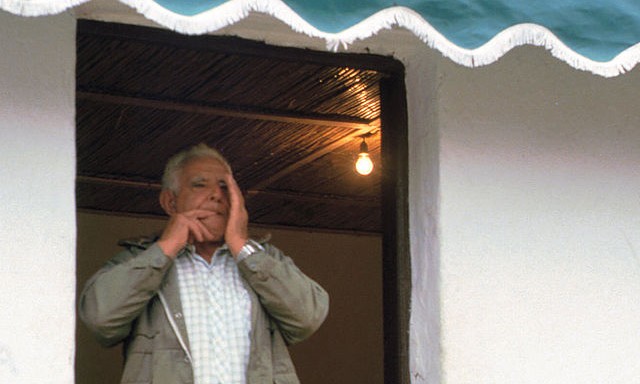Il termine storia è antico e deriva dal greco istoreîn, che significa “ricercare, informarsi”. Indagare sul passato è infatti il compito della storia. La nostra lingua lo utilizza sia per intendere lo svolgimento delle vicende umane nel tempo (res gestae), sia la loro narrazione e interpretazione (historia rerum gestarum). Qual è la differenza tra storia e storiografia? L’ambiguità del termine italiano è oggi risolta con l’uso di storiografia, che indica l’elaborazione di un’opera di argomento storico secondo una precisa metodologia. In entrambe le definizioni compare lo stesso soggetto: l’uomo. Senza di lui non esiste storia, perché non ci sarebbe chi la produce, la narra, la interpreta.
Indice dei contenuti
- L’importanza di studiare la storia
- Gli elementi fondamentali: uomo, tempo e spazio
- Lo storico e il metodo storico
- Le fonti della storia: una classificazione completa
- La memoria storica: tra passato e futuro
- Le principali scienze ausiliarie della storia
- La cronologia: l’apparato scheletrico della storia
L’importanza di studiare la storia
Studiare la storia è fondamentale non solo per conoscere il passato, ma soprattutto per comprendere il presente e orientarsi nel futuro. La conoscenza degli eventi passati ci permette di capire le radici dei problemi attuali, le origini delle culture e delle istituzioni che modellano la nostra società. Sviluppa il pensiero critico, insegnandoci a valutare le fonti, a distinguere i fatti dalle interpretazioni e a non accettare passivamente una sola versione degli eventi. Infine, la storia ci educa alla cittadinanza, mostrandoci le conseguenze delle scelte umane e rendendoci più consapevoli delle nostre responsabilità individuali e collettive.
La classificazione delle fonti storiche
| Classificazione | Tipologie di fonti |
|---|---|
| Per natura | Scritte (leggi, lettere), Materiali (monumenti, utensili), Iconografiche (dipinti, foto), Orali (leggende, interviste). |
| Per rapporto con l’evento | Primarie o dirette (testimonianze coeve, es. un diario) e Secondarie o indirette (rielaborazioni successive, es. un manuale). |
| Per intenzione | Volontarie (create per lasciare memoria, es. un arco di trionfo) e Involontarie (diventate fonti senza intenzione, es. una lettera privata). |
Gli elementi fondamentali: uomo, tempo e spazio
Il primo fattore della storia è l’uomo. Altro elemento fondamentale è il tempo, quindi la storia è la scienza degli uomini nel tempo. Con questa affermazione lo storico francese Marc Bloch vuole sottolineare sia l’aspetto umano della storia, sia il fatto che un fenomeno storico si spiega pienamente tenendo conto del tempo in cui avviene. Cosa studia la storia e di quali uomini si occupa? In passato trattava solo “le gesta dei re”, dando spazio a grandi eventi di natura politica e militare e a grandi personalità (re, papi, imperatori). La ricerca storica contemporanea si muove in un campo più vasto: quello che ha come attori anche gli uomini comuni e si propone di ricostruire i cambiamenti della società in una dimensione più ampia, occupandosi degli aspetti economici, sociali, culturali e della vita quotidiana del passato.
Altro elemento fondamentale è lo spazio. A sua volta l’uomo interagisce con gli spazi fisici, modificandoli in base alle proprie necessità. Geografia e storia, perciò, vanno un po’ a braccetto.
Lo storico e il metodo storico
Le opere storiche vengono scritte da specialisti, gli storici, che si propongono di ricostruire il passato avvalendosi di tecniche e criteri che costituiscono il metodo storico. Chi è lo storico e cosa fa? Nello svolgimento del proprio lavoro, deve innanzitutto reperire i documenti, detti anche fonti, selezionarli, datarli, catalogarli, analizzarli e valutarne l’autenticità. Deve inoltre farsi un’ipotesi di lavoro e analizzare i documenti ponendosi delle domande. Come tutte le scienze umane, anche la storia pone un problema di obiettività. Lo storico può e deve essere obiettivo e ciò è possibile solo se applica con correttezza e rigore il suo metodo. I documenti vanno studiati senza pregiudizi: lo storico deve porsi il fine di comprendere e non di giudicare.
Le fonti della storia: una classificazione completa
La storia si basa su una conoscenza per tracce, in quanto lo storico studia fatti che non ha direttamente vissuto. Queste tracce sono le fonti o documenti. Quali sono le fonti della storia? Un tempo le fonti scritte erano le privilegiate. Ora tutto quello che l’uomo produce si ritiene possa dare preziose informazioni; per questo hanno assunto particolare importanza anche le fonti materiali: i manufatti, le opere iconografiche e i monumenti, le fotografie. Fra le fonti scritte si annoverano i documenti ufficiali (atti pubblici e privati, trattati, leggi) e le fonti narrative (cronache, opere letterarie, diari). Non meno fondamentale è la classificazione delle fonti in primarie o dirette e secondarie o indirette. Le prime mettono lo storico a contatto con un frammento del passato senza mediazione (resti archeologici, atti notarili). Sono primarie anche le fonti orali, che ci restituiscono la testimonianza di chi ha partecipato a un evento. Le fonti indirette, invece, mettono a conoscenza di un avvenimento tramite un mediatore (un cronista, un pittore). Le fonti si possono suddividere anche in volontarie e involontarie. Del primo gruppo fanno parte tutti quei documenti realizzati con la precisa consapevolezza di lasciare una testimonianza ai posteri: cronache storiche, monumenti come le piramidi o gli archi di trionfo. Molto spesso, però, il passato ci parla attraverso indizi che non sono nati con l’intenzionale volontà di lasciare un ricordo. In questo caso si parla di fonti involontarie, come le lettere di un soldato dal fronte.
La memoria storica: tra passato e futuro
«Il tempo di oggi risale nel contempo a ieri, ad un passato più lontano e ad uno remotissimo». Questa affermazione dello storico Braudel ci invita a ricordare che gli uomini sono figli del loro passato. L’interesse di studiare il passato risiede innanzitutto nel fatto di poter meglio comprendere il presente. Dal passato derivano infatti idee, valori e istituzioni che caratterizzano le società in cui viviamo. La storia accresce inoltre la conoscenza degli uomini, facendo comprendere la complessità. Educa alla responsabilità, mostrando ciò che accade come conseguenza delle libere scelte degli uomini. I Latini dicevano che la storia è maestra di vita: Historia magistra vitae.
Le principali scienze ausiliarie della storia
Per le sue ricerche, lo storico può avvalersi del contributo di discipline, definite scienze ausiliarie della storia. Per le fonti materiali un ruolo di spicco riveste l’archeologia. La paleontologia invece studia i fossili. Numerose sono le scienze per lo studio delle fonti scritte: la paleografia (antiche forme di scritture); l’epigrafia (testi incisi su materiale durevole); la papirologia (scritti riportati sui papiri); la filologia (origine e evoluzione della lingua). Altrettanto fondamentale è il contributo della numismatica (studio delle monete), della topografia, della toponomastica, dell’antropologia, della sociologia e della demografia storica.
La cronologia: l’apparato scheletrico della storia
Per “mettere ogni cosa al proprio posto”, nella storia bisogna servirsi della cronologia. Il termine deriva dal greco chrónos (tempo) e lógos (discorso). Essa ne costituisce il sostegno, l’apparato scheletrico. Nell’ambito della cronologia, si distinguono due concetti: diacronia (svolgimento lineare del tempo) e sincronia (svolgimento parallelo in ambiti diversi). La cronologia tradizionale suddivide la storia in tre grandi periodi, detti Evi (Antico, Medievale, Moderno), preceduti dalla lunghissima Preistoria. Ciascun Evo, poi, viene suddiviso in sottoperiodi.
Occorre mettere in rilievo che le datazioni fino al Mesolitico sono espresse in “anni fa”, mentre dal Neolitico in poi si usa il sistema a.C. (avanti Cristo) e d.C. (dopo Cristo).