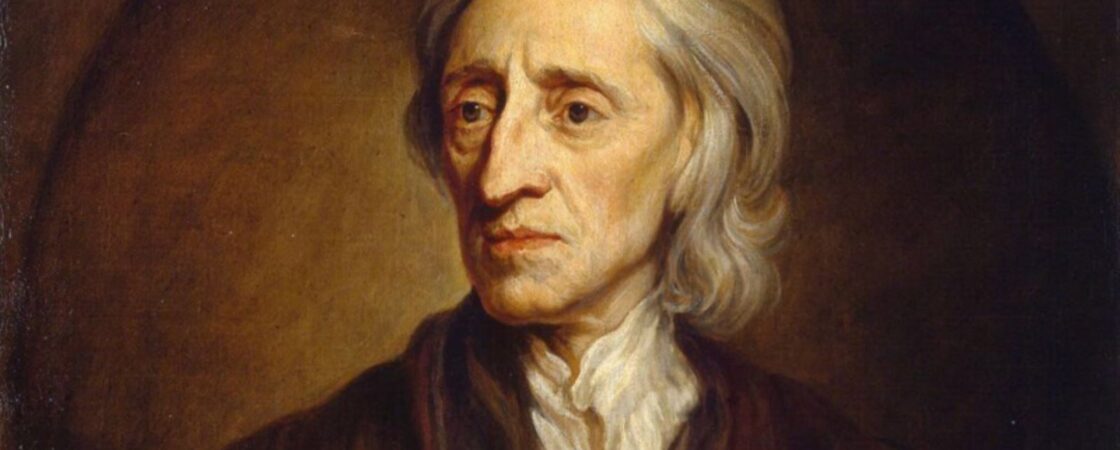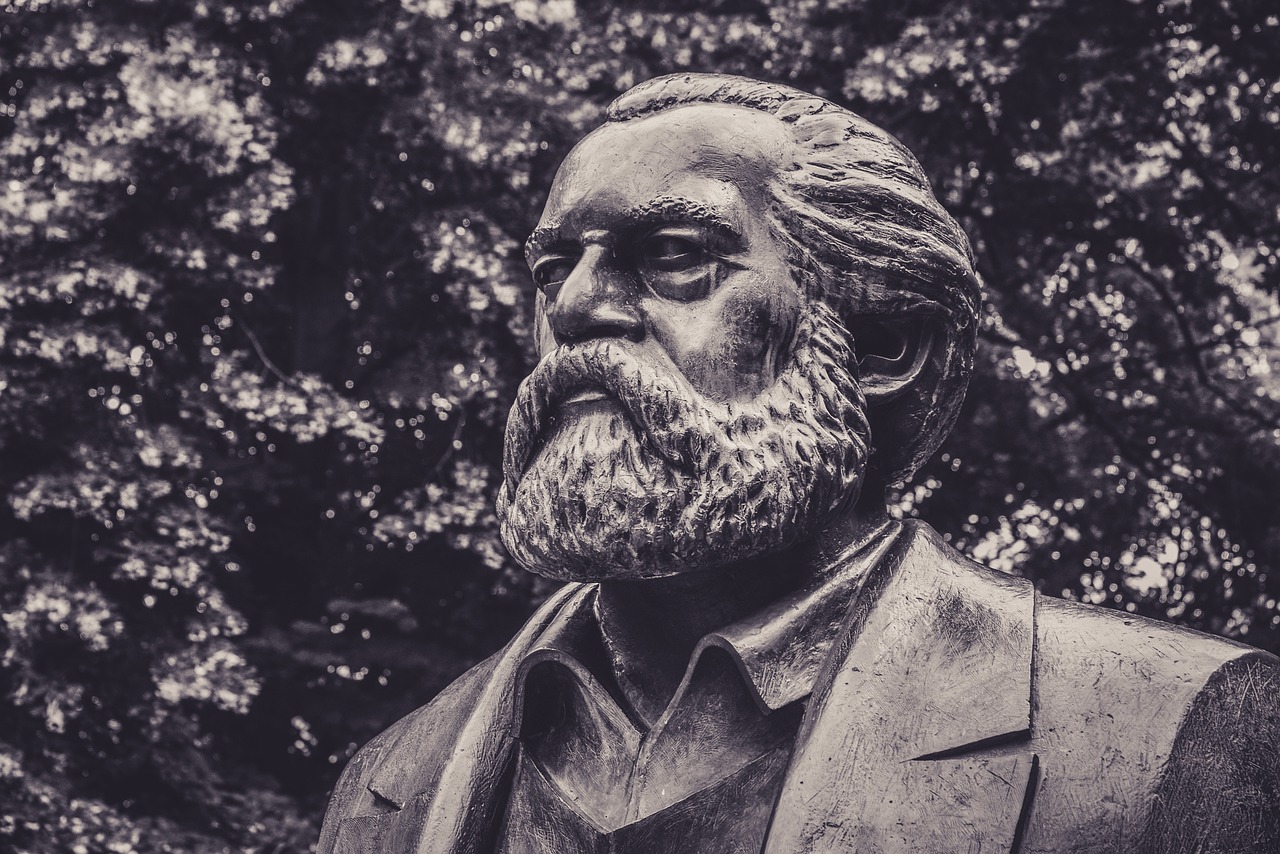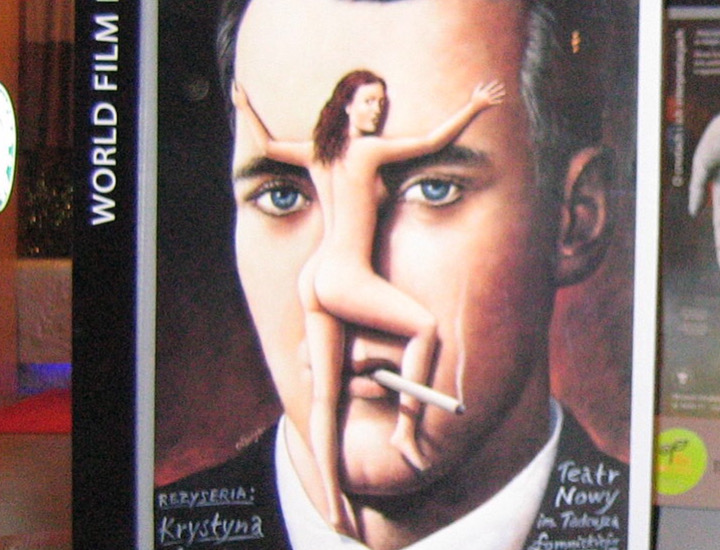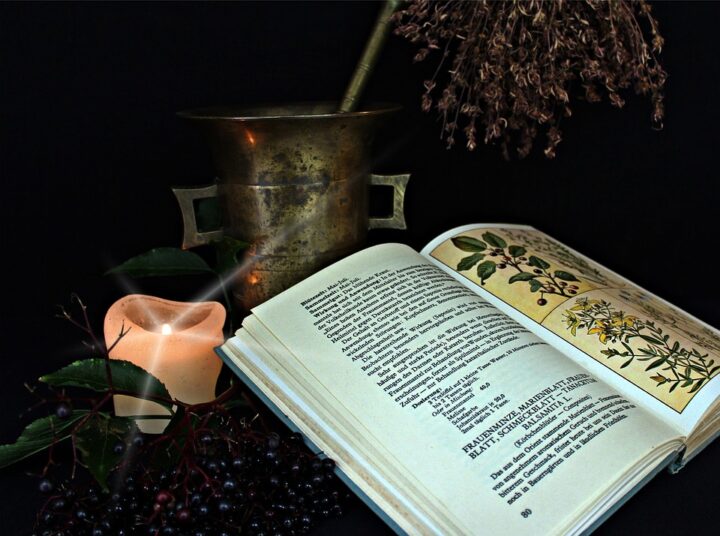John Locke è un filosofo inglese ed è considerato l’iniziatore dell’empirismo, corrente filosofica che si contrappone al razionalismo. Secondo John Locke la conoscenza deriva dall’esperienza e che nessuna mente neanche quella più geniale può produrre autonomamente delle idee considerate a posteriori, si vede l’oggetto e se ne fa un’idea. Quindi non esiste l’idea universale come affermava Platone.
La vita di John Locke
John Locke nacque a Wrington, nel Somerset, in Inghilterra, il 29 agosto 1632, in un periodo di grande fermento politico. Suo padre era un avvocato e sostenitore del Parlamento durante la guerra civile inglese, un’esperienza che influenzò profondamente le convinzioni politiche del giovane Locke. Studiò alla Westminster School e poi a Christ Church, Oxford, dove si dedicò alla filosofia, alle scienze naturali e alla medicina. Inizialmente, Locke mostrò interesse per le dottrine scolastiche, ma in seguito si avvicinò alle nuove correnti del pensiero scientifico, entrando in contatto con figure come Robert Boyle, uno dei fondatori della chimica moderna. La sua carriera lo portò a ricoprire diverse cariche pubbliche, tra cui quella di segretario del conte di Shaftesbury, un importante esponente del partito Whig. Questo coinvolgimento nella politica lo costrinse anche all’esilio in Olanda per alcuni anni, a causa delle sue posizioni liberali. Durante questo periodo, Locke completò la stesura del Saggio sull’intelletto umano, che fu pubblicato al suo ritorno in Inghilterra dopo la Gloriosa Rivoluzione del 1688. Oltre al Saggio, Locke scrisse importanti opere come i Due trattati sul governo, le Lettere sulla tolleranza e Pensieri sull’educazione, che ebbero un’enorme influenza sul pensiero politico e pedagogico successivo. Locke morì a Oates, nell’Essex, il 28 ottobre 1704.
Il contesto storico e filosofico
John Locke visse in un periodo di grandi cambiamenti politici e intellettuali in Inghilterra, segnato da conflitti religiosi e dalla lotta per il potere tra la monarchia e il Parlamento. Il XVII secolo vide la Rivoluzione Inglese, la Restaurazione e la Gloriosa Rivoluzione, eventi che influenzarono profondamente il suo pensiero. In questo contesto, Locke si schierò a favore del parlamentarismo e della tolleranza religiosa, posizioni che rifletté nelle sue opere, in particolare nei Due trattati sul governo. Dal punto di vista filosofico, Locke si oppose alle dottrine dell’innatismo e del razionalismo, che dominavano il pensiero continentale, rappresentato da figure come Cartesio e Leibniz. Questi filosofi sostenevano l’esistenza di idee innate, presenti nella mente umana fin dalla nascita, e la capacità della ragione di raggiungere verità assolute indipendentemente dall’esperienza. Locke, al contrario, pose l’esperienza al centro della sua epistemologia, fondando l’empirismo inglese e aprendo la strada a sviluppi successivi con filosofi come Berkeley e Hume. La sua influenza fu enorme sull’Illuminismo, un movimento culturale che esaltava la ragione e la libertà individuale, e sulla politica, con le sue idee sui diritti naturali e la limitazione del potere statale.
John Locke: le riflessioni
John Locke, come anticipato, crede che tutte le idee derivino dall’esperienza che può essere esterna o interna. Le idee di riflessione rimandano all’esperienza interna, quindi la percezione, il dubbio, il ragionamento, mentre le idee di sensazione rimandano all’esperienza esterna come calore, sapore perché riguardano i sensi.
Queste sono chiamate idee semplici ma la conoscenza non si ferma a quest’ultime, le quali implicano una tendenziale passività della mente poiché è la realtà che ci viene incontro. John Locke sostiene che la vera conoscenza stia nel combinare più idee semplici per avere idee complesse che si dividono in 3 categorie: modi, sostanze e relazioni.
- Modi. Le idee complesse non esistono di per sé ma sono conseguenze o riflesso di altre sostanze, sono modi che si riferiscono a un soggetto come il modo di essere, alto, basso, forte e così via. Dunque se una persona dice: “alto”, qualcuno di riflesso risponderà “chi”.
- Sostanze. La sostanza non esiste di per sé, nella sua universalità ma è sempre la somma di tante idee particolari. Per esempio se vediamo una mela rossa ha un sapore, una consistenza e viene denominata mela, ma non vediamo l’universalità di essa, esistono vari tipi di mele con sapori e colori diversi. Dunque non si vede universalità ma le caratteristiche specifiche di un determinato oggetto.
- Relazioni. Sono delle concatenazioni di idee messe in relazione tra loro, come il concetto di identità si relaziona a quello di diversità. Per capire che qualcosa è identico bisogna relazionarlo con la diversità. Quindi si mettono in relazione per arrivare a una conseguenza, per esempio la causa ha come relazione l’effetto ma è un qualcosa che avviene spontaneamente.
Da questi principi John Locke elabora 2 tipi di conoscenza: intuitiva e dimostrativa. La prima è la conoscenza immediata ed è quella più certa e semplice, come: 2+2= 4 non si ha il bisogno di pensare, o fare grandi calcoli, intuitivamente si arriva ad una conclusione. La seconda, quella dimostrativa, è invece più complessa, non si arriva subito, ci sono tante fasi intermedie che si chiamano prove. La conoscenza dimostrativa essendo complessa può far cadere nell’errore: se si fanno dei calcoli algebrici, ad esempio, è possibile sbagliare un passaggio o un risultato, quindi si deve rifare il tutto.
Secondo John Locke le conoscenze certe sono:
- Conoscenza intuitiva dell’io
- Conoscenza per dimostrazione dell’esistenza di Dio
- Conoscenza delle cose esterne per sensazione
Conoscenza dell’io. Secondo Locke la conoscenza dell’io si ha con il cogito ergo sum, intuisco di essere un soggetto pensante e quindi io so di esistere, vediamo delle persone sono delle nostre idee e ci arrivano delle sensazioni. Queste sensazioni per essere percepite devono arrivare ad un centro unificatore cioè la realtà. Quest’ultima è molteplice ma al nostro intelletto arriva l’unità del molteplice: l’identità riceve in un determinato momento una sensazione. Ognuno ha le proprie sensazioni. Di conseguenza John Locke deduce che la realtà è complessa e molteplice, l’identità dell’io unifica il molteplice, io so di esistere e tra le varie esistenze so di essere un soggetto pensante. Penso dunque sono.
Conoscenza di Dio. Locke in quanto empirista avrebbe dovuto essere ateo perché la conoscenza si basa sull’esperienza. Però tramite la dimostrazione causale arriva alla dimostrazione dell’esistenza di Dio e afferma: «io so che tutto ciò che esiste ha una causa e devo ipotizzare che ci sia stata una causa prima che ha generato se stessa e le cose del mondo e questa causa è Dio». Esiste qualcosa e se esiste è stato creato, ma da chi? Ci deve quindi essere una causa prima che ha creato il mondo, se stessa e poi le cose.
Conoscenza delle cose esterne. Per Locke esiste la sensazione e quindi un’osservazione diretta degli oggetti, si osserva per poi fare un’idea. L’immaginazione imprime l’oggetto nella mente, l’intelletto ci riflette e si arriva alla definizione di quel concetto che ha determinate caratteristiche. Quindi per avere una conoscenza bisogna trovare una relazione tra realtà esterna e le idee, ci deve essere corrispondenza e la possibilità da parte dell’intelletto di indagare la realtà.
L’evoluzione dell’empirismo dopo Locke
L’empirismo di John Locke ha posto le basi per uno sviluppo significativo di questa corrente filosofica nei secoli successivi. Le sue idee sulla tabula rasa e sull’importanza dell’esperienza sensoriale hanno influenzato profondamente pensatori successivi, dando vita a diverse sfumature e interpretazioni dell’empirismo. George Berkeley, ad esempio, portò l’empirismo alle sue estreme conseguenze con il suo idealismo immaterialista, sostenendo che esse est percipi (“essere è essere percepito”). Berkeley negò l’esistenza di una materia indipendente dalla percezione, affermando che solo le idee e le menti che le percepiscono esistono realmente. Questa posizione radicale cercava di confutare il materialismo e di rafforzare l’importanza della percezione nella costituzione della realtà. David Hume, considerato il più importante empirista dopo Locke, sviluppò un empirismo scettico, mettendo in discussione concetti fondamentali come la causalità e l’induzione. Hume argomentò che non possiamo avere una vera conoscenza delle connessioni causali tra gli eventi, ma solo osservare la loro costante congiunzione. Questa critica radicale mise in crisi le pretese della scienza di raggiungere verità assolute e aprì la strada a nuove riflessioni sulla natura della conoscenza. Nel corso del XVIII e XIX secolo, l’empirismo continuò a influenzare il pensiero filosofico e scientifico, con figure come John Stuart Mill, che applicò i principi empiristi alla logica, alla politica e all’etica. Nel XX secolo, l’empirismo logico del Circolo di Vienna cercò di combinare l’empirismo con la logica formale, proponendo un criterio di significanza basato sulla verificabilità empirica. L’empirismo continua a essere una corrente importante nella filosofia contemporanea, influenzando discipline come la filosofia della scienza, la psicologia cognitiva e le scienze sociali.
Fonte immagine: Wikipedia