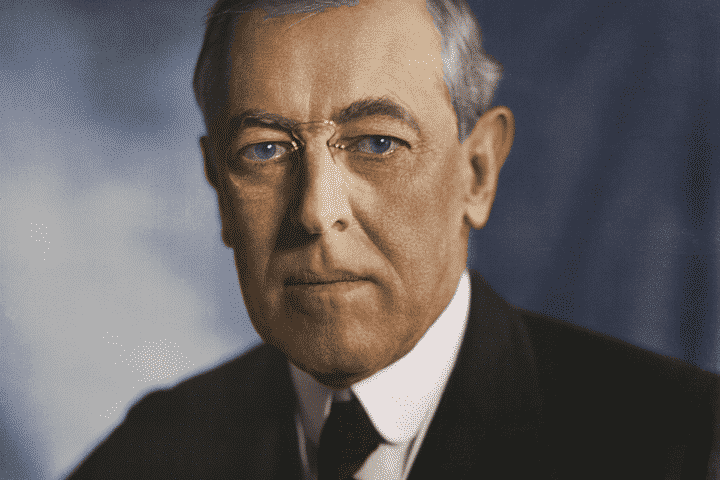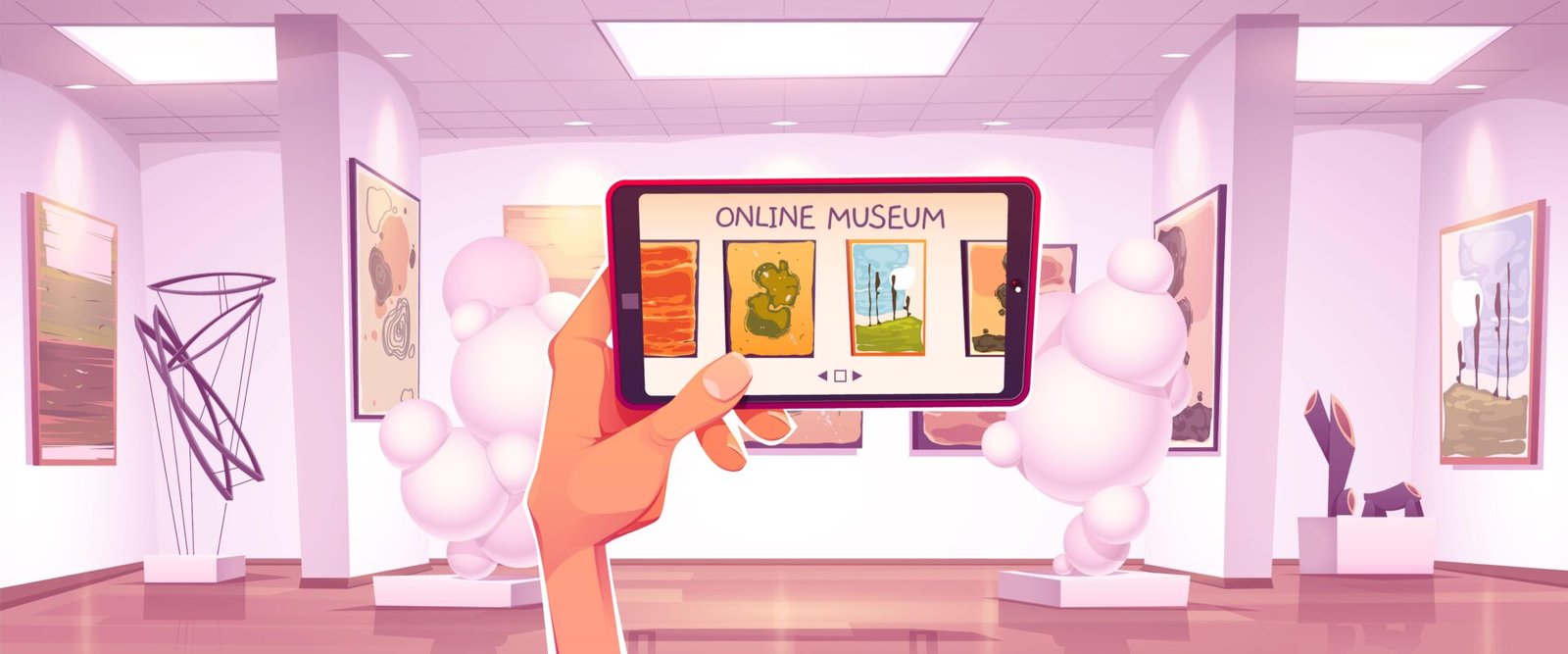La conversazione, un atto linguistico quotidiano, può apparire come un flusso di parlato disordinato. In realtà, è un sistema altamente organizzato e strutturato. A partire dagli anni ’70, la disciplina dell’Analisi della Conversazione, fondata da sociologi come Harvey Sacks, Emanuel Schegloff e Gail Jefferson, ha dimostrato che ogni interazione segue regole precise che ne garantiscono la fluidità e la coerenza. Il funzionamento di questo sistema si basa sulla collaborazione implicita tra gli interlocutori, in particolare nella gestione dei turni e delle sequenze.
Indice dei contenuti
Il sistema di gestione dei turni
Il principio base della conversazione è che, di norma, una persona parla alla volta. La gestione dei turni di parola è regolata da un meccanismo preciso. Il Parlante (P) attuale ha la possibilità di selezionare il parlante Successivo (S). L’alternanza avviene in corrispondenza di un Punto di Rilevanza Transizionale (PRT), ovvero la fine di un’unità sintattica o di pensiero dove il turno può passare a un altro interlocutore. Se il parlante P non seleziona nessuno, il primo che interviene si auto-seleziona e prende la parola. Se nessuno interviene, il parlante P può continuare il suo turno. Questo dimostra come l’interazione sia un accordo collaborativo e non un’interruzione caotica.
Le coppie adiacenti: le fondamenta del dialogo
Un elemento fondamentale dell’organizzazione conversazionale sono le coppie adiacenti (o sequenze complementari). Si tratta di due turni consecutivi, prodotti da parlanti diversi, in cui la prima parte richiede un tipo specifico di seconda parte. Sono forme ricorrenti e quasi automatiche che strutturano le nostre interazioni. Alcuni esempi classici sono:
- Saluto → Saluto
- Domanda → Risposta
- Invito → Accettazione/Rifiuto
- Offerta → Accettazione/Rifiuto
Sequenze preferite e dispreferite
La seconda parte di una coppia adiacente può essere preferita o dispreferita. Una risposta preferita è quella socialmente attesa, più diretta e semplice. Una risposta dispreferita, invece, è inattesa, va contro le aspettative e richiede un “lavoro” linguistico aggiuntivo per essere formulata, come esitazioni, giustificazioni o ritardi.
| Sequenza preferita | Sequenza dispreferita |
|---|---|
| È la risposta socialmente attesa e più comune (es. accettare un invito). | È la risposta inattesa e meno comune (es. rifiutare un invito). |
| Viene prodotta in modo diretto, rapido e senza esitazioni. | È spesso preceduta da pause, esitazioni (“beh…”, “ehm…”) e seguita da giustificazioni. |
| Esempio: “ti va un caffè?” → “sì, volentieri!”. | Esempio: “ti va un caffè?” → “(pausa) beh… guarda, ti ringrazio ma devo proprio scappare”. |
L’influenza culturale: lo studio di Zorzi
Sebbene queste strutture siano universali, la loro applicazione pratica può variare culturalmente. Uno studio del 1990 di Daniela Zorzi ha analizzato le risposte dispreferite dei commessi in librerie italiane e inglesi. Come evidenziato da fonti accademiche come l’Enciclopedia Treccani, è emerso che i commessi italiani tendono a fornire una risposta negativa diretta, seguita da un “lavoro di riparazione” (suggerimenti, alternative), un approccio che potremmo definire post-riparatorio. I commessi inglesi, invece, ritardano la risposta negativa con esitazioni e formule come “well…” o “ehm…”, preparando il cliente al rifiuto in un approccio pre-riparatorio. Questo dimostra come, pur partendo da una struttura comune, le consuetudini culturali influenzino profondamente il modo in cui gestiamo la conversazione. L’Accademia della Crusca stessa promuove studi sulla pragmatica della lingua italiana, sottolineando l’importanza di questi aspetti culturali.
fonte immagine: pexel.com
Articolo aggiornato il: 06/10/2025