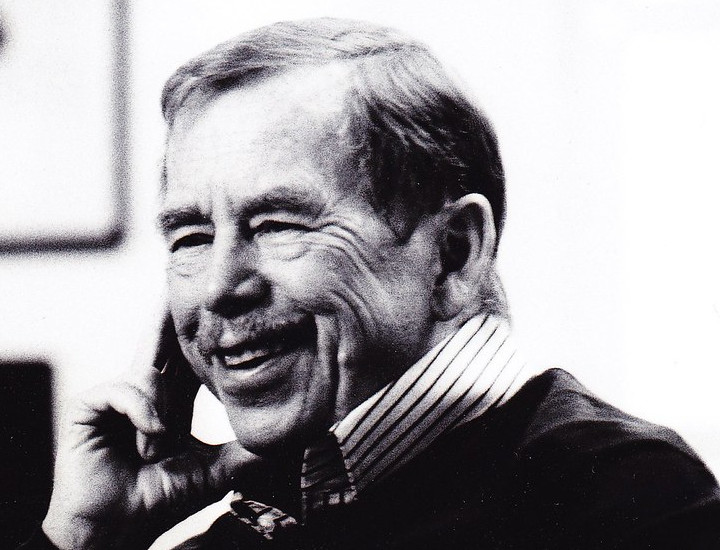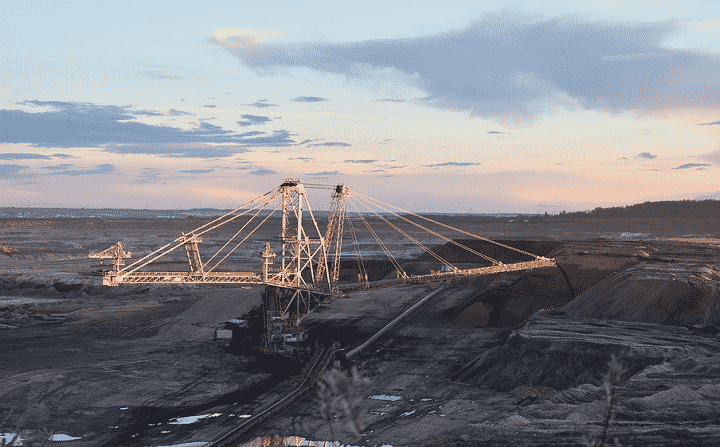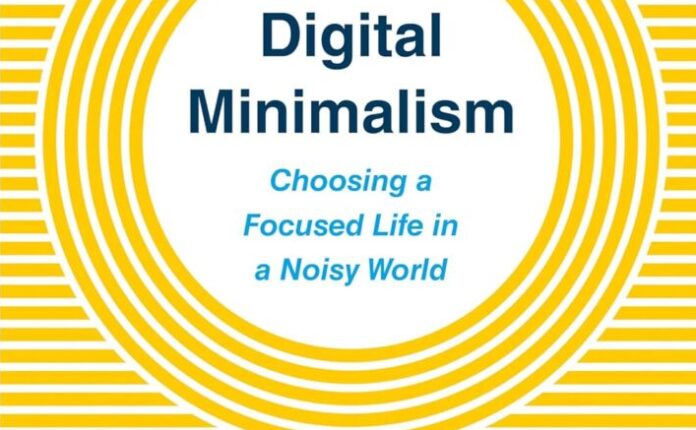Questo articolo descrive le basi della società romana arcaica, concentrandosi sulle sue strutture portanti, le classi sociali e il ruolo centrale della religione.
La famiglia patriarcale: il potere assoluto del paterfamilias
Le strutture portanti della società romana arcaica erano la famiglia e la gens. La famiglia era il nucleo sociale più piccolo, comprendente tutti coloro che erano soggetti all’autorità del maschio più anziano, il paterfamilias: moglie, figli, nipoti e schiavi (anche se questi ultimi erano poco numerosi nei primi secoli della storia di Roma). Si trattava di una famiglia patriarcale, fondata sul dominio della componente maschile. Le donne, al momento del matrimonio, passavano sotto l’autorità del marito.
L’autorità del paterfamilias era pressoché assoluta, sia sulle persone che sui beni. Amministrava tutte le questioni familiari, decideva se riconoscere o abbandonare i figli alla nascita, stabiliva l’impiego del patrimonio, combinava i matrimoni, assegnava i beni ai figli e, almeno nel periodo più arcaico, sembra che avesse persino potere di vita e di morte sui membri della famiglia. I rapporti familiari erano caratterizzati da un forte autoritarismo, considerato dai Romani una virtù fondamentale per la coesione sociale.
La gens: un gruppo di famiglie con antenati comuni
La gens era costituita da un gruppo di varie famiglie che discendevano da antenati comuni. I componenti della gens (i gentiles) portavano lo stesso nome, osservavano culti particolari e celebravano feste e cerimonie in comune. Avevano l’obbligo di aiutarsi reciprocamente. Non esisteva un capo della gens: erano i paterfamilias delle singole famiglie a prendere le decisioni, vincolanti per tutti.
Nell’età monarchica e nei primi secoli della Repubblica, i membri della gens avevano in comune anche la proprietà di pascoli e terreni. Solo a partire dal IV secolo a.C. iniziò ad affermarsi a Roma la piena proprietà individuale della terra.
Della gens facevano parte anche i clienti, persone libere (non schiavi) che godevano della protezione di un componente della gens (il patrono). In cambio, i clienti assicuravano fedeltà e servizi di ordine economico e militare. I clienti costituivano la forza militare che la gens utilizzava nelle razzie o nelle guerre (che, nella prima fase della storia di Roma, erano spesso condotte dalle gentes più che dallo stato).
Patrizi e plebei: la divisione sociale fondamentale
L’insieme dei cittadini romani costituiva il populus Romanus, composto sia da individui appartenenti a una gens sia da quelli che ne erano privi. Da qui deriva la distinzione sociale fondamentale tra patrizi e plebei.
- Patrizi: L’aristocrazia romana, gli appartenenti alle gentes più antiche. Detenevano il potere politico ed erano gli unici a poter far parte del Senato, comandare l’esercito e celebrare i riti religiosi.
- Plebei: Secondo la definizione data dagli antichi patrizi, i plebei erano coloro che non facevano parte di una gens, individui privi del prestigio derivante dall’appartenenza a una gens. Erano un gruppo sociale eterogeneo: contadini, clienti che avevano perso il loro patrono, commercianti, artigiani, ecc. Spesso erano poveri, ma non mancavano plebei benestanti. Erano esclusi dai diritti politici e dal governo della città.
La religione nella società romana arcaica: pietas e formalismo
La religione aveva un ruolo centrale nella vita di Roma, caratterizzata da un forte valore pubblico e civico. L’atteggiamento religioso dei Romani era definito dalla pietas, non la “pietà” in senso cristiano, ma il sentimento di dovere e rispetto dovuto agli dèi, che si traduceva nell’adempimento di precisi rituali e obblighi. Era sempre la comunità a praticare il culto religioso. Anche all’interno delle mura domestiche, era il pater familias a officiare il culto per l’intera famiglia.
Il ruolo dei sacerdoti e l’influenza etrusca
La pratica religiosa e la sfera politica erano strettamente collegate. I magistrati celebravano di persona diversi riti ed erano i rappresentanti della cittadinanza anche di fronte agli dèi. Molti uomini politici importanti iniziarono la loro carriera con cariche religiose.
La religione romana era caratterizzata da un forte formalismo: la pratica religiosa consisteva in formule e riti da rispettare scrupolosamente per ottenere la benevolenza divina (“pace con gli dèi”), condizione essenziale per il successo di ogni azione. Il calendario romano distingueva rigorosamente tra giorni lavorativi e giorni festivi dedicati agli dèi. Qualsiasi atto di rilevanza pubblica doveva avere il favore degli dèi, interrogati con tecniche divinatorie apprese dagli Etruschi.
Come gli Etruschi, i Romani avevano sacerdoti specializzati nella lettura delle viscere degli animali (aruspici) e nell’interpretazione del volo degli uccelli e dei segni celesti. I pontefici, guidati dal pontifex maximus (che ereditò le funzioni religiose del re), custodivano le norme tradizionali e la loro interpretazione. Il legame tra gli interpreti della volontà divina e il patriziato aumentava ulteriormente il potere di quest’ultimo.
Culti familiari e divinità civiche
La religione romana integrava elementi di origine antica (legati a culti agricoli e pastorali) con altri derivati dagli Etruschi, dagli Italici e dai Greci. Grande importanza avevano i culti familiari:
- Penati: Protettori della prosperità domestica.
- Lari: Vigilavano sulla casa e sulle strade.
- Vesta: Patrona del focolare domestico e della purezza, ma anche dello stato. Le Vestali, sacerdotesse vergini, avevano il compito di tenere sempre acceso il fuoco sacro, simbolo della conservazione della famiglia e dello stato.
A queste divinità si unirono altre di carattere agreste e di origine latino-laziale (es. Marte, dio della guerra e dell’agricoltura). Altre divinità, di origine laziale, etrusca (es. Minerva) o greca (es. Apollo), avevano carattere civico, come protettrici della città.
La società romana arcaica era quindi caratterizzata da una struttura gerarchica (famiglia patriarcale, gens, divisione tra patrizi e plebei) e da un forte legame tra religione e vita pubblica. Questi elementi, pur evolvendosi nel tempo, avrebbero continuato a influenzare profondamente la storia di Roma.
Prof. Giovanni Pellegrino
L’omosessualità nell’antica Grecia: tra accettazione e regole