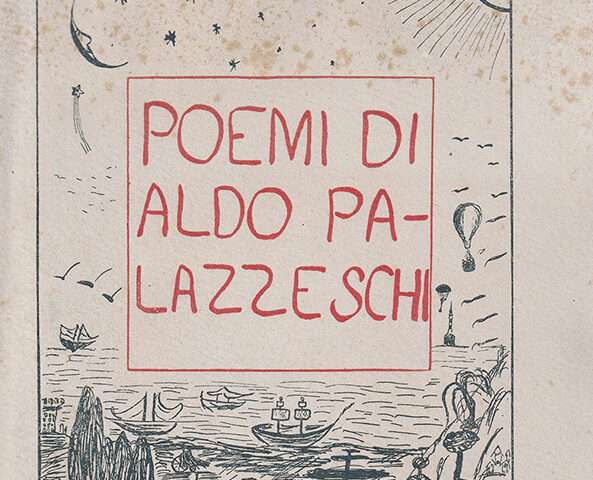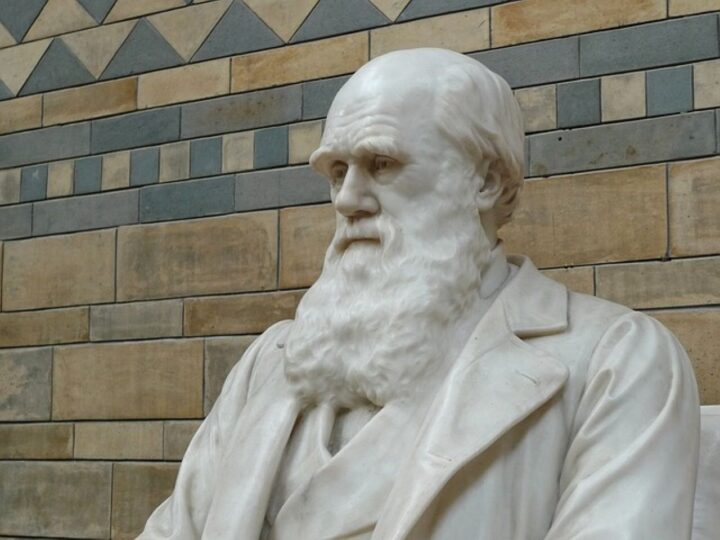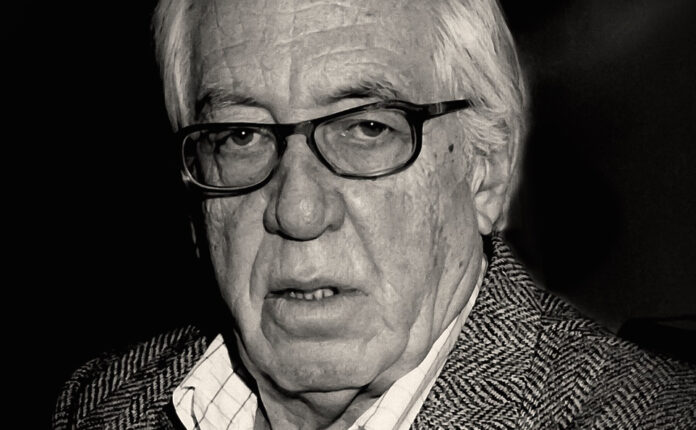A cosa fa pensare il termine “palafitte”? Una vacanza all’insegna del relax in Polinesia, magari dopo un lungo e duro anno di eventi e lavoro. Così come la storia delle popolazioni preistoriche vissute in determinati siti geografici.
Palafitte: storia e fascino delle antiche abitazioni sull’acqua
Cosa sono le palafitte? Definizione e caratteristiche
Le palafitte sono abitazioni utilizzate soprattutto nell’antichità e tuttora in uso presso alcune popolazioni africane, asiatiche e sudamericane. Si tratta di capanne di paglia, legno, canne, costruite su una piattaforma di legno sostenuta da pali del medesimo materiale infissi verticalmente sul fondo o sulla riva di fiumi, laghi, lagune, paludi o talvolta su terreno asciutto.
Perché veniva costruita una palafitta? Funzionalità e vantaggi
La necessità di costruzioni palafitticole, con pavimento sopraelevato in modo da essere asciutto, era dovuta a fattori topografici, così come climatici: ai tempi del Neolitico si sperimentò un periodo climatico asciutto e relativamente torrido, raggiungendo il picco durante l’età del bronzo: di conseguenza si ebbe un graduale e notevole abbassamento del livello dell’acqua. Da qui l’esigenza di costruire villaggi palafitticoli. Le palafitte offrono un’immagine di vita delle prime comunità agricole europee, e non solo. Informano circa le pratiche di allevamento e le innovazioni tecnologiche via via sperimentate. Costruire su palafitte aveva diversi vantaggi: protezione da animali feroci e da nemici, isolamento dall’umidità del terreno e, in alcuni casi, una migliore difesa in caso di inondazioni.
Tipologie di palafitte: dalla “palafitta su bonifica” alla “palafitta aerea”
I materiali principalmente usati per la costruzione di tali particolari e suggestive abitazioni furono il legno, la paglia o le canne di bambù. I pali verticali di sostegno erano tronchi d’albero, con forma tondeggiante e l’estremità inferiore tagliata a punta per poter essere infissa sul fondale o nel terreno. Spesso insorgeva poi l’esigenza di rinforzare questi pali con cumuli di pietrame. Col passar del tempo si giunse all’utilizzo di pali più grossi e robusti e a nuove tecniche costruttive, sempre più efficaci, spostando le costruzioni progressivamente dall’acqua alle rive dei laghi. La necessità di un continuo ricambio dei pali di legno che sostenevano le piattaforme urgeva quando questi non reggevano più il peso o marcivano per l’acqua. Tra le tipologie più note di palafitte – diversificatesi in base al posizionamento delle strutture, alle tecniche costruttive e al clima – si menzionano la “palafitta su bonifica”, realizzata in sponda allo specchio d’acqua, e la “palafitta aerea”, eretta invece sul pelo dell’acqua.
Palafitte nel mondo: una diffusione geografica ampia e variegata
Le palafitte sono diffuse presso popolazioni di diversi continenti stanziate sui laghi, lungo i fiumi e le coste e su terreno asciutto.
I villaggi palafitticoli in Europa e in Italia: un patrimonio UNESCO
Resti di palafitte e villaggi palafitticoli europei vennero in luce intorno al 1823 presso Zurigo. Le ricerche sistematiche però ebbero inizio un trentennio più tardi nei laghi svizzeri, quando la siccità aveva fatto ritirare gli specchi d’acqua. Resti di siti analoghi si ritrovarono anche in Inghilterra, Irlanda, Svezia e Prussia orientale. In Italia, invece, il primo ritrovamento di una palafitta risale al 1860 presso Mercurago, in provincia di Novara, dov’è attualmente presente il Parco naturale dei Lagoni di Mercurago. La Svizzera proliferava di stazioni palafitticole sin dal Neolitico, dove i folti boschi lasciavano come spazi per le dimore umane solo gli specchi d’acqua. Così anche in Francia occidentale, Belgio, Germania ed Europa centro-orientale, fino a Boemia e Croazia. In Italia i villaggi palafitticoli sorsero ai piedi delle Alpi e nella bassa Lombardia. All’età del bronzo risalgono le palafitte di Solferino, in provincia di Mantova, e alla fase finale quelle di Peschiera del Garda, in provincia di Verona.
Le palafitte in Asia, America e Africa
I centri palafitticoli di maggiore diffusione negli altri continenti sorgevano in Indocina, Indonesia e Nuova Guinea, nel continente asiatico; in America proliferavano nelle tribù del Nord-Ovest, nel Golfo del Messico e nel Mar Caraibico; in Africa nei bacini del Congo, Niger e Alto Nilo. Tuttora tali dimore sono molto diffuse nelle isole della Malesia e in generale nelle zone tropicali umide. In Africa la dimora su pali è spesso associata a strutture cilindriche a tetto conico, piuttosto che a strutture quadrangolari. Sulle Alpi oggi le palafitte sono conosciute come “Raccard”, e utilizzate come granai. In Inghilterra tali costruzioni sono immesse su pietre chiamate “Staddle Stones”, piuttosto che su pali in legno, sempre abbastanza elevate per evitare l’incursione dei roditori al grano.
Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro: un viaggio nella preistoria
Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, situato nella suggestiva cornice dell’età del bronzo, è un luogo che ci trasporta indietro nel tempo. Fondato negli anni ’70 e ospitato nella sede territoriale del MUSE – Museo delle Scienze, questo museo offre ai visitatori l’opportunità di immergersi nella vita quotidiana di un villaggio palafitticolo (2.200-1350 a.C.) scoperto sulla sponda orientale del lago. Nel 2011, questo straordinario sito è stato riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO. Le Palafitte di Ledro, dopo essere rimaste sommerse per migliaia di anni, sono riemerse nell’autunno del 1929 quando il livello del lago è stato abbassato per la costruzione di una centrale idroelettrica a Riva del Garda. Questo evento ha rivelato oltre diecimila pali, testimonianza di uno dei più grandi insediamenti preistorici in Italia e in Europa. Nel 2019, grazie a un significativo investimento della Provincia autonoma di Trento, il museo e il suo edificio sono stati completamente rinnovati. L’edificio ha ottenuto la prestigiosa Certificazione LEED® livello “GOLD”, riconoscimento internazionale per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Questo riflette l’impegno del governo locale nella promozione della cultura, del patrimonio e della storia in tutto il territorio trentino. All’interno del museo, i visitatori possono ammirare una straordinaria collezione di manufatti artigianali provenienti dal villaggio palafitticolo, uno dei più importanti dell’arco alpino. Quattro capanne ricostruite, arredate con precisione storica, offrono un’immersione autentica nella vita quotidiana dell’età del bronzo, consentendo ai visitatori di scoprire come vivevano i nostri antenati.
L’allestimento interno del museo è stato progettato con concetti come dinamismo, trasparenza, leggerezza e inclusione, creando uno spazio senza confini e percorsi obbligati. Il museo esplora quattro temi principali, dall’ampia prospettiva delle palafitte come fenomeno europeo, fino alla vita nel villaggio, agli individui e alle loro attività quotidiane durante l’età del bronzo. Tra i reperti esposti, spiccano manufatti di origine vegetale, gioielli in bronzo, una maestosa canoa scolpita da un unico tronco di abete lungo oltre 5 metri e antichi pani che rivelano la storia millenaria dell’arte della panificazione. Inoltre, il museo fa parte di ReLED, una rete museale nella Valle di Ledro che offre una varietà di esperienze culturali e educative. Questa rete comprende musei dedicati all’archeologia, alla botanica, alla storia, all’etnografia, alla zoologia e ad antichi mestieri, offrendo laboratori, attività e visite guidate per grandi e piccini.
I siti palafitticoli in Italia: un’eredità da scoprire
Esistono autentici siti palafitticoli archeologici, ben 111 localizzati sulle Alpi europee. I principali centri palafitticoli rientrano dal 2011 nella “World Heritage List” dell’UNESCO. Di questi, ben 19 appartengono all’Italia, dislocati tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. I siti archeologici si rinvengono in prossimità di zone particolarmente umide, come i laghi. In Italia, ad esempio, è possibile ammirare tale splendida eredità preistorica presso il Lago di Varese, così come Desenzano del Garda, Peschiera del Garda, Piadena e Monzambano, per citarne alcuni. Tali siti palafitticoli costituiscono autentiche fonti per lo studio delle prime società agrarie di questi luoghi, mostrando l’utilizzo di risorse territoriali e marine, proprie della cultura europea che abbraccia il periodo storico che dal Neolitico giunge all’età del bronzo.
Palafitte moderne: un’architettura che resiste al tempo
Sebbene le palafitte siano spesso associate alla preistoria, questo tipo di architettura continua a essere utilizzato anche in epoca moderna. Nelle zone soggette a inondazioni o con terreni instabili, le palafitte moderne offrono una soluzione abitativa sicura ed efficiente. Inoltre, in alcune località turistiche, come la Polinesia, le palafitte sono diventate un simbolo di lusso e di vacanze esclusive. In definitiva l’architettura palafitticola restituisce fascino e storia, definendo le particolari dimore su pali di legno infissi al suolo acquitrinoso o asciutto in base a fattori topografici e/o climatici, così come per la funzionalità quotidiana e lavorativa di conservare e proteggere le provviste. Bellezza e praticità unite nella medesima tipologia costruttiva.
Conclusioni: le palafitte tra passato e presente
Le palafitte rappresentano un’affascinante testimonianza del passato, un esempio di come l’ingegno umano si sia adattato alle sfide dell’ambiente. Dai villaggi palafitticoli preistorici alle moderne abitazioni su pali, le palafitte continuano a esercitare un fascino senza tempo, dimostrando la loro validità come soluzione abitativa in diversi contesti geografici e culturali.
Fonte immagine in evidenza: https://pixabay.com/it/photos/palafitte-2514170/