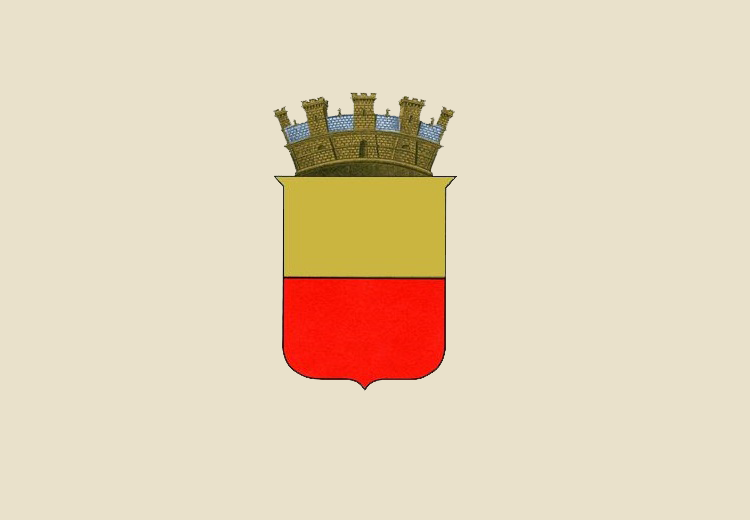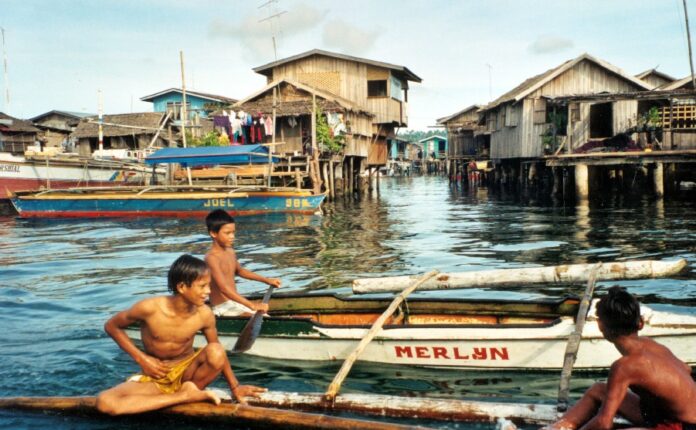Il senso del pellegrinaggio con le sue incognite sta nel lasciare sicurezza e stabilità, per affrontare una novità carica di imprevedibile.
«Peregrini si possono intendere in due modi, in uno largo e in uno stretto: in largo, in quanto è peregrino chiunque è fuori della sua patria». All’interno della Vita nova, Dante Alighieri specifica alcuni dettagli sullo status del pellegrino: per l’uomo del Medioevo è chiunque si trovi lontano dalla propria casa e dalle sue sicurezze. Ma come nasce storicamente questa pratica?
Indice dei contenuti
Le 3 grandi mete del pellegrinaggio medievale (Peregrinationes Maiores)
| Meta | Significato e simbolo del pellegrino |
|---|---|
| Gerusalemme | Luogo della vita e passione di Cristo, considerata il centro del mondo. Il pellegrino era il palmarius (portava una foglia di palma). |
| Roma | Sede del Papato e luogo del martirio degli apostoli Pietro e Paolo. Il pellegrino era il romeus (portava le chiavi di San Pietro). |
| Santiago de Compostela | Luogo della tomba dell’apostolo Giacomo, simbolo della lotta contro l’Islam. Il pellegrino portava la conchiglia (vieira). |
Genesi e finalità del pellegrinaggio
Quello del “pellegrinaggio” è un fenomeno comune a tutte le grandi religioni che abbiano elaborato il concetto di “luogo sacro”. Il pellegrinaggio non ha finalità turistiche, ma culturali, di devozione o penitenza: l’uomo del Medioevo è homo viator, uomo viaggiatore, che trova appagamento nel mettersi al servizio di Dio e nel rinnovarsi profondamente. Spesso, il peregrinus parte per adempiere un voto, espiare un crimine, ottenere indulgenze o cercare una guarigione.
Le grandi mete della cristianità
Storicamente, la pratica si lega alla venerazione per i luoghi santificati da Cristo e per le sepolture di apostoli e martiri, come i santuari del culto micaelico e la tomba di Giacomo a Santiago de Compostela. L’emergere di queste forme devozionali favorisce lo sviluppo del culto dei santi, alle cui reliquie sono attribuite virtù taumaturgiche. Fin dal II secolo, i luoghi più frequentati sono le catacombe romane e le memorie neotestamentarie di Gerusalemme.
Il momento di maggiore intensità del pellegrinaggio verso la Terrasanta coincide con la distruzione del Santo Sepolcro nel 1009, che costituisce la premessa alla prima crociata, un vasto pellegrinaggio armato della cristianità occidentale. Coloro che partivano, infatti, definivano se stessi “pellegrini”, non “crociati”.
La Via Francigena e i diari di viaggio

Dopo la definitiva perdita di Gerusalemme nel 1244 e l’istituzione del Giubileo da parte di Bonifacio VIII nel 1300, il pellegrinaggio verso Roma diventa il più importante del cristianesimo occidentale. Per collegare Roma al Nord Europa, si afferma una direttrice appenninica interna che dal IX secolo è indicata come Via Francigena, per l’origine di chi la transitava o perché conduceva in Francia.
I pellegrinaggi hanno prodotto una mole di resoconti scritti, o Itineraria, ad uso dei futuri viaggiatori, con informazioni su percorsi, tappe e alloggi. Notevole è l’Itinerarium Egeriae, un testo di fine IV secolo in cui una pellegrina descrive il suo viaggio in Egitto, Palestina e Mesopotamia, una preziosa testimonianza dell’evoluzione del latino tardo.
Pertanto, il fenomeno del pellegrinaggio nel medioevo è legato al desiderio di sperimentare una fede in cammino. Il raggiungimento della meta vuole esemplificare l’incontro tra umano e divino. La fede, infatti, ha bisogno di luoghi, ma non necessariamente di andarvi. Ogni pellegrinaggio altro non è che l’avventura stessa della vita.
Altre informazioni e curiosità sul pellegrinaggio nel Medioevo
Chi erano i pellegrini nel Medioevo?
I pellegrini provenivano da ogni ceto sociale: nobili, cavalieri, mercanti, artigiani e contadini. Il loro abbigliamento era distintivo: indossavano un mantello ruvido (la “pellegrina”), un cappello a tesa larga per proteggersi dal sole e dalla pioggia, un bastone (il “bordone”) per aiutarsi nel cammino e una bisaccia (“scarsella”) per le provviste.
Perché si faceva il pellegrinaggio nel Medioevo?
Le motivazioni erano diverse e spesso intrecciate. Si partiva per devozione (per venerare una reliquia o un luogo santo), per penitenza (per espiare peccati gravi, a volte imposto come condanna da un tribunale ecclesiastico), per chiedere una grazia (come una guarigione da una malattia) o per adempiere a un voto fatto in un momento di difficoltà.
Quanto durava un pellegrinaggio?
La durata dipendeva dalla distanza e dai mezzi. Un viaggio a piedi da Parigi a Roma poteva richiedere mesi. Un pellegrinaggio a Gerusalemme era un’impresa che poteva durare anche più di un anno, includendo lunghi tratti in nave. Era un viaggio pericoloso, esposto a briganti, malattie e intemperie, che richiedeva una grande preparazione fisica e spirituale.
Immagine in evidenza per l’articolo sul pellegrinaggio nel medioevo tratta da Wikipedia
Articolo aggiornato il: 30/08/2025