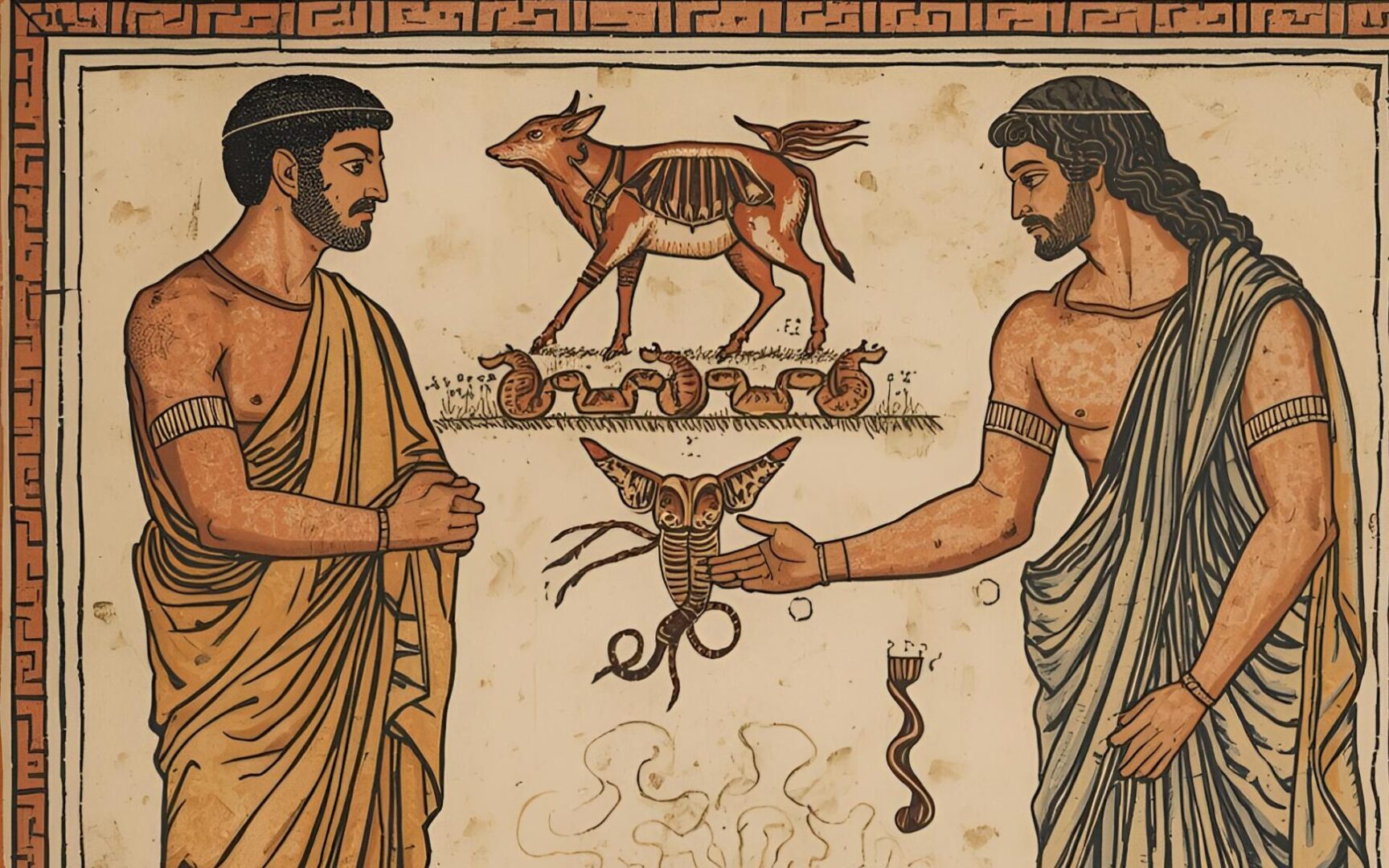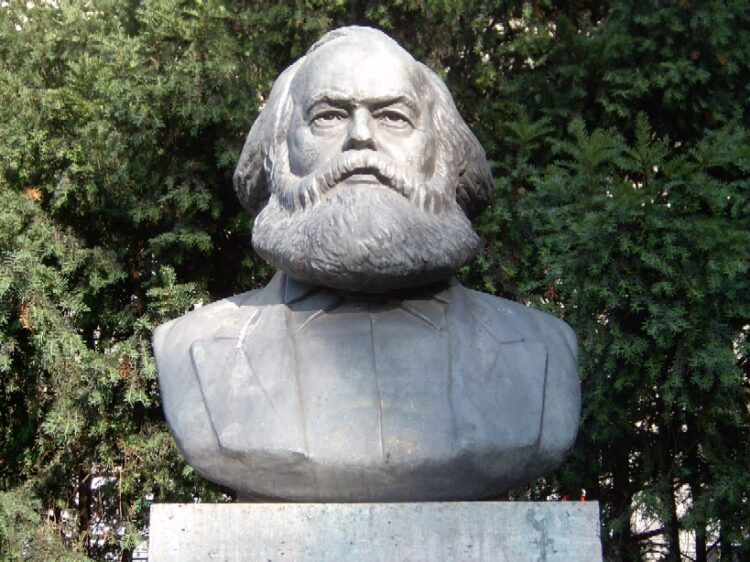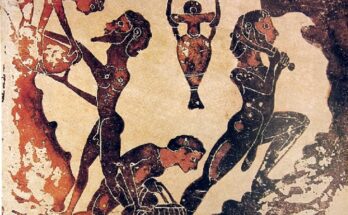Il modello valenziale offre un approccio innovativo allo studio della grammatica, superando la visione tradizionale che la considera solo un insieme di regole per non commettere errori. Questa teoria si fonda su un principio fondamentale: il verbo è il motore che attiva e organizza la costruzione mentale della frase. Per comprendere il funzionamento della lingua, è essenziale riconoscere la funzione centrale del verbo, e la valenza è il criterio che ci permette di farlo.
In questo approfondimento:
Cos’è la grammatica valenziale in sintesi
| Aspetto | Descrizione |
|---|---|
| Definizione | Un modello di analisi della frase che si basa sulla capacità del verbo di legare a sé un certo numero di elementi necessari (argomenti). |
| Fondatore | Il linguista francese Lucien Tesnière (1893-1954). |
| Principio chiave | Il verbo è il nucleo centrale della frase; tutti gli altri elementi dipendono da esso e dalla sua “valenza”. |
| Concetti principali | Valenza, argomenti (o attanti), espansioni (o circostanti). |
Il principio chiave: il verbo al centro della frase
La grammatica valenziale rappresenta la struttura della frase secondo uno schema radiale, non lineare. Al centro c’è il verbo, che agisce come un nucleo atomico. Da esso si diramano gli elementi indispensabili per completarne il significato.
Nucleo ed elementi extranucleari
- Il Nucleo: è formato dal verbo e dai suoi argomenti, cioè gli elementi obbligatori richiesti dal significato del verbo stesso (es. in “Paolo mangia una mela”, “Paolo” e “una mela” sono argomenti del verbo “mangiare”).
- Elementi Extranucleari: sono le espansioni (o circostanti), cioè elementi facoltativi che aggiungono informazioni ma non sono essenziali per la struttura della frase (es. in “Paolo mangia una mela in cucina“, “in cucina” è un’espansione).
Le classi di verbi secondo la valenza (con esempi)
Applicando il modello valenziale, i verbi italiani si classificano in base al numero di argomenti che richiedono. Questa classificazione non coincide con la distinzione tradizionale tra verbi transitivi e intransitivi.
| Classe di Verbo | Argomenti richiesti | Esempio |
|---|---|---|
| Verbi zerovalenti | Nessun argomento | Verbi meteorologici: Piove. Nevica. |
| Verbi monovalenti | Un argomento (soggetto) | Mario dorme. Il cane abbaia. |
| Verbi bivalenti | Due argomenti | Luca legge un libro. Sara abita a Roma. |
| Verbi trivalenti | Tre argomenti | Anna regala un fiore a Maria. |
| Verbi tetravalenti | Quattro argomenti (rari) | Paolo traduce un libro dall’inglese all’italiano. |
Le origini del modello: da Aristotele a Tesnière
Sebbene il modello valenziale sia considerato una “novità” didattica, le sue radici sono antiche. Già Aristotele aveva intuito il ruolo centrale del verbo. L’idea fu ripresa nel Rinascimento da autori come Machiavelli. Il vero fondatore della grammatica valenziale moderna è il linguista francese Lucien Tesnière, che nella sua opera postuma Éléments de syntaxe structurale (1959) ha formalizzato la teoria. Tesnière definì gli argomenti “attanti”, un termine ancora usato in linguistica.
Domande Frequenti (FAQ)
Perché si chiama grammatica “valenziale”?
Il termine “valenza” è preso in prestito dalla chimica. Come un atomo ha una certa valenza che gli permette di legarsi a un numero definito di altri atomi, così un verbo ha una valenza che determina quanti argomenti (soggetto, oggetto, ecc.) deve legare a sé per formare una frase di senso compiuto.
La grammatica valenziale sostituisce l’analisi logica tradizionale?
Non la sostituisce, ma la integra con un approccio più scientifico e strutturato. L’analisi logica classifica i complementi, mentre la grammatica valenziale distingue tra elementi necessari (argomenti) ed elementi accessori (espansioni), offrendo una visione più chiara della gerarchia all’interno della frase.
Quali sono i vantaggi didattici di questo modello?
Il modello valenziale si è rivelato molto efficace a scuola perché aiuta gli studenti a comprendere la struttura logica della frase in modo più intuitivo. La rappresentazione radiale e la centralità del verbo rendono più facile riconoscere le relazioni tra le diverse parti del discorso.
Fonte immagine: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 27/08/2025