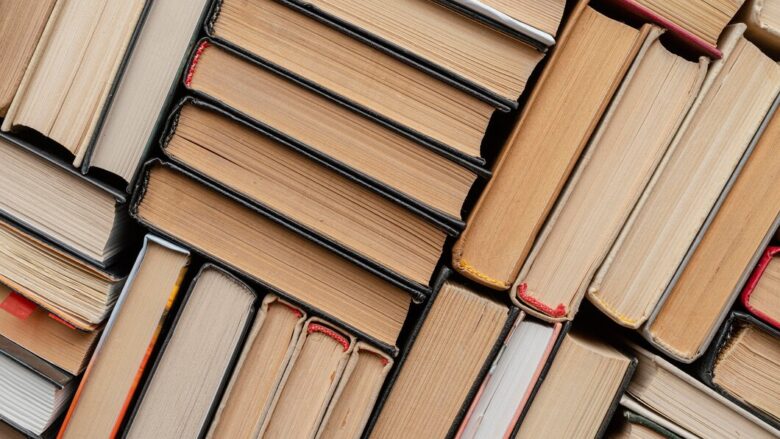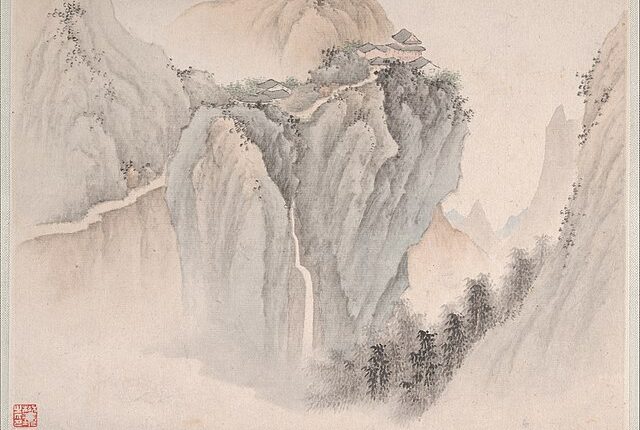Il modello valenziale non si fonda su principi che potrebbero essere definiti “tradizionali”, per quanto riguarda la concezione di grammatica, per cui questa deve essere studiata solo, per esempio, per non commettere errori nello scrivere; si pensa pure che essa non serva perché “astratta”, dato che viene studiata attraverso l’esercizio o utilizzo di frasi- standard.
Tale modello, al contrario di ciò, ha la sua base in un principio, secondo il quale il verbo è l’attivatore della costruzione mentale della frase.
Per capire e comprendere il funzionamento della lingua, è importante riconoscere e conoscere la funzione del verbo: la valenza è proprio un criterio per riconoscere tale funzione.
Il verbo, nella frase, costituisce il nucleo, assieme ai suoi argomenti, e il modello della grammatica valenziale permette di avere un approccio differente all’oggetto-frase e alla sua struttura, che è imperniata sul verbo; tale struttura può essere quindi rappresentata secondo uno schema radiale, con il verbo al centro che si arricchisce via via di altre “parti”, gli argomenti, quali le espansioni, legate al nucleo e che vengono considerate come “satelliti” della frase.
La rappresentazione secondo schemi radiali permette di capire le relazioni esistenti tra gli elementi componenti la frase, che di conseguenza non può essere presentata come qualcosa di lineare, poiché ciò non permetterebbe di cogliere le relazioni su citate.
Fra l’altro, la rappresentazione della frase data dal modello valenziale aiuta a comprendere tutto il sistema della lingua ed essa può essere definita ordinata, principalmente perché centrata sul verbo e rappresentativa del rapporto tra morfologia e sintassi.
Attraverso il modello valenziale cambia dunque la visione della frase, la cui struttura è imperniata sul verbo, relativamente al quale è necessario tenere in considerazione le sue valenze, un’operazione, questa, collegata all’analisi semantica del verbo, che ne spiega proprio le variazioni della valenza.
Si potrebbe e si può affermare che il modello valenziale costituisce una “novità”, per ciò che concerne l’insegnamento/apprendimento della grammatica; in realtà, esso ha delle origini che possono essere fatte risalire ad Aristotele, il quale mise in evidenza il meccanismo che porta il verbo a “costruire”, avvalendosi dell’ausilio dei nomi, elementi, questi, che sono o meglio rappresentano il primo “appoggio” al verbo nella sua azione di costruzione.
Il principio “postulato” da Aristotele venne ripreso nel Rinascimento, in particolare da Machiavelli, il quale nella sua opera Discorso sulla lingua vede nel verbo l’elemento fondamentale della lingua che ci porta a capire i nomi e la loro funzione.
Colui che comunque è ritenuto il fondatore della grammatica valenziale è il linguista francese Lucien Tesnière, che con il suo modello della grammatica valenziale ha fornito un riferimento importante per la descrizione di qualsiasi lingua. In relazione agli elementi che sono di “appoggio” al verbo, Tesnière parla di attanti, mentre gli studiosi italiani hanno utilizzato il termine argomenti.
Se si applica il modello valenziale alla lingua italiana, vengono distinte cinque “classi” di verbi (distinzione, questa, che non ha un riscontro nei concetti tradizionali di transitività e intransitività), in base al numero di argomenti:
- Verbi zerovalenti, con nessun argomento ( per esempio, i verbi legati ai fenomeni atmosferici);
- Verbi monovalenti, con una valenza che richiede un argomento;
- Verbi bivalenti, con due valenze/ due argomenti;
- Verbi trivalenti, con tre valenze/ argomenti;
- Verbi tetravalenti, richiedenti quattro argomenti.
Il modello della grammatica valenziale fornisce un’immagine articolata della frase, è un modello scientifico, perché spiega, chiarisce, grazie a semplicità e sinteticità; negli ultimi anni, è stato adottato e si è rivelato didatticamente efficace, grazie agli aspetti che lo caratterizzano e che permettono di raggiungere uno degli obiettivi fondamentali dell’insegnamento grammaticale, cioè il riconoscimento delle proprietà di una lingua e dei fenomeni presenti nella morfologia e nella sintassi di qualsiasi lingua.
Fonte immagine articolo Grammatica valenziale: un approccio differente all’oggetto-frase: Wikipedia