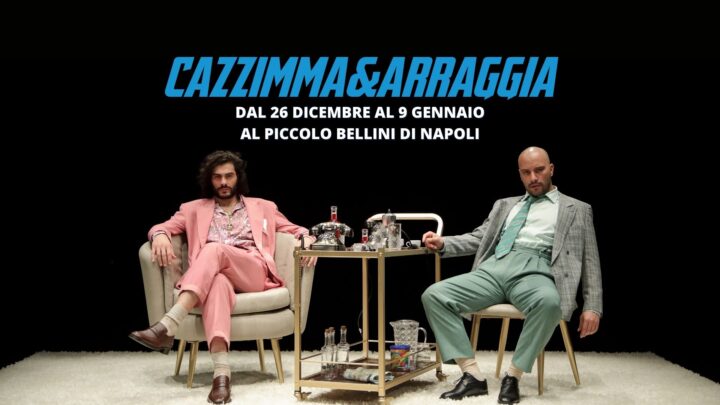Diretto da Augusto Fornari e con l’interpretazione di Biagio Izzo L’arte della truffa è in scena al teatro Augusteo di Napoli dal 12 al 19 Maggio e poi, il 22 e il 24 maggio.
Il cast della commedia
L’arte della truffa è il nuovo spettacolo andato in scena al teatro Augusteo di Napoli con Biagio Izzo. Nel cast della rappresentazione, inoltre, sono presenti anche gli attori: Carla Ferraro, Roberto Giordano, Ciro Pauciullo, Arduino Speranza e Adele Vitale. La commedia è stata scritta da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, e Vincenzo Sinopoli. La regia dello spettacolo invece è curata da Augusto Fornari. La scenografia della pièce porta la firma di Massimo Comune, il disegno luci è realizzato da Luigi Raia, le musiche sono prodotte dal Gruppo SMP, i costumi sono stati creati da Federica Calabrese e, infine, la produzione esecutiva è di Giacomo Monda.
Il plot de L’arte della truffa
La commedia L’arte della truffa rappresentata sul prestigioso palco dell’Augusteo, da domenica 12 fino al 19 Maggio e poi, in seguito, il 22 e il 24 maggio, vede Biagio Izzo come interprete principale di una serie di gag e parentesi comiche brillanti, ma, a tratti, anche riflessive e introspettive, quasi a voler offrire allo spettatore un “tocco” ed uno spunto di profondità, nonostante il clima, in gran parte, spassoso e ameno.
Il titolo dell’opera, L’arte della truffa, si riferisce, in ogni caso, ad una stravagante e peculiare truffa all’italiana, che, potremmo descrivere, infatti, anche come una sorta di “imbroglio-spaghetti western”, dunque con modi e contenuti tutti “nostrani”, insomma, con mezzi assai maldestri, ma in compenso col cuore grande, che ben si addicono, tra l’altro, ai temi cari della “commedia all’italiana”.
Le trovate comiche dello spettacolo
La coppia protagonista della storia, formata da Gianmario e dalla sua consorte Stefania, è scombussolata d’improvviso dall’arrivo dello tsunami-Francesco, il fratello criminale di Stefania, che i coniugi dovranno accogliere nella propria abitazione per fare in modo che possano essergli concessi gli arresti domiciliari.
Così il saggio, clericale, prudente e previdente Gianmario, che lavora per il Vaticano, sarà costretto a fronteggiare la considerevole sfida, apportata alla sua vita sentimentale e lavorativa da parte del cognato Francesco. Impenitente e veterano frodatore, egli non impiegherà molto a mettere a repentaglio la serenità del primo, con le sue battute e le sue uscite impudenti e irriverenti, in un susseguirsi di trovate buffe e sketch esilaranti, che divertono da morire la platea, travolgendola in un vortice di buonumore e simpatia, assolutamente irresistibile. Eppure, un’improvvisa quanto insospettabile contrarietà finanziaria condurrà il povero e malcapitato Gianmario a necessitare proprio della tecnica infallibile di suo cognato, Francesco.
L’arte della truffa, promosso!
Insomma, un grande e insuperabile Biagio Izzo ancora una volta in forma smagliante non potrà di certo lasciarvi indifferenti. Spettacolo consigliatissimo per tutta la famiglia!
Fonte immagine: profilo Facebook ufficiale del Teatro Augusteo