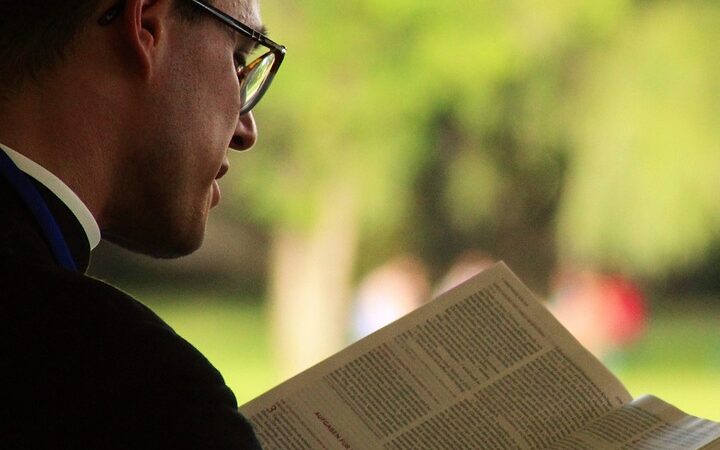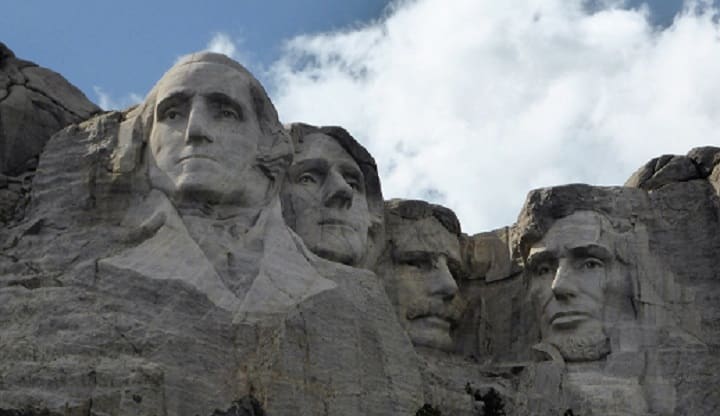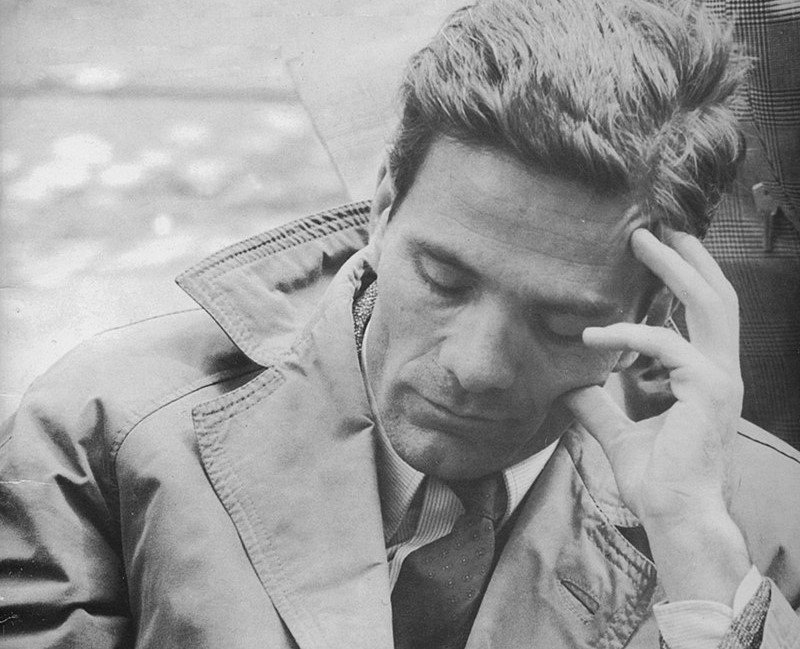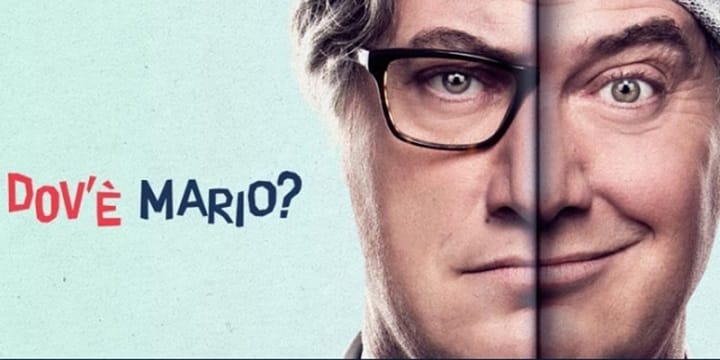L’arte dell’omiletica (dal greco homiletikè, derivato da homilia, “conversazione”) è la disciplina, interna agli studi teologici, che insegna come comporre e recitare un discorso sacro. Essa comprende tutte le forme di oratoria sacra, dalla predicazione all’istruzione catechistica, con un’attenzione particolare all’omelia, ovvero la spiegazione e attualizzazione della parola di Dio proclamata durante la liturgia. Questa disciplina antica non si limita agli aspetti tecnici della comunicazione, ma include anche la dimensione teologica, spirituale e pastorale. Chi la pratica, infatti, deve possedere una solida formazione biblica e una profonda conoscenza del contesto in cui si rivolge.
Indice dei contenuti
1. Definizione: l’omiletica tra teologia e retorica
L’omiletica si occupa della composizione ed esposizione dei discorsi religiosi. Sebbene il termine sia spesso usato in senso lato, è importante distinguere tra omelia e predica (o sermone). L’omelia è strettamente legata alla liturgia e commenta le letture bibliche del giorno; la predica è un discorso che può trattare un argomento teologico o morale specifico, anche al di fuori della celebrazione. L’omiletica, quindi, è una disciplina che si interseca con l’esegesi biblica, la teologia e la retorica classica, richiedendo competenze di contenuto, forma e sensibilità pastorale.
2. L’evoluzione della predicazione cristiana: una timeline
La storia dell’omiletica mostra un’evoluzione costante, adattandosi ai contesti culturali e alle esigenze pastorali di ogni epoca.
| Periodo storico | Caratteristiche e finalità dell’omiletica |
|---|---|
| Origini bibliche (antico e nuovo testamento) | Predicazione profetica e apostolica. Lo scopo è annunciare il messaggio di dio e chiamare alla conversione. |
| Patristica (II-V secolo) | Sintesi tra esegesi biblica (Origene) e retorica classica (Agostino). Lo scopo è istruire i fedeli nella dottrina. |
| Medioevo (XII-XIV secolo) | Nascita delle “artes praedicandi”. Lo scopo è educare, persuadere e commuovere il popolo, anche con tecniche teatrali. |
| Riforma e controriforma (XVI secolo) | La predicazione diventa centrale. Lo scopo è affermare la dottrina (protestante) o contrastare le eresie (cattolica). |
| Età contemporanea | Dialogo con la teoria della comunicazione e i nuovi media. Lo scopo è rendere il messaggio evangelico rilevante per l’uomo di oggi. |
3. Le origini bibliche e patristiche
Le radici dell’omiletica affondano nella Bibbia. Nell’Antico Testamento, i profeti si presentavano come portavoce di Dio, usando oracoli e azioni simboliche. Nel Nuovo Testamento, Gesù stesso dedica gran parte del suo ministero alla predicazione. Nei secoli successivi, i Padri della Chiesa hanno gettato le basi dell’omiletica cristiana. Origene (185-254) fu un modello per il suo metodo di predicazione sistematica, versetto per versetto. Un contributo fondamentale venne da Sant’Agostino, che nel suo De doctrina christiana integrò la retorica ciceroniana con le esigenze della predicazione, sostenendo che il predicatore deve docere, delectare et movere (insegnare, dilettare e commuovere), come evidenziato in diverse analisi della Santa Sede.
4. Il medioevo e la nascita delle artes praedicandi
Nel Medioevo, l’omiletica assunse un nuovo obiettivo sociale: educare il popolo e definire un codice comportamentale. Per rispondere alle esigenze di un pubblico più vasto e spesso analfabeta, nacquero le artes praedicandi, manuali che insegnavano a rendere i sermoni più persuasivi. Si introdussero dialoghi, exempla (brevi racconti morali), e una forte componente performativa, con modulazione della voce e gestualità quasi teatrale. In questo contesto, figure come San Francesco d’Assisi (XIII secolo) rivoluzionarono lo stile della predicazione. Egli, fondatore dell’ordine francescano, basò la sua missione su una predicazione semplice, diretta e incentrata sull’esempio concreto di vita evangelica.
5. L’omiletica dalla riforma all’età contemporanea
Con la Riforma protestante, la predicazione divenne ancora più centrale, considerata dai riformatori come Martin Lutero il principale mezzo di trasmissione della fede. Anche la Chiesa cattolica, con il Concilio di Trento (1545-1563), ribadì l’importanza della formazione del clero e della predicazione per contrastare le eresie. Col passare dei secoli, l’omiletica ha continuato a evolversi. Oggi si confronta con le teorie della comunicazione e i nuovi media, cercando di rendere il messaggio evangelico comprensibile e rilevante per la società contemporanea, come sottolineato da documenti come la Sacrosanctum Concilium, che definisce l’omelia “parte integrante dell’azione liturgica” (SC 52, fonte vatican.va).
Fonte immagine in evidenza: Pixabay
Articolo aggiornato il: 15/09/2025