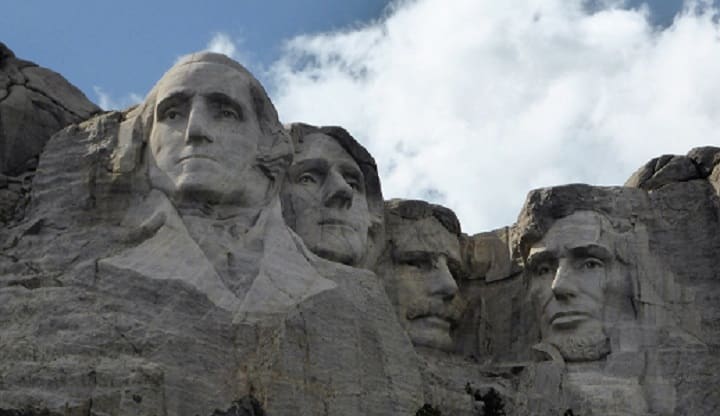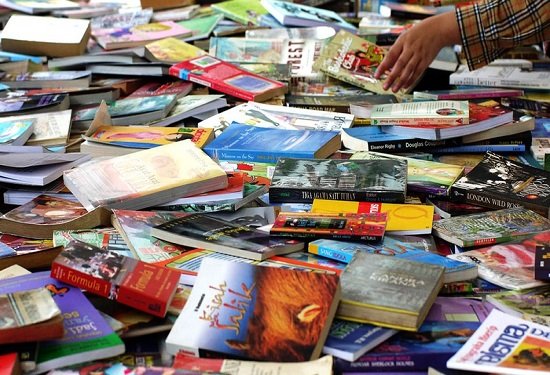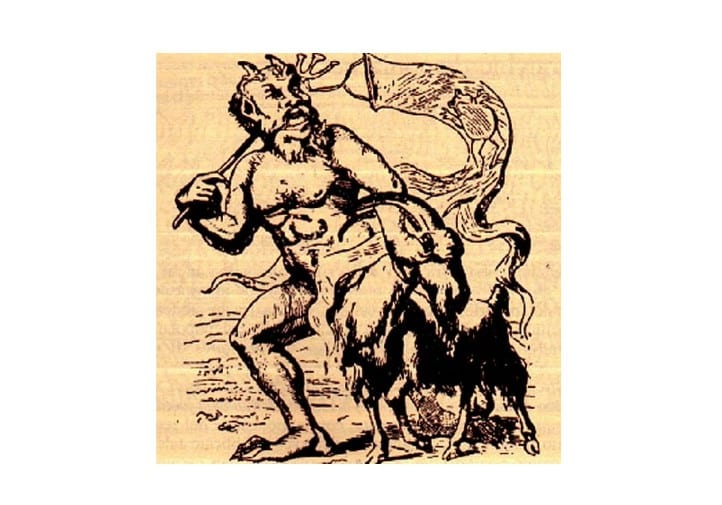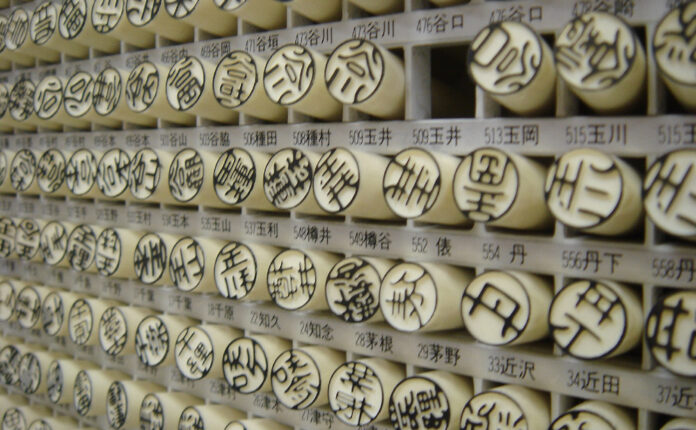Negli ultimi anni si sente spesso parlare di cultura dello stupro, un’espressione nata negli studi di genere e nella letteratura femminista degli anni ’70 per indicare un contesto sociale in cui lo stupro e altre forme di violenza sessuale sono comuni, normalizzate e persino minimizzate. Non si fa riferimento solo all’atto criminale in sé, ma a tutto quell’insieme di credenze e comportamenti che incoraggiano l’aggressività maschile e supportano la violenza contro le donne.
Indice dei contenuti
La cultura dello stupro in Italia: i dati e i fatti di cronaca
Il tema è diventato centrale in seguito a gravi fatti di cronaca come lo stupro di gruppo di Palermo e le violenze a Caivano. Questi eventi drammatici si inseriscono in una realtà allarmante: secondo i dati Istat, quasi una donna su tre (31,5%) ha subìto nel corso della vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi, come lo stupro e il tentato stupro, sono state commesse nel 62,7% dei casi da un partner o ex partner. Questi numeri, che rappresentano solo i casi emersi e non il sommerso, evidenziano come la violenza sia un fenomeno sistemico e non una serie di episodi isolati.
Il ruolo del linguaggio nel normalizzare la violenza
Come si può cambiare questa realtà? Un punto di partenza fondamentale riguarda l’uso consapevole del linguaggio, poiché esso svolge un ruolo determinante nell’istituire e mantenere viva una cultura. Le parole che usiamo quotidianamente possono rinforzare stereotipi e pregiudizi. Esempi evidenti sono le metafore che riducono la donna a oggetto, come preda da cacciare o dessert da consumare, o le cosiddette “battute” che minimizzano la gravità della violenza. Anche il catcalling e l’uso di insulti misogini contribuiscono a creare un ambiente in cui la donna è costantemente oggettificata e la sua volontà sminuita. Restare in silenzio di fronte a queste manifestazioni verbali rende complici della loro diffusione.
La colpevolizzazione della vittima: cos’è il victim blaming
Un meccanismo centrale della cultura dello stupro è il victim blaming, ovvero la tendenza a colpevolizzare, parzialmente o totalmente, la vittima per la violenza subita. Si manifesta attraverso domande e commenti che spostano l’attenzione dal carnefice alla persona offesa: “come eri vestita?”, “perché eri lì a quell’ora?”, “avevi bevuto?”. Queste insinuazioni, spesso presenti nel dibattito mediatico e persino nelle aule di tribunale, trasferiscono la responsabilità dell’aggressione e rafforzano stereotipi dannosi. La frase “se l’è cercata” è l’espressione più rappresentativa di questo processo, che causa una vittimizzazione secondaria e scoraggia le denunce.
| Linguaggio della cultura dello stupro | Linguaggio del rispetto e del consenso |
|---|---|
| “Se l’è cercata con quel vestito”. | “L’abbigliamento non è mai un invito né una giustificazione”. |
| “Era ubriaca / sotto l’effetto di droghe”. | “Uno stato alterato rende una persona vulnerabile, non consenziente”. |
| “Perché non ha detto ‘no’ più chiaramente?”. | “Il consenso deve essere esplicito, entusiasta e continuo. L’assenza di un ‘no’ non è un ‘sì'”. |
| “È un raptus / un momento di follia”. | “La violenza sessuale è un atto di potere e controllo, non una perdita di lucidità”. |
Come contrastare la cultura dello stupro
Liberarsi da questo vortice di violenza richiede un impegno collettivo. A livello istituzionale, è fondamentale promuovere l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, incentrata sul concetto di consenso. Nel nostro quotidiano, ognuno di noi può fare la differenza non restando in silenzio, correggendo il linguaggio che minimizza la violenza e schierandosi sempre dalla parte della vittima. Come suggerito da organizzazioni come Amnesty International, credere ai sopravvissuti è il primo passo per smantellare un sistema che li colpevolizza. La lotta è ancora lunga, ma non si può restare fermi ad assistere.
Fonte immagine in evidenza: Pixabay
Articolo aggiornato il: 19/09/2025