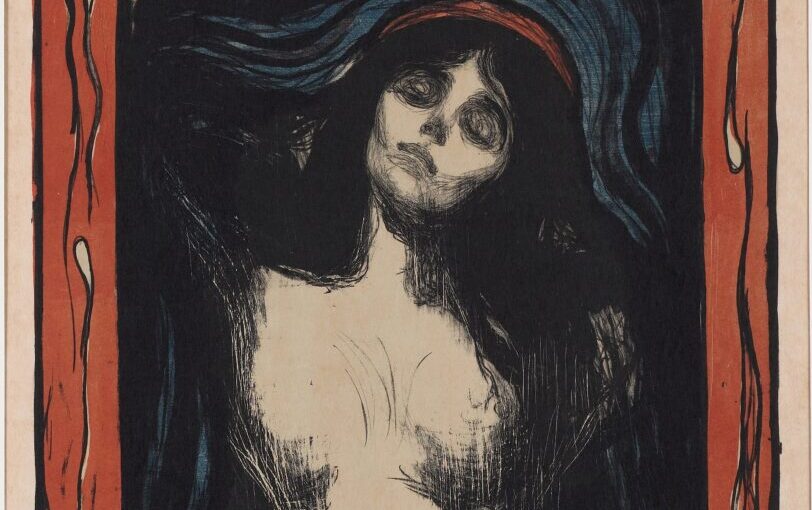Il “Genji Monogatari Emaki” (源氏物語絵巻) costituisce una delle più rilevanti testimonianze pervenuteci della pittura Yamato-e (大和絵), di epoca Heian. L’emaki-mono (絵巻物) o “rotolo orizzontale illustrato”, infatti, rappresentava il prodotto artistico che più di tutti si poneva di esemplificare le istanze provenienti dal nuovo modo di concepire l’arte e la pittura. Essa assolveva al compito di creare un contenuto identitario, eminentemente giapponese, attingendo al patrimonio mitico e letterario della tradizione nipponica e, di conseguenza, distaccandosi da soggetti e ambientazioni propri della pittura Kara-e (唐絵), proveniente dalla Cina.
La storia del Principe Genji, prodotta dalla stupefacente “penna” della dama di corte Murasaki Shikibu, è raffigurata sin dal XII secolo, nell’opera riconosciuta come il “Genji Monogatari Emaki“, dal valore inestimabile. Ci sono pervenuti circa venti frammenti, appartenenti a dodici capitoli delle cinquantaquattro sezioni del racconto scritto. Alcuni studiosi sostengono che anticamente fosse stata riprodotta almeno una scena per ciascun capitolo, ma che, col tempo, alcuni frammenti si siano perduti o siano stati soggetti a perimento, a causa della fragilità di un materiale come l’emaki. Ad ogni parte dipinta è intervallata una parte di testo scritto, in hiragana (il sistema grafico tipicamente giapponese), esempio di scrittura onna-de (女手), letteralmente “mano di donna” sta ad indicare una produzione associata al tratto femminile e che constava di alcune caratteristiche peculiari ben codificate, tanto nella scrittura quanto nell’arte. Da qui comprendiamo che il connubio tra letteratura e pittura non sia un mero fatto formale, un ponte di comunicazione tra le varie arti, i cui esempi abbondano fin dai tempi antichi. In questo caso, il dialogo si fa sostanza poiché scrittura e immagine condividono lo stesso spazio, non più solo ideale. In aggiunta, un genere letterario misto tra prosa e poesia come l’Uta Monogatari (歌 物語), di cui il Genji Monogatari ne è tra i massimi esempi, può ben prestarsi a tal scopo.
A livello narrativo, parliamo di pittura “monoscenica”: le scene raffigurate non sono direttamente collegate tra loro e ciò ci induce a pensare che non è da rintracciare un solo artista dietro l’opera, ma un atelier che lavora collettivamente.
Elementi stilistici del Genji Monogatari Emaki
Ci sono degli elementi caratteristici che, a livello formale, sono necessari per leggere correttamente un’opera del genere.
- Per quanto concerne l’uso dei colori, soprattutto negli abiti si prediligono colori saturi e brillanti, ma essi non restituiscono alcuna profondità. Per tal motivo, si segue la tecnica dello “tsukuri-e“(作り絵), anche detta “pittura costruita“, che consiste in una serie di passaggi: dapprima bisogna delineare la scena nei suoi contorni, poi aggiungere i colori, il giallo, rosso, arancio, verde, e infine eseguire i dettagli. Così facendo, le linee originali vengono tracciate nuovamente in modo da far riemergere il disegno iniziale. Si tratta di un vero e proprio processo di stratificazione.
- Per la composizione prospettica viene utilizzata la tecnica del “fukinuki yatai” (吹抜屋台), o del “tetto scoperchiato“. Perché è chiamata così? Nel Genji Monogatari Emaki si nota nell’immediato che tetti, soffitti e pareti sono completamente assenti. Tuttavia, vengono conservati travi e paraventi interni. Il ruolo dello spettatore è fondamentale perché è come se fosse posto in un angolo al di sotto del tetto e avesse una visione dall’alto, sulla raffigurazione. Tutto ciò doveva servire a far entrare nel dipinto quanti più elementi possibili, cosa che si ricollega alla concezione di spazio legata al prodotto “emaki”. Ma possiamo ipotizzare anche un’altra ragione: questa tecnica potrebbe prefiggersi di simulare, nella raffigurazione, il senso della lettura giapponese, di una scrittura che procedeva dall’alto verso il basso e da destra a sinistra.
- La somiglianza tra tutti i personaggi rappresentati non è un caso. L’indeterminatezza delle figure non cela alcuna pretesa di realismo. Ciò è atto a favorire l’identificazione dello spettatore con personaggi solo archetipici. Infatti, nel romanzo di Murasaki Shikibu, l’ambientazione è volutamente lasciata vaga e rimane vaga anche nelle informazioni sui protagonisti dai vari capitoli: non se ne sa l’età, persino i nomi, spesso celati, le descrizioni non sono mai puntuali ma esse vengono rese attraverso metafore e paragoni. Come si può ricreare nella rappresentazione tale effetto? Dobbiamo parlare di “hikime kagibana” (引目鈎鼻), letteralmente “una linea per gli occhi e un gancio per il naso“, in altre parole, parliamo di soggetti ridotti al minimo della caratterizzazione. Sono spesso ritratti a tre quarti, al massimo di profilo, ma mai frontali.
- Un discorso più concettuale, ma che ha delle conseguenze sulla figurazione, è quello che riguarda le emozioni trasmesse da queste figure. L’ambiente della corte imperiale doveva essere assai ristretto e chiuso, tale prigione dorata è resa anche graficamente. I personaggi non esprimono emozioni attraverso espressioni facciali; perennemente nascosti dietro paraventi, sarebbe difficile anche solo intravederle, confacendo all’estetica del tempo che riteneva poco elegante la manifestazione di qualsiasi sensazione dell’individuo. Come vengono restituite, allora, le emozioni? Attraverso artefici della rappresentazione. Le diagonali, rese con le travi che spezzano l’angolo visuale, quanto più sono verticali, tanto più identificano un animo travagliato del soggetto ritratto.
- L’ambientazione in cui si svolge l’azione è sempre chiusa e interna al contesto cortese. Qualora si intravedesse il paesaggio circostante con terrazze e uscite, è sintomo di un momento di difficoltà.
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia