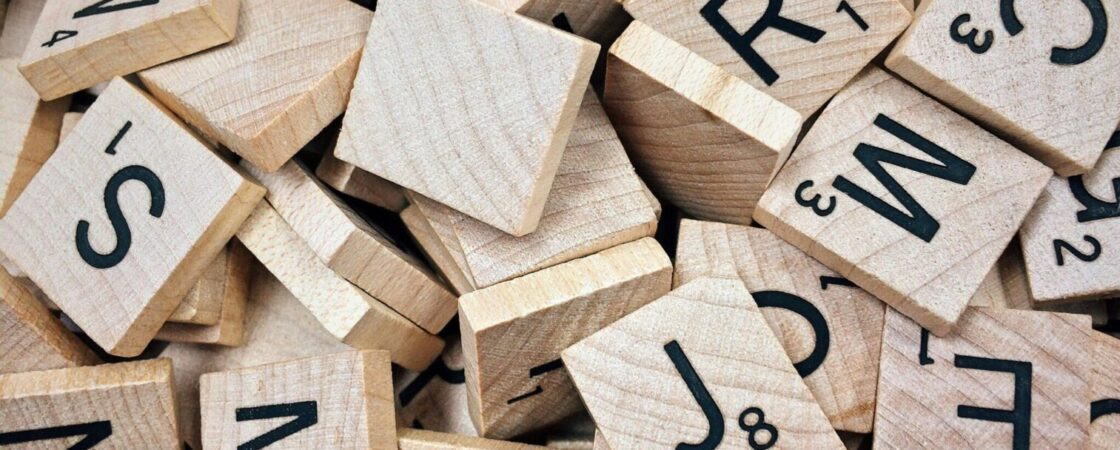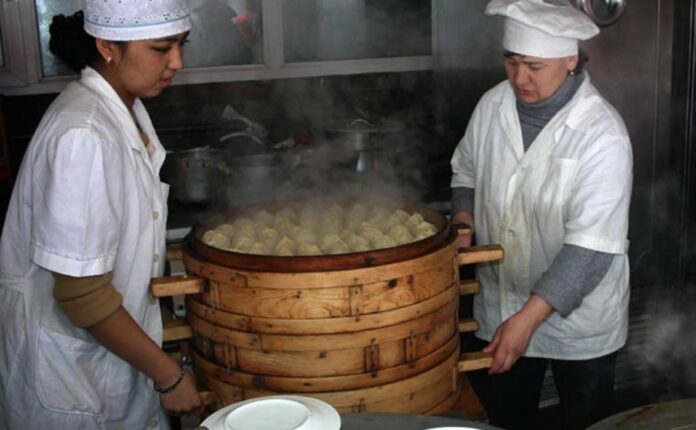Il romanzo psicoanalitico è un genere molto conosciuto e studiato ancora oggi, affascinante e coinvolgente per le tematiche trattate e soprattutto per gli argomenti spesso scelti dagli autori, profondamente tormentati e in opposizione con il mondo circostante.
La psicoanalisi è un argomento molto interessante e sul quale, nel corso, del tempo si sono susseguiti una serie di studi, il cui precursore fu Sigmund Freud.
Durante il Novecento affrontare il tema della psicoanalisi in riferimento all’ambito letterario, ha significato fare riferimento soprattutto alle riflessioni freudiane, all’interno delle quali la poetica si configurava come fantasia, desiderio, gioco o come linguaggio omologo a quello del motto di spirito, del sogno.
Tra i freudiani italiani più noti del periodo sono da annoverare Vittorio Benussi, Marco Levi-Bianchini, Edoardo Weiss, Emilio Servadio, Cesare Luigi Musatti. Di fondamentale importanza la fondazione della Società Psicoanalitica Italiana, avvenuta nel 1925 a Teramo da parte dello psichiatra Marco Levi-Bianchini, e la nascita della «Rivista Italiana di Psicoanalisi», fondata dallo psicoanalista triestino Edoardo Weiss nel 1932.
Uno dei temi cardine del romanzo psicoanalitico è quello dell’uomo, non da considerarsi inetto, ma in quanto individuo che si ritrova avviluppato in una concatenazione di problemi; più banalmente si potrebbe dire che la colpa è del destino di fronte al quale l’uomo ha pochi mezzi per cambiarlo a suo vantaggio, questa impotenza porta molto spesso l’uomo ad essere distruttivo ed autodistruttivo, sentendosi ogni giorno in trappola e vivendo una doppia vita, quella privata e quella pubblica.
Proprio a tal proposito, in relazione alle idee di Freud, si diffusero una serie di scelte ed idee letterarie, di autori e poeti italiani che diedero il via alla nascita del romanzo psicoanalitico o psicologico, perno della letteratura ottocentesca e soprattutto Novecentesca.
Romanzo psicoanalitico: quando si è diffuso e caratteristiche principali
La diffusione della dottrina psicoanalitica in Italia ha conosciuto uno sviluppo che, oltre ad essere stato piuttosto lento e timido, è anche stato tardivo rispetto a quello che si è osservato negli altri paesi europei.
In Italia solo a partire dagli anni Cinquanta si può parlare di una presenza indiscussa della psicoanalisi presso la cultura di livello medio.
Primo in Italia, fu il celebre autore de La coscienza di Zeno, Italo Svevo, che pur non considerando la psicoanalisi come un modo per guarire dalla nevrosi, tratta temi ad essa strettamente collegati, quali: il sogno, lo spirito, le paturnie della vita quotidiana.
Una scelta stilistica quella di Svevo, che avviene con forte coscienza razionale, soprattutto all’interno di una delle sue opere più importanti. In tal senso si può intendere Zeno Cosini, come simbolo di una più vasta nevrosi del mondo contemporaneo.
Svevo è il primo autore a “toccare” uno spazio privato dell’inconscio, smembrando quell’archeologia del banale che aveva contraddistinto gli anni del Naturalismo, secondo quanto hanno dichiarato nel corso degli anni, critici e filosofi.
La semplicità intesa come banalizzazione della realtà, non trova fondamento all’interno del romanzo psicoanalitico, fortemente incentrato sull’identificazione dell’io in relazione alla società, agli aspetti della vita quotidiana, azioni, gesta e comportamenti.
Il romanzo psicoanalitico nasce anche per rispondere a determinate esigenze, nell’ambito delle ricerche di specialisti del campo letterario, per arrivare ad una legittimazione vera e propria.
La nuova disciplina psicoanalitica in ambito letterario, crea dubbi nati, secondo gli storici e i letterati del tempo, da un approccio sbagliato al genere.
La cultura del tempo era intrisa di inflessioni mitteleuropee, lo stesso Italo Svevo, aveva difficoltà a scrivere in italiano, ma dopo le prime “prove letterarie”, diede vita a quello che ancora oggi è conosciuto come il suo più grande capolavoro.
Così fu anche per altri autori, tra i quali Umberto Saba; esponente di rilievo di quella parte di intellettualità ebraica triestina che fu pienamente coinvolta dalla fase psicoanalitica Saba, spinto da una dura nevrosi, entrò in terapia approcciandosi proprio con la psicoanalisi.
L’esperienza dell’analisi costituì, a detta di Saba, un cambiamento oltre e più che nella sua vita, nella sua poesia, che il poeta celebrò con la raccolta Il piccolo Berto, dedicandola a Weiss, grazie al quale egli aveva ritrovato in analisi la propria parte infantile, l’io che fino a quel momento era sfuggito.
Quello di Umberto Saba si può definire romanzo psicoanalitico soprattutto in riferimento ai temi trattati, tra i quali: l’ispirazione non sforzata, quindi spontanea, le ambiguità e le doppiezze, ma anche il concetto di verità che giace sul fondo.
In tal senso il poeta si riferisce ad una verità psicologica che è dentro ogni uomo, in quello che è il vero sentire, camuffato però dalle bugie che la vita impone. Compito del poeta è dunque riportare questo tipo di sapere alla coscienza e renderlo arte, bellezza.
Letteratura intesa come arte e dunque perfettamente inserita nell’ambito del romanzo psicoanalitico alla quale si ricollega anche Luigi Pirandello; in molte sue opere infatti, viene fuori una consapevole base d’ispirazione freudiana; tra queste: Sei personaggi in cerca d’autore, Non si sa come o ancora Enrico IV; ma nei fatti Pirandello stesso ha sempre negato ogni legame con Freud.
Ultimo (ma non per importanza) argomento di interesse in questo ambito, è il confronto tra Italo Svevo e una poetessa ed autrice italiana: Elsa Morante.
Esistono infatti, ben due punti di contatto tra La coscienza di Zeno e Menzogna e sortilegio; tantissimi sono gli elementi di identificazione tra i narratori delle due storie, ad esempio, entrambi sono narratori in prima persona e ritengono di essere portatori di una malattia devastatrice (l’inettitudine per l’uno e la menzogna per l’altra) che trova le sue radici nei meandri dell’infanzia. Inoltre, entrambi tentano di giungere alla guarigione grazie alla scrittura delle loro memorie nella speranza che, ripercorrendo passo dopo passo la loro esistenza passata, potranno trovare la fonte della loro nevrosi attuale e così liberarsene.
Dunque, in questo senso, il romanzo psicoanalitico può essere inteso come scrittura catartica, utilizzata come “medicina” per la cura dell’anima, attraverso l’inconscio o la consapevolezza intesa come metafora dell’esistenza. Il romanzo psicoanalitico in questo caso è da intendersi come una “sottocategoria” del romanzo psicologico, la cui componente principale è la prevalenza del monologo interiore dell’autore o dei personaggi.
In quest’ottica si può aggiungere che il romanzo psicoanalitico nasce da una esigenza interna, con i moti e i flussi della coscienza, attraverso un io che cambia continuamente e che si lascia condizionare dagli stimoli esterni.
Foto di Pixabay
Immagine in evidenza: Pixabay