Dal settembre del 1945 all’aprile del 1951 il Giappone è stato occupato militarmente dalle potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale. Di tale occupazione si occuparono principalmente gli Stati Uniti, con l’obiettivo di rendere il Giappone un Paese incapace di fare la guerra. Per raggiungere tale scopo era necessario fare ordine nel passato militarista del Paese ed è con questo auspicio che viene istituito il Tribunale di Tokyo.
Indice dei contenuti
Istituzione e scopo del Tribunale
Dal 1931 al 1945 il Giappone aveva seguito una linea aggressiva ed espansionistica, macchiandosi di crimini efferati ai danni dei civili. Alla luce di questo, il 3 maggio del 1946 fu istituito dagli Alleati il Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente, comunemente noto come Tribunale di Tokyo. Omologo del Tribunale di Norimberga, aveva il compito di giudicare i crimini di classe A, ovvero i crimini contro la pace.
| Dati chiave del processo | Dettagli |
|---|---|
| Periodo | 3 maggio 1946 – 12 novembre 1948 |
| Imputati | 28 alti ufficiali e funzionari di governo (es. Hideki Tojo) |
| Sentenze Finali | 7 condanne a morte, 16 ergastoli, 2 condanne a pene minori |
La controversia sull’imperatore Hirohito
Tra i 28 imputati, principalmente anziani ufficiali e funzionari, non figurava l’imperatore Hirohito. Questa scelta, voluta dal generale Douglas MacArthur e dal governo statunitense, è uno degli elementi più controversi del processo. L’intento era ottenere il sostegno dell’istituzione imperiale per le riforme americane in Giappone, evitando una violenta sollevazione popolare che sarebbe derivata da un’incriminazione dell’imperatore, considerato una figura divina.
I crimini di guerra occultati
L’andamento del Tribunale di Tokyo proseguì in maniera ambigua, con l’occultamento di alcuni crimini commessi dai giapponesi. Per volontà degli Stati Uniti, non furono prese in considerazione prove su atrocità come il Massacro di Nanchino del 1937. Venne insabbiata anche la questione delle comfort women, donne costrette alla schiavitù sessuale per i soldati. Infine, fu nascosta la documentazione sugli esperimenti condotti su prigionieri di guerra dall’Unità 731, in cambio dei risultati di quelle ricerche su armi chimiche e biologiche.
L’accusa di “giustizia dei vincitori”
Numerose critiche sono state mosse contro il Processo, in particolare quella sulla victors’ justice. Si tratta di un’espressione che indica un’applicazione distorta della giustizia da parte dei vincitori nei confronti dei vinti. Questa critica trova applicazione concreta nel Tribunale di Tokyo, dato che dalla lista dei crimini erano stati esclusi il colonialismo occidentale e atrocità come lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Inoltre, la corte era composta esclusivamente da giudici delle nazioni vincitrici. Queste ragioni, secondo il giudice indiano dissenziente Radhabinod Pal, rappresentano il «fallimento del processo nell’offrire nient’altro che l’opportunità per i vincitori di vendicarsi dei vinti».
Altre informazioni e curiosità sul Tribunale di Tokyo
Chi fu processato al Tribunale di Tokyo?
Furono processati 28 leader politici e militari giapponesi per crimini di guerra di Classe A (crimini contro la pace). L’imputato più noto era l’ex Primo Ministro Hideki Tojo. L’imperatore Hirohito non fu tra gli imputati.
Quali furono le condanne del Processo di Tokyo?
Il processo si concluse nel novembre 1948 con 25 condanne (due imputati morirono durante il processo, uno fu dichiarato mentalmente instabile). Le sentenze furono: 7 condanne a morte (tra cui Tojo), 16 ergastoli e 2 condanne a pene detentive minori.
Perché l’imperatore Hirohito non fu processato?
L’imperatore Hirohito non fu processato per una decisione politica degli Stati Uniti, guidati dal generale MacArthur. Si temeva che processare una figura considerata divina avrebbe causato un’insurrezione popolare, compromettendo l’occupazione e le riforme post-belliche del Giappone.
Fonte immagine in evidenza: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 31/08/2025





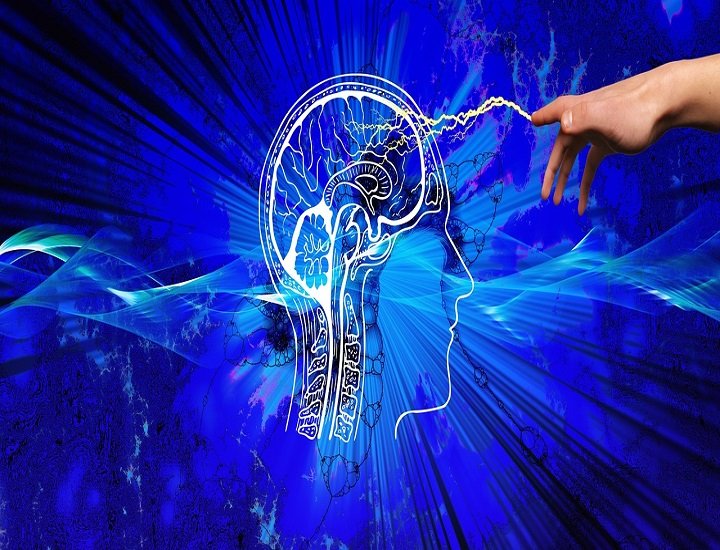





Articolo ben strutturato e scorrevole, inoltre è evidente l’approfondita conoscenza dell’argomento.