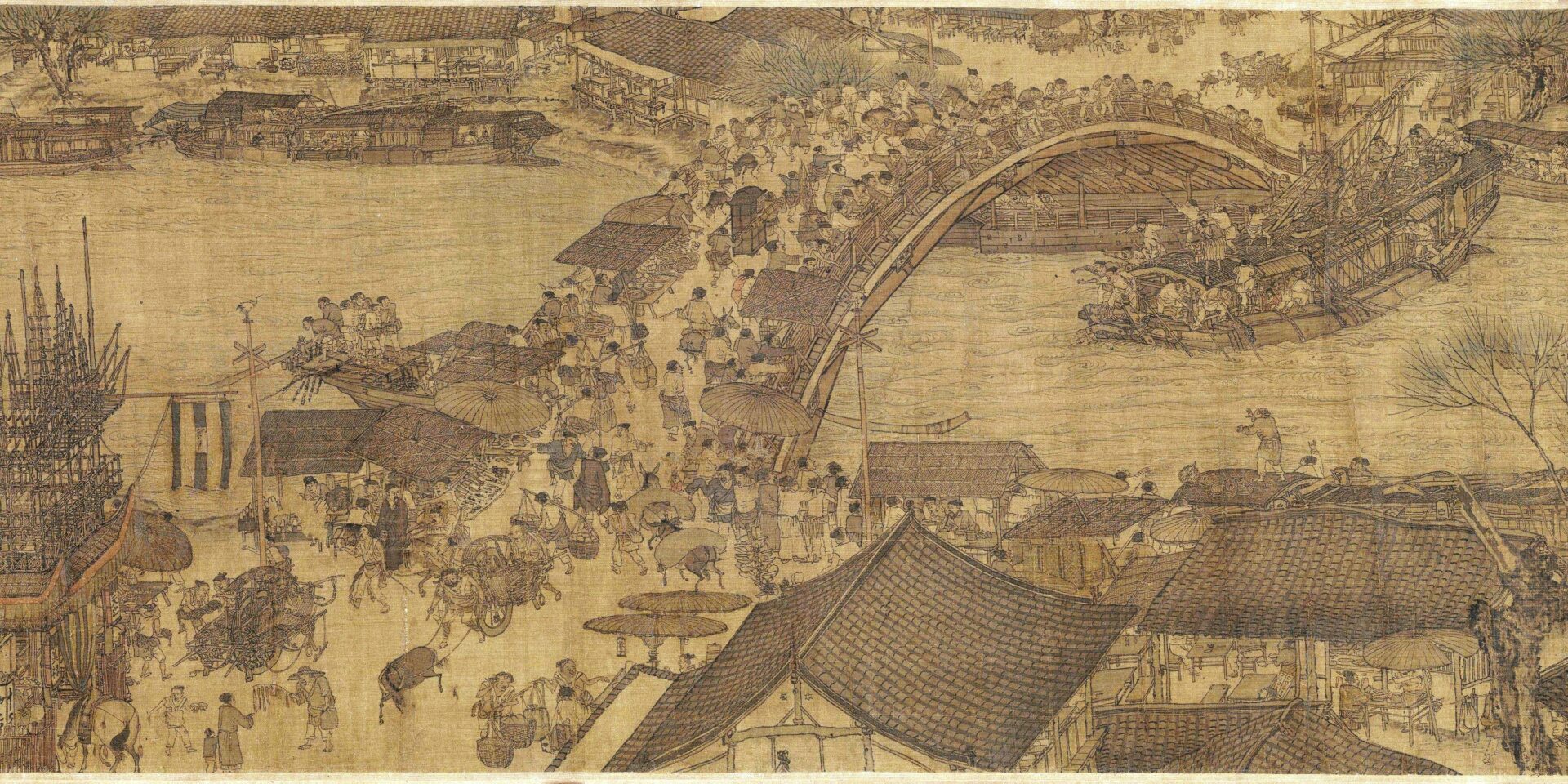La letteratura cinese ha assunto un ruolo centrale nella costituzione delle idee e dei valori della modernità cinese. In un periodo di profonda crisi e trasformazione, essa è diventata uno strumento fondamentale non per un’evoluzione tecnologica, ma per modificare le menti, i sentimenti e le ideologie di un’intera popolazione, con l’obiettivo di modernizzare la Cina dall’interno.
Indice dei contenuti
Il contesto: dal “Sogno Cinese” alla crisi di fine ‘800
L’idea di una “grande rinascita della nazione cinese”, slogan ripreso da Xí Jìnpíng nel 2012, affonda le sue radici nel trauma del declino imperiale. Dopo secoli di centralità, la sconfitta nella guerra sino-giapponese del 1895 rappresentò un punto di non ritorno. Gli intellettuali cinesi compresero che il mondo era cambiato e che la Cina, per non soccombere, doveva modernizzarsi e ridiventare ricca e forte (fuqiang). La letteratura cinese divenne uno dei principali campi di battaglia per questa trasformazione.
La svolta: la Riforma dei cento giorni
Il momento di svolta simbolico fu la Riforma dei cento giorni del 1898. Un gruppo di letterati, guidati da Kang Youwei e dal suo discepolo Liang Qichao, convinse l’imperatore Guangxu ad avviare un processo di riforme radicali. L’obiettivo non era più solo un aggiornamento tecnico, ma una trasformazione politica profonda: convertire l’Impero in uno stato-nazione. Questo significava passare da un sistema in cui i cinesi erano semplici sudditi a una comunità di cittadini che possedevano lo stato e ne esercitavano il potere.
Il ruolo della letteratura: formare i cittadini del nuovo stato-nazione
Per creare lo stato-nazione, non bastava cambiare le istituzioni. Come sosteneva Liang Qichao, era necessario formare i nuovi cittadini, insegnando loro valori politici e sociali. La letteratura divenne lo strumento principale per questa educazione. Il suo potere risiedeva nella sua capacità di agire sull’immaginazione e sulle emozioni, elementi fondamentali per creare quella che è stata definita una “comunità immaginata”.
| Obiettivo della modernizzazione | Funzione della letteratura |
|---|---|
| Trasformare i sudditi in cittadini | Insegnare e diffondere nuovi valori politici e sociali (responsabilità, partecipazione, patriottismo) attraverso romanzi e racconti. |
| Creare un’identità nazionale | Costruire una “comunità immaginata”, un senso di appartenenza e fratellanza tra tutti i cinesi, superando le divisioni locali. |
| Promuovere l’idea di progresso | Rileggere la tradizione (come la figura di Confucio) in una chiave moderna e riformista, per dimostrare che il cambiamento era in linea con la cultura cinese. |
Altre informazioni e curiosità sulla letteratura e la modernizzazione cinese
Chi era Liang Qichao e perché è così importante?
Liang Qichao (1873-1929) fu un intellettuale, giornalista e riformista, tra le figure più influenti della Cina moderna. La sua importanza risiede nell’aver capito che la modernizzazione della Cina non poteva essere solo tecnologica o militare, ma doveva essere prima di tutto culturale e politica. Fu lui a teorizzare in modo più sistematico il ruolo della letteratura (in particolare del romanzo) come strumento per forgiare la coscienza nazionale e creare i “nuovi cittadini” necessari per uno stato moderno.
Cos’è stata la Riforma dei cento giorni?
La Riforma dei cento giorni fu un intenso periodo di riforme tentato nel 1898 dall’imperatore Guangxu, su impulso di un gruppo di intellettuali guidati da Kang Youwei e Liang Qichao. Le riforme miravano a modernizzare radicalmente il sistema educativo, militare, politico ed economico della Cina sul modello occidentale e giapponese. Il tentativo fallì a causa di un colpo di stato conservatore guidato dall’imperatrice vedova Cixi, ma segnò l’inizio del dibattito che avrebbe portato alla fine dell’impero.
Cosa significa “stato-nazione” nel contesto della Cina di fine ‘800?
Per gli intellettuali cinesi dell’epoca, il concetto di “stato-nazione” (preso dall’Occidente) rappresentava una rottura radicale con il passato. Significava superare il modello imperiale, in cui il paese era proprietà del sovrano e il popolo era composto da sudditi passivi. Lo stato-nazione, al contrario, era concepito come un’entità politica appartenente a tutta la comunità di cittadini, uniti da una lingua, una cultura e un’identità condivisa, e attivamente partecipi al destino del Paese.
Se ti può interessare, leggi anche: Le 6 poesie cinesi che raccontano la cultura millenaria del paese
IMMAGINE IN EVIDENZA: FREEPIK
Articolo aggiornato il: 03/09/2025