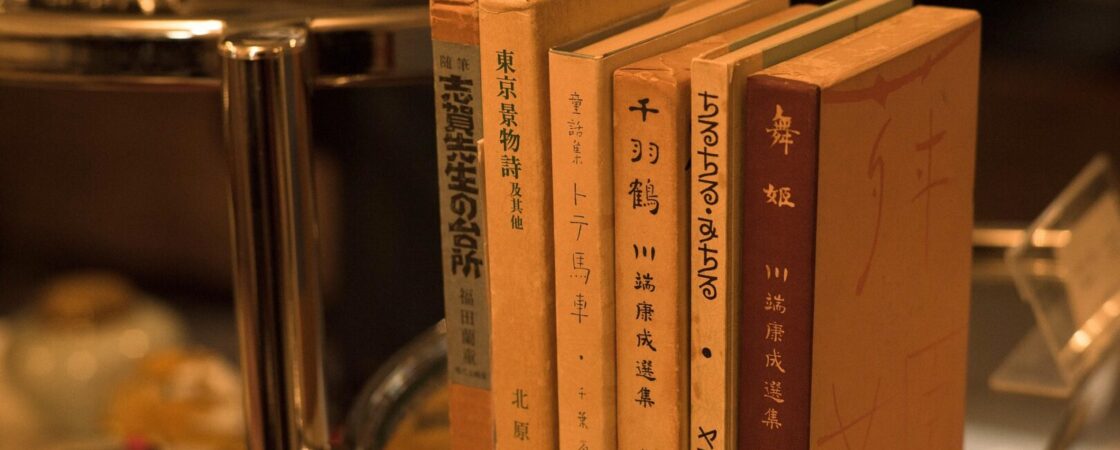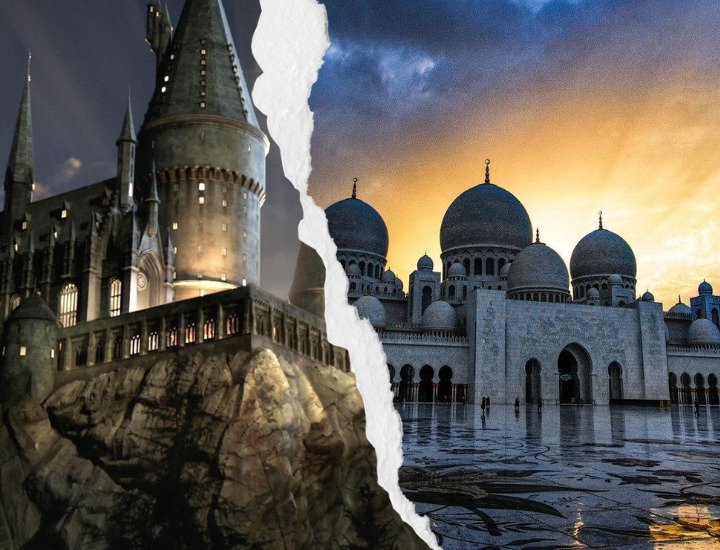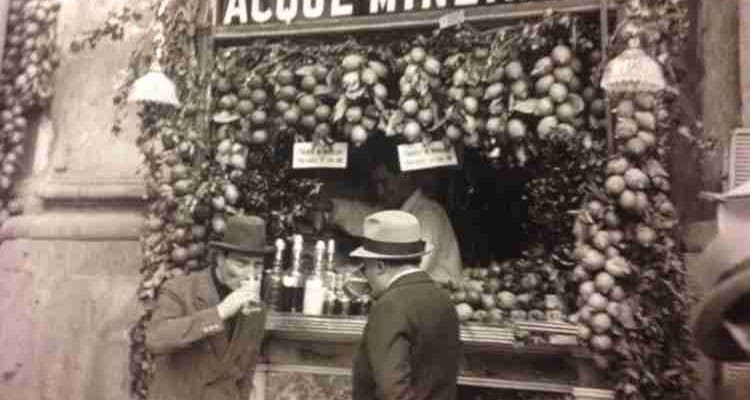Il Giappone non nasce come nazione buddhista; questa religione fu introdotta solo nel VI secolo d.C., ma divenne presto un elemento fondamentale della sua cultura. L’influenza buddhista nella letteratura giapponese è una caratteristica profonda e persistente, che ha modellato temi, estetica e la visione del mondo di innumerevoli opere.
Indice dei contenuti
Il periodo Heian: il “Genji Monogatari” e il karma
Tra le prime e più importanti opere a mostrare l’influenza buddhista vi è il Genji Monogatari, capolavoro scritto da Murasaki Shikibu nel periodo Heian. Sebbene i romanzi di finzione (monogatari) fossero visti con sospetto da alcuni monaci, che li accusavano di suscitare passioni e allontanare dal nirvana, l’opera di Murasaki è intrisa di concetti buddhisti. Il tema del karma è onnipresente: le azioni del principe Genji, che spesso usa i precetti religiosi per giustificare le sue conquiste amorose, hanno conseguenze inevitabili. La sua passione smodata, condannata dal Buddhismo, diventa causa di sofferenza e distruzione, dimostrando come gli attaccamenti terreni ostacolino la salvezza.
Il periodo Kamakura e l’estetica dell’impermanenza
Nel XII secolo, con l’instabilità politica del periodo Kamakura, l’influenza buddhista si fece ancora più profonda. Si diffuse una visione del mondo segnata dal senso di incertezza e caducità, basata su due concetti chiave derivati dalla filosofia buddhista giapponese:
- Mappō: la credenza di vivere nell’era della “fine del Dharma”, un periodo di declino spirituale e caos destinato a concludersi con la morte.
- Mujōkan: la profonda percezione dell’impermanenza e dell’evanescenza di ogni aspetto della vita umana.
Questo sentimento permea le opere di due degli autori più importanti del periodo.
Due visioni dell’impermanenza: Chōmei vs Kenkō
| Kamo no Chōmei in “Ricordi di un eremo” (Hōjōki) | Kenkō Hōshi in “Momenti d’ozio” (Tsurezuregusa) |
|---|---|
| Interpreta il mujōkan con un pessimismo cupo. Descrive le catastrofi e riflette sul suo doloroso attaccamento ai beni materiali, riconoscendolo come un ostacolo alla salvezza. | Ha una visione più positiva. Accetta il mujōkan come una ragione per apprezzare ancora di più la bellezza fugace della vita, godendo dei momenti proprio perché destinati a finire. |
| La sua opera è una meditazione sulla sofferenza causata dall’attaccamento in un mondo instabile. | La sua opera celebra la bellezza dell’irregolarità e della non-artificialità, un’etica estetica tipicamente giapponese che abbraccia l’imperfezione. |
L’opera di Kamo no Chōmei è una profonda riflessione sulla sofferenza derivante dall’attaccamento alle cose terrene, viste come fonte di dolore in un’epoca di catastrofi. Al contrario, Kenkō Hōshi, pur partendo dallo stesso presupposto dell’impermanenza, arriva a una conclusione diversa: proprio perché la vita è effimera, bisogna apprezzarne la bellezza in ogni sua manifestazione, anche nell’irregolarità e nell’imperfezione, concetti che sono al cuore dell’estetica giapponese.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 10/09/2025