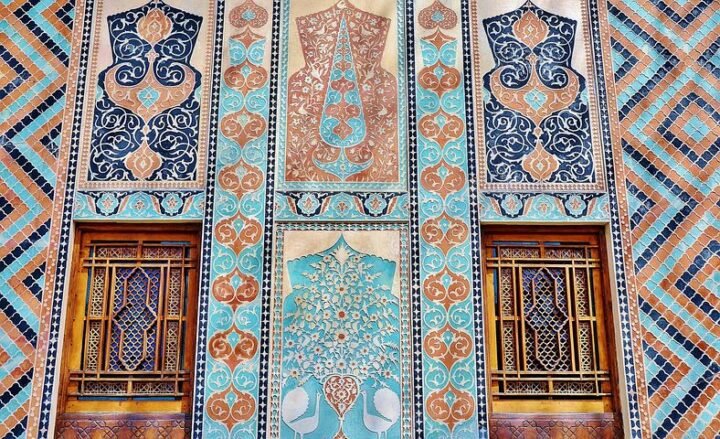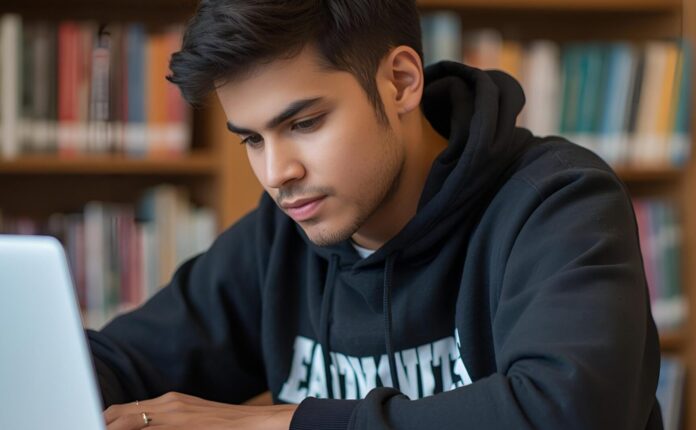L’italiano fa parte delle cosiddette lingue del sì, un’espressione che dobbiamo al Sommo Poeta Dante Alighieri. Nel suo trattato De vulgari eloquentia, egli propose una celebre tripartizione delle lingue romanze europee, basata sulla particella affermativa usata in ciascuna area linguistica.
Indice dei contenuti
La classificazione di Dante: oïl, oc e sì
Dante identificò tre grandi filoni linguistici romanzi, ciascuno definito dal proprio modo di dire “sì”:
- La lingua d’oïl, diffusa nella Francia del nord, antecedente del francese moderno.
- La lingua d’oc, diffusa nella Francia del sud, progenitrice dell’occitano.
- La lingua del sì, ovvero l’insieme dei volgari parlati nella penisola italiana.
| Lingua (secondo Dante) | Area Geografica e Tradizione Letteraria |
|---|---|
| Lingua d’oïl | Francia settentrionale. Lingua dell’epica cavalleresca (es. Chanson de Roland). |
| Lingua d’oc | Francia meridionale (Occitania). Lingua della poesia lirica dei trovatori. |
| Lingua del sì | Penisola italiana. Lingua della nascente lirica della Scuola Siciliana e, in seguito, degli Stilnovisti. |
La nascita dell’italiano: dal latino ai volgari
L’italiano, come le altre lingue romanze, deriva dal latino volgare, ovvero il latino parlato quotidianamente. Con la caduta dell’Impero Romano, il latino classico rimase la lingua scritta della cultura, mentre le diverse varietà di latino parlato si evolsero in lingue autonome. La lingua latina era stata imposta come lingua dell’Impero, sovrapponendosi alle parlate preesistenti e creando substrati linguistici unici in ogni regione.
In Italia, la notevole frammentazione politica portò alla nascita di numerosi volgari, molti dei quali oggi si possono identificare con i dialetti regionali. Con il tempo, questi idiomi, da esclusivamente orali, cominciarono a essere usati anche in forma scritta.
I primi documenti in volgare italiano
Le prime testimonianze scritte della “lingua del sì” sono documenti di natura pratica, non ancora letteraria:
- Indovinello veronese (VIII-IX sec.): una nota a margine di un manoscritto, considerata da alcuni studiosi un esempio di tardo latino e da altri il primo vagito del volgare italiano.
- Iscrizione della Catacomba di Commodilla (IX sec.): un graffito a Roma che recita “Non dicere ille secrita a bboce” (“Non dire i segreti a voce alta”), chiara testimonianza di una lingua intermedia tra latino e volgare.
- Placiti Cassinesi (960-963 d.C.): formule di giuramento inserite in atti notarili redatti a Capua, Sessa Aurunca e Teano. La formula capuana, “Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti“, è universalmente riconosciuta come il primo documento ufficiale in volgare italiano. È possibile consultare il manoscritto originale presso la Biblioteca Medicea Laurenziana.
Perché l’italiano è la “lingua del sì”?
La particella affermativa sì deriva dal latino sīc est (“è così”). Dante, nel definire l’Italia, scelse proprio questo suono come suo emblema. Nella Divina Commedia, e precisamente nel Canto XXXIII dell’Inferno, descrive l’Italia come il “bel paese là dove ‘l sì suona“. Questa definizione non è solo una classificazione linguistica, ma un vero e proprio atto d’amore. L’italiano era percepito come una lingua aggraziata, dolce, e quella particella divenne simbolo di appartenenza culturale e motivo di vanto.
Verso un’unità linguistica
È importante ricordare che la Divina Commedia stessa è un capolavoro di plurilinguismo, basato sul dialetto fiorentino ma arricchito da latinismi, francesismi e termini provenienti da vari volgari italiani. Il registro linguistico dell’opera è stato definito una sorta di “risemantizzazione” della nascente lingua italiana, che propendeva verso un’unità solo successivamente raggiunta grazie al prestigio letterario delle “tre corone”: Dante, Petrarca e Boccaccio.
In conclusione, l’espressione lingue del sì non indica solo una classificazione dotta, ma celebra l’identità di una lingua e di una cultura che, fin dalle sue origini, affascinava poeti e letterati per la sua musicalità e il suo spessore.
Immagine in evidenza: Pixabay
Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2025