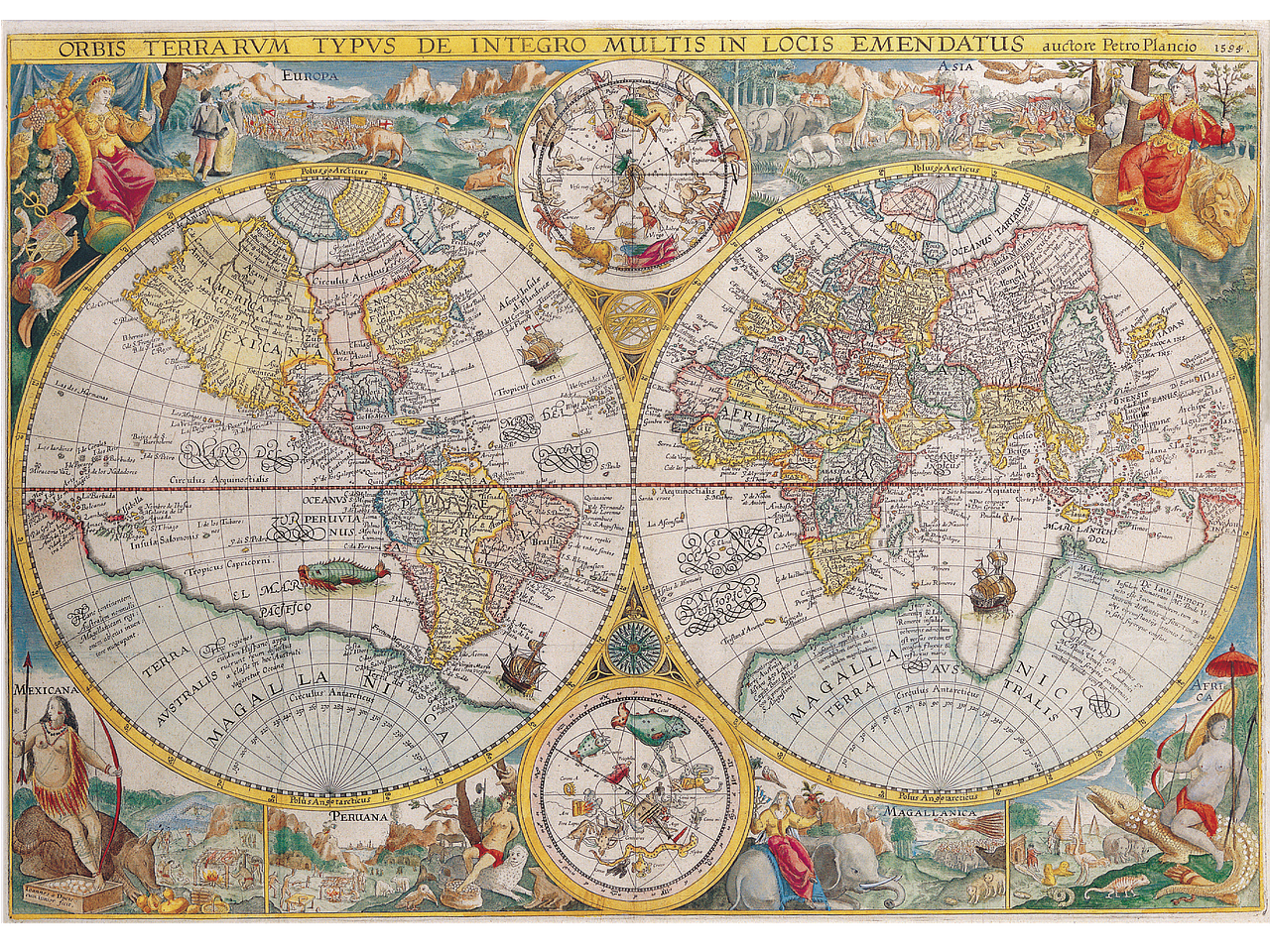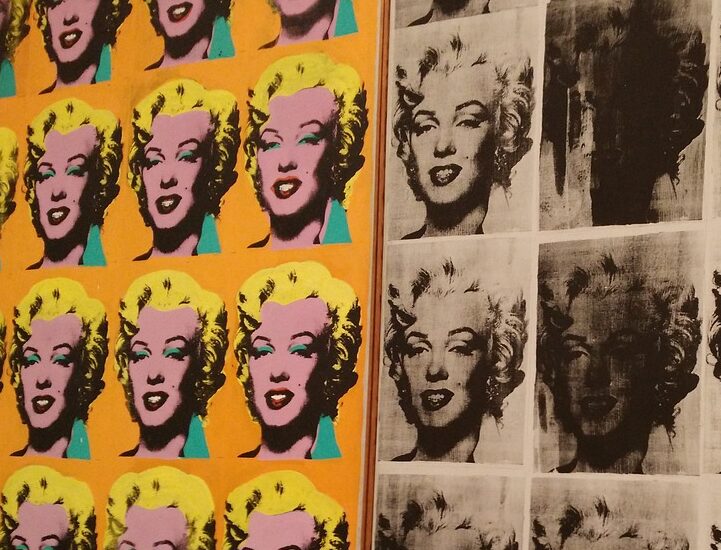De vulgari eloquentia (dell’eloquenza della lingua volgare): il volgare secondo Dante
Analizziamo uno dei trattati danteschi più di rilievo in ambito linguistico, e del perché la lingua volgare sia stata così importante nella storia occidentale. Il De vulgari eloquentia è un’opera fondamentale per comprendere il pensiero di Dante sulla lingua e sulla letteratura. Scritto in latino tra il 1303 e il 1304, durante l’esilio, il trattato si propone di definire le caratteristiche del volgare illustre, ovvero di quel volgare letterario che il poeta ritiene degno di essere utilizzato per opere di alto livello, come la poesia lirica e la trattatistica. Un volgare capace di competere con il latino, lingua della tradizione e della cultura, e di esprimere al meglio i concetti più elevati e complessi. Con quest’opera, Dante si pone come uno dei primi e più importanti teorici della lingua volgare, anticipando di secoli le discussioni che animeranno il dibattito linguistico italiano. Il trattato, dunque, è un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere l’evoluzione della nostra lingua e il ruolo che Dante ha avuto in questo processo. Il De vulgari eloquentia è un’opera di grande importanza non solo per la storia della lingua italiana, ma anche per la storia della linguistica in generale.
Il volgare secondo Dante: definizione e caratteristiche nel testo
La lingua volgare, secondo il poeta Dante Alighieri, è quella lingua che il bambino impara dalla balia: parliamo di una delle frasi più di rilievo del trattato scritto nel 1303, il De vulgari eloquentia. Tale opera è composta da quattro libri, di cui uno solo ci è arrivato completo, un secondo mai concluso, e altri due che non sono stati mai scritti. Lo spazio argomentativo fu dedicato interamente all’eloquenza della lingua volgare, cioè alla lingua progressivamente affermatasi nel Medioevo in tutta l’Europa occidentale, e, in questo caso in Italia, usata da giuristi, commercianti, notai, uomini religiosi e poeti nella loro vita quotidiana. Dante affrontò in maniera critica i problemi attorno alla lingua volgare, che si accingeva a svilupparsi nella letteratura; infatti, fu ribattezzata come una lingua “colta”. Dante decise di scrivere in latino il De vulgari eloquentia per due precisi motivi: per prevenire le accuse di incultura e soprattutto perché tale scritto era dedicato alla gente dotta, ai literati, cioè a coloro che conoscevano il latino e che consideravano il volgare una lingua inferiore e inadatta a trattare argomenti elevati. In questo modo, il poeta fiorentino poteva dimostrare la sua padronanza della lingua dei classici e, allo stesso tempo, rivendicare la dignità e il valore del volgare.
Leggi anche: Scuola siciliana, cos’è
De vulgari eloquentia: la storia della lingua secondo Dante
Andiamo ad analizzare in maniera più dettagliata i vari argomenti intorno all’eloquenza della lingua volgare. Prima di tutto, l’autore affronta l’argomento sotto un punto di vista storico, affermando che il latino era ormai una lingua inadatta all’uso quotidiano, in quanto lingua artificiale, creata a tavolino dai dotti. Inoltre, parla dell’originale esistenza di un’unica lingua, quella parlata da Adamo, donatagli direttamente da Dio. Secondo l’autore della Divina Commedia, la distruzione della torre di Babele, simbolo della superbia umana, avrebbe provocato la frammentazione di questa, provocando “sottogruppi” di lingua volgare, che variarono in base alla posizione geografica e alla popolazione che la utilizza (il concetto della mutatio, la mutazione della lingua, è d’altronde alla base dell’intuizione dantesca). Nella sua teoria si distinguono, poi, tre volgari europei: il greco, il germano/slavo e l’occidentale, suddividendo quest’ultima nelle lingue d’oc, d’oil ed il si (lingua d’oc, lingua d’oil e lingua del sì). Da quest’ultima, secondo Dante, hanno avuto origine i diversi volgari italiani, che il poeta si propone di analizzare e classificare.
Il volgare illustre secondo Dante nel De vulgari eloquentia
La lingua volgare che ricerca il poeta deve rispondere ai canoni del decoro, ossia essere illustre; cardinale, cioè deve fare da cardine rispetto alle altre lingue parlate; aulico, cioè utilizzabile dinanzi ad un sovrano; ed infine, curiale, ovvero adatta all’ambiente di corte. Ma nessuno dei volgari italiani esistenti, secondo Dante, risponde a queste virtù, salvo in casi di opere di autori come Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Cino da Pistoia e lo stesso Dante. L’obiettivo del poeta è quindi quello di creare un volgare illustre, che sia degno di essere utilizzato nella poesia e nella letteratura, un volgare che sia la sintesi delle parlate più nobili d’Italia e che possa assurgere a lingua nazionale. Per fare ciò, Dante passa in rassegna i diversi volgari italiani, ben quattordici, bocciandoli tutti, poiché nessuno di essi possiede le caratteristiche necessarie per assurgere al ruolo di volgare illustre. Tra questi volgari, il poeta salva solo il bolognese, per la sua dolcezza, e il siciliano, per la sua musicalità, ma li ritiene comunque insufficienti. Curioso il fatto che Dante non citi mai esplicitamente il fiorentino, benché sia evidente che lo tenga in grande considerazione.
La riscoperta del trattato e la sua importanza
Parlando del secondo libro del De vulgari eloquentia, esso fu interrotto bruscamente al XIV capitolo. Dimenticato per lunghi anni, fu poi riscoperto nel 1514, o meglio nel 1529, da Gian Giorgio Trissino, nel pieno di un dibattito sulla questione della lingua volgare; inoltre, furono palesati forti dubbi sulla reale paternità di Dante Alighieri, smentita in seguito a lunghi studi filologici compiuti a fine Ottocento. La pubblicazione a stampa del trattato, avvenuta a Vicenza nel 1529, fu curata proprio dal Trissino, che ne fece una traduzione in italiano. L’opera di Dante ebbe un’immediata risonanza e influenzò notevolmente il dibattito sulla lingua che si sviluppò nel Cinquecento, contribuendo all’affermazione del modello linguistico proposto da Pietro Bembo nelle sue Prose della volgar lingua (1525), basato sul fiorentino letterario del Trecento.
Possiamo concludere dicendo che la grande potenza di questo trattato sta nella capacità dell’autore di aver anticipato il dibattito quattrocentesco e cinquecentesco sulla lingua volgare, definendo una precisa “storia” della vita di questa lingua, che nasce nella Provenza, con la poesia trobadorica, e arriva fino in Toscana, con la Scuola siciliana e il Dolce Stil Novo. Attraverso le pagine del De vulgari eloquentia, Dante ci ha lasciato una testimonianza preziosa non solo del suo pensiero linguistico, ma anche della realtà linguistica e culturale dell’Italia del suo tempo.
Immagine di copertina: Pixabay