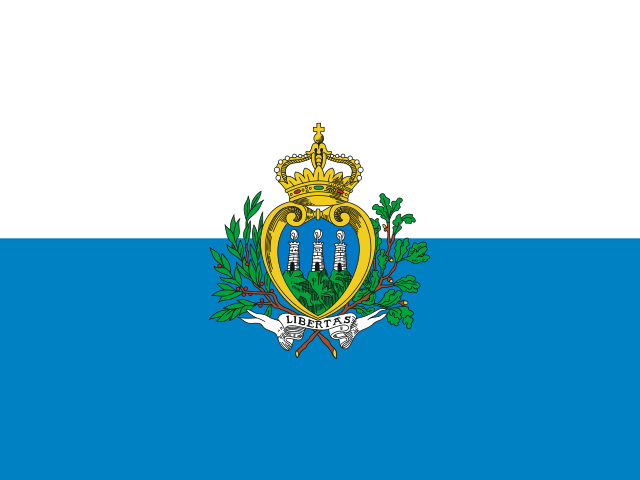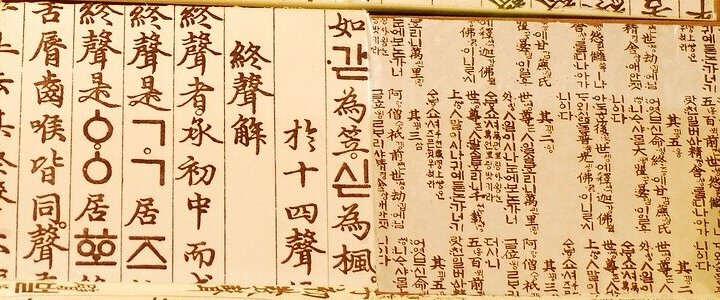Il romanzo epistolare è un’opera narrativa la cui trama si sviluppa interamente attraverso uno scambio di lettere tra i personaggi. Questo formato permette al lettore di accedere direttamente ai pensieri, ai sentimenti e al punto di vista dei corrispondenti, creando un forte senso di immediatezza e realismo. L’etimologia del termine deriva dal latino epistŭla, che significa appunto “lettera”.
Indice dei contenuti
Le origini del genere: da Ovidio al rinascimento
Le radici di questa particolare forma narrativa si trovano nella letteratura classica latina, dove incontriamo i primi testi poetici organizzati in forma epistolare. L’esempio più celebre sono le Heroides di Ovidio, una raccolta di ventuno lettere d’amore fittizie, attribuite a figure femminili del mito come Medea, Arianna e Penelope. Quello di Ovidio è considerabile un modello ante-litteram, un’eccezione nel panorama classico.
Per una maggiore diffusione del genere bisogna attendere il Cinquecento europeo, periodo in cui si afferma la tendenza a pubblicare raccolte epistolari. Sebbene non si trattasse ancora di romanzi, opere come le Lettere di Pietro Aretino e le Lettere di diversi nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni di Paolo Manuzio spianarono la strada. Il primo prototipo di romanzo epistolare vero e proprio è considerato Lettere amorose di due nobilissimi intelletti di Alvise Pasqualigo, pubblicato a Venezia nel 1563 e definito dall’Enciclopedia Treccani un’opera pionieristica.
Le caratteristiche principali del romanzo epistolare
Il ritmo narrativo del romanzo epistolare è interamente affidato ai personaggi della storia: sono loro, attraverso i fatti che raccontano, a determinare l’andamento degli eventi. La narrazione è quindi soggettiva e spesso polifonica, presentando punti di vista multipli e talvolta contraddittori. Questo espediente elimina la figura del narratore onnisciente, lasciando al lettore il compito di ricostruire la verità dai frammenti forniti. La forma della lettera, inoltre, diventa un elemento narrativo a sé, capace di rivelare lo status sociale e il livello di istruzione dei personaggi attraverso il loro stile di scrittura. Infine, la struttura può fungere da cornice narrativa: l’autore finge di aver ritrovato casualmente le lettere, un artificio che gli permette di intervenire nell’opera con prefazioni o note, inserendo il proprio punto di vista esplicito.
| Opera e autore | Caratteristica chiave / Tipo |
|---|---|
| Pamela (S. Richardson) | Romanzo monofonico (un solo corrispondente) |
| Le relazioni pericolose (P. de Laclos) | Romanzo polifonico (punti di vista multipli) |
| Ultime lettere di jacopo ortis (U. Foscolo) | Confessione intima e narrazione soggettiva |
| Frankenstein (M. Shelley) | Cornice narrativa epistolare per un racconto gotico |
I grandi classici del romanzo epistolare in Europa
Il Settecento è il secolo d’oro del romanzo epistolare. Nella letteratura inglese spicca Samuel Richardson con Pamela, o la virtù premiata e Clarissa. In seguito, autori come Mary Shelley con Frankenstein e Anne Brontë con La signora di Wildfell Hall dimostrano la grande versatilità del genere, capace di spaziare dal gotico al romanzo di costume. Anche la letteratura francese vanta esempi straordinari, come Le relazioni pericolose di Pierre Choderlos de Laclos e Julie, o la nuova Eloisa di Jean-Jacques Rousseau. In Germania, un’opera fondamentale è I dolori del giovane Werther di Goethe, che ebbe un impatto enorme sulla cultura europea.
Anche nella letteratura italiana troviamo classici ascrivibili al genere, con Le ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo e Storia di una capinera di Giovanni Verga.
L’evoluzione moderna: dalle lettere alle email
Le narrazioni più recenti hanno adattato la forma epistolare alla sensibilità moderna, sostituendo le lettere con mezzi di comunicazione più contemporanei. Un esempio è l’uso dell’e-mail, come nel caso dell’epistolare virale o di romanzi come Le ho mai raccontato del vento del Nord di Daniel Glattauer e il suo sequel, La settima onda. Questa evoluzione dimostra la flessibilità di una struttura narrativa che continua a essere efficace anche nell’era digitale, utilizzando blog, chat o messaggi per raccontare storie in modo intimo e diretto.
Fonte immagine: Image by rawpixel.com on Freepik
Articolo aggiornato il: 03/10/2025