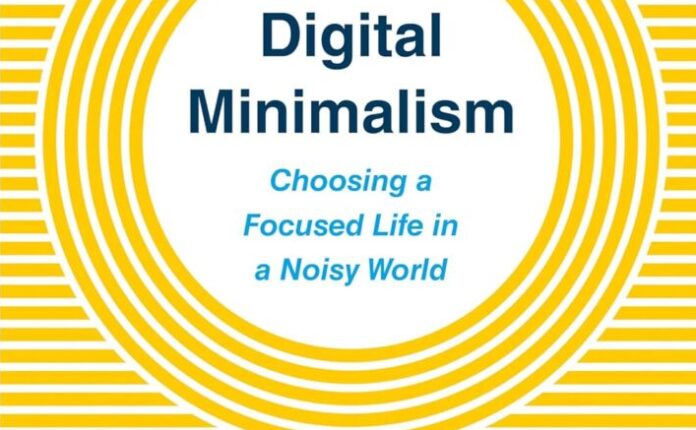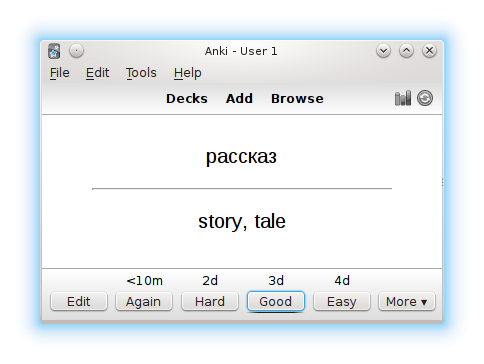Regioni a Statuto Speciale: quali sono, storia e differenze tra di loro
L’Italia è suddivisa amministrativamente in 20 regioni, di cui 5 definite Regioni a Statuto Speciale, ovvero dotate di particolare autonomia. Ma cosa significa esattamente “Statuto Speciale”? Quali sono queste regioni e perché godono di condizioni speciali? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, analizzando le differenze tra Regioni a Statuto Speciale e Regioni a Statuto Ordinario, ripercorrendo la storia della loro istituzione e approfondendo le motivazioni che hanno portato a questa scelta, delineando infine un quadro della situazione attuale.
Cosa sono le Regioni a Statuto Speciale?
Lo Stato Italiano è suddiviso, a livello amministrativo, in 20 regioni italiane, 5 delle quali godono di una maggiore autonomia gestionale e finanziaria, e sono appunto definite Regioni a Statuto Speciale. Si tratta delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Tutte terre di confine e isole. Semplificando, hanno lo statuto speciale per le loro: a) particolari caratteristiche storiche (non naturale appartenenza all’Italia), b) istanze autonomiste (anche secessioniste), c) caratteristiche culturali (tutela delle minoranze, come prevede l’Art. 6 della Costituzione).
Regioni a Statuto Speciale e ordinario: quali differenze?
Ciò che caratterizza le regioni elencate è il fatto di possedere uno “Statuto Speciale”, appunto, diverso dallo “Statuto di diritto comune” che appartiene invece alle Regioni a Statuto Ordinario. Quest’ultimo è adottato e modificato con legge regionale, mentre lo Statuto Speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua modifica. Tale differenza si traduce in una maggiore autonomia per le Regioni a Statuto Speciale, sia dal punto di vista legislativo che amministrativo e finanziario.
Autonomia amministrativa, legislativa e finanziaria delle Regioni a Statuto Speciale
Le Regioni italiane a Statuto Speciale godono di una triplice autonomia: amministrativa, legislativa e finanziaria. Nel caso di quest’ultima si parla di privilegi concessi, tanto che vi sono stati tentativi di “migrazione” verso una determinata Regione a Statuto Speciale da parte di Comuni di confine delle Regioni ordinarie (è noto il caso di Cortina d’Ampezzo). Nel tempo la differenza effettiva tra l’autonomia finanziaria di una Regione a Statuto Speciale e di una Regione Ordinaria si è attenuata, anche grazie all’introduzione di meccanismi di perequazione come i costi e i fabbisogni standard.
La nascita delle Regioni italiane a Statuto Speciale: un excursus storico
Le regioni italiane sono nate con la Costituzione Italiana, che entrò in vigore il 1° gennaio 1948; come è noto, però, le regioni non entrarono in funzione subito: fino al 1970 non venne eletto alcun consiglio regionale, tranne quelli delle Regioni a Statuto Speciale. Le Regioni a Statuto Speciale, previste dall’articolo 116 della Costituzione, sono un unicum in uno stato centralizzato, non vennero decise tutte insieme e sono nate con motivazioni parzialmente diverse.
La Sicilia e il movimento indipendentista
La parziale autonomia della Sicilia, iniziata già con l’istituzione dell’Alto commissariato per la Sicilia nel 1944, venne confermata nel 1946 con un decreto firmato dall’allora Luogotenente del Regno d’Italia, il principe Umberto di Savoia. Il motivo era il forte movimento indipendentista siciliano, che a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale era diventato molto numeroso, anche con derive di separatismo e secessione.
La Sardegna e l’autonomia limitata
Le prime elezioni dell’Assemblea Regionale Siciliana avvennero nel lontano aprile del 1947, ma già l’anno prima si erano tenute le elezioni in Valle d’Aosta. Inizialmente le Regioni a Statuto Speciale furono quattro: Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. In Sardegna, i politici locali avevano cominciato a parlare di autonomia già alla fine della Seconda Guerra Mondiale (ma ne ottennero poi una più limitata di quella siciliana).
Il Trentino-Alto Adige: la questione altoatesina e le rivendicazioni austriache
In Trentino Alto Adige l’autonomia venne concessa anche per le rivendicazioni territoriali austriache, infatti il governo austriaco trattò con quello italiano per le tutele da dare alla minoranza tedesca, e ci fu anche una sorta di compensazione per l’opera di “italianizzazione” forzata durante il Fascismo.
La Valle d’Aosta e la tutela della minoranza francese
Per motivi simili (la tutela della minoranza francese) venne concesso lo statuto speciale anche alla Valle d’Aosta. Nel 1949 le elezioni regionali si tennero in Sardegna e in Trentino Alto Adige, che successivamente si divise (eliminando l’assemblea regionale unica) nelle due province autonome di Trento e di Bolzano.
Il Friuli-Venezia Giulia: l’ultima Regione a Statuto Speciale
La legge costituzionale che aggiunse anche il Friuli Venezia Giulia venne proposta e approvata solo molto tempo dopo, all’inizio del 1963. In Friuli Venezia Giulia le prime elezioni furono nel 1964: qui l’autonomia venne concessa, oltre che per il problema di Trieste e delle contese territoriali con la Jugoslavia, anche per le criticità di sviluppo economico dell’area.
Competenze e poteri delle Regioni a Statuto Speciale: il caso della Sicilia
Anche le competenze di queste regioni sono diverse. Le più ampie sono quelle della Sicilia, che quindi è la regione “più autonoma” di tutte: solo la Sicilia ha la cosiddetta «competenza esclusiva» in una ventina di campi (tra cui agricoltura, industria, urbanistica, lavori pubblici, turismo e istruzione elementare). In quelle materie, lo Stato centrale non ha potere legislativo in Sicilia e tutte le decisioni sono prese dagli organi regionali. Questa distinzione dei poteri ha causato parecchi problemi nel corso degli anni, con numerosi conflitti di attribuzione e ricorsi alla Corte Costituzionale, dovuti al fatto che le Regioni a Statuto Speciale devono comunque applicare “grandi riforme” statali: le diverse interpretazioni nascono naturalmente quando bisogna decidere che cosa debba essere considerato “grande riforma”.
Regioni italiane a Statuto Speciale: un modello da rivedere?
Negli ultimi anni ci sono state alcuni cambiamenti importanti nell’ambito delle Regioni: la modifica del Titolo V della Costituzione (che riguarda le Regioni, le Province e i Comuni) nel 2001 ha dato più autonomia a tutte le regioni e in un certo senso ha ridotto loro particolarità. Inoltre, in alcune frange politiche, ci sono state molte prese di posizione contro gli statuti speciali, ritenuti “ingiusti”, troppo costosi e da superare con un ordinamento statale di tipo federale o con il cosiddetto regionalismo differenziato previsto dall’articolo 116 della Costituzione. Di certo, osservando il quadro politico di ciascuna di queste regioni, le motivazioni che avevano spinto alla diversa regolamentazione – la spinta indipendentista violenta, le rivendicazioni austriache, la tutela speciale delle minoranze – si sono affievolite.
I referendum in Lombardia e Veneto per una maggiore autonomia
I due referendum regionali che hanno avuto luogo domenica 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto avevano lo scopo di appurare se anche i cittadini di queste due regioni intendessero ottenere forme maggiori di autonomia, sull’esempio delle citate regioni. Per questo motivo conviene esaminare le caratteristiche delle Regioni italiane a statuto speciale e capire se in questo determinato momento storico hanno ancora senso. La questione dell’autonomia regionale e del federalismo è dunque più che mai attuale e il dibattito sul futuro delle Regioni a Statuto Speciale è destinato a proseguire.
[Fonte immagine: https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_italiana_a_statuto_speciale]
Nunzia Serino