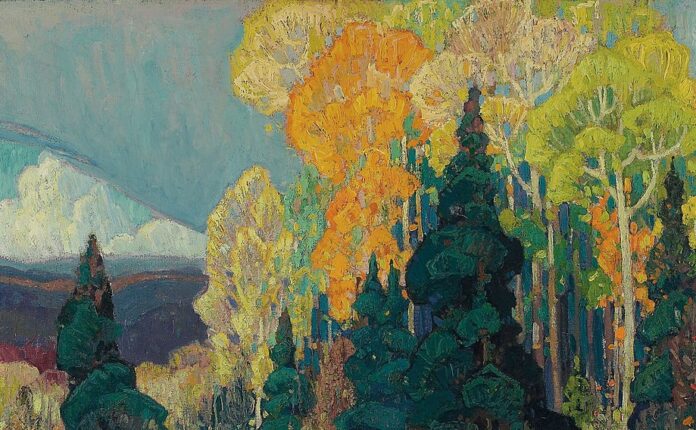Carlo Goldoni (Venezia, 1707 – Parigi, 1793) è stato il più importante commediografo italiano del Settecento e l’artefice di una fondamentale riforma del teatro. La sua vita fu caratterizzata da una passione irrefrenabile per il teatro, che lo portò a un’esistenza inquieta e a continue fughe, dagli studi e dalle città.
Un momento centrale nella sua formazione fu l’incontro con il capocomico del teatro veneziano di San Samuele, che lo convinse a dedicarsi alla scrittura. Tornato a Venezia, Goldoni iniziò a comporre le sue opere, scontrandosi con le convenzioni dell’epoca e subendo accuse di immoralità. Anche a Parigi, il suo stile non fu subito compreso. Morì in miseria durante la Rivoluzione Francese, dopo aver lasciato un’eredità immortale al teatro moderno.
Indice dei contenuti
La riforma del teatro: dalla Commedia dell’Arte al realismo
La riforma del teatro goldoniana fu una vera rivoluzione che mirava a superare i canoni della Commedia dell’Arte, allora dominante in Italia. Goldoni, ispirandosi ai principi dell’Illuminismo, voleva portare sul palco il “Mondo”, ovvero la realtà della società del suo tempo, in particolare quella della nascente classe borghese. La sua riforma, come spiegato da fonti autorevoli come l’Enciclopedia Treccani, si basava su punti precisi.
La riforma goldoniana a confronto
| Prima della riforma (Commedia dell’Arte) | Con la riforma di Goldoni |
|---|---|
| Recitazione basata sull’improvvisazione e un canovaccio (trama generica). | Introduzione del copione con dialoghi interamente scritti. |
| Personaggi fissi e stereotipati definiti dalle maschere (es. Arlecchino, Pantalone). | Abolizione delle maschere e creazione di personaggi con una psicologia definita. |
| Linguaggio spesso volgare e basato su lazzi (battute fisiche). | Linguaggio popolare e realistico, con uso mirato del dialetto per caratterizzare i personaggi. |
| Trama spesso fantastica e inverosimile. | Trama verosimile, ispirata alla vita quotidiana della borghesia veneziana. |
La locandiera di Carlo Goldoni: l’analisi
Scritta nel 1752, La locandiera è considerata il capolavoro di Carlo Goldoni e la massima espressione della sua riforma. La commedia, divisa in tre atti, è incentrata sulla figura di Mirandolina, un personaggio femminile forte, astuto e moderno, che gestisce una locanda a Firenze.
Atto I: la sfida
Mirandolina, abituata a rifiutare le proposte amorose dei suoi clienti, come quelle del Marchese di Forlipopoli (un nobile decaduto) e del Conte d’Albafiorita (un mercante arricchito), rimane incuriosita dall’unico ospite che la ignora: il Cavaliere di Ripafratta, un misogino dichiarato. Offesa dal suo comportamento, la donna decide di usare tutta la sua astuzia per farlo innamorare di lei.
Atto II: la seduzione
La locandiera mette in atto il suo piano. Si mostra indipendente e intelligente, fingendo di condividere il disprezzo del Cavaliere per l’amore. Durante un pranzo, dopo averlo lusingato con attenzioni speciali, Mirandolina finge di svenire per la commozione. Questo gesto calcolato fa crollare le difese del Cavaliere, che cade nel suo tranello e si scopre innamorato.
Atto III: la vittoria e la scelta
Il Cavaliere, ormai in preda alla passione, diventa irriconoscibile e arriva a sfidare a duello il Conte. Mirandolina ha raggiunto il suo obiettivo: ha dimostrato il suo potere. A questo punto, per sedare gli animi e ristabilire l’ordine, dichiara di voler sposare il suo cameriere, Fabrizio, come promesso al padre in punto di morte. La sua è una scelta di convenienza e di classe: sposa un uomo del suo stesso ceto sociale per mantenere la sua indipendenza e la sua locanda. La commedia si chiude con Mirandolina che ammonisce il pubblico sul potere delle donne, rivelando la finalità etica e la profonda introspezione psicologica che Goldoni voleva portare sul palco.
Fonte immagine: Wikimedia Commons
Articolo aggiornato il: 30/09/2025