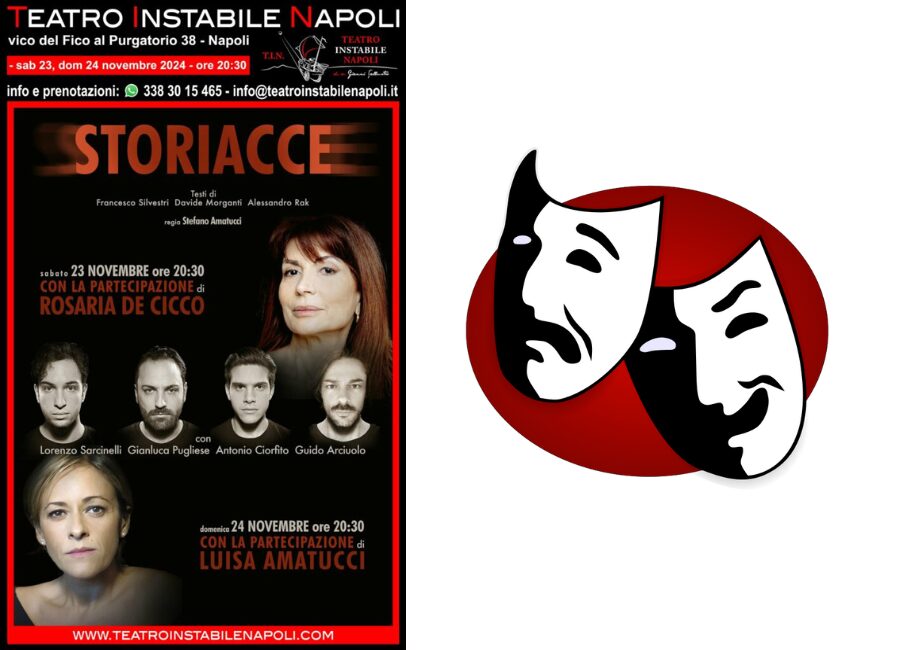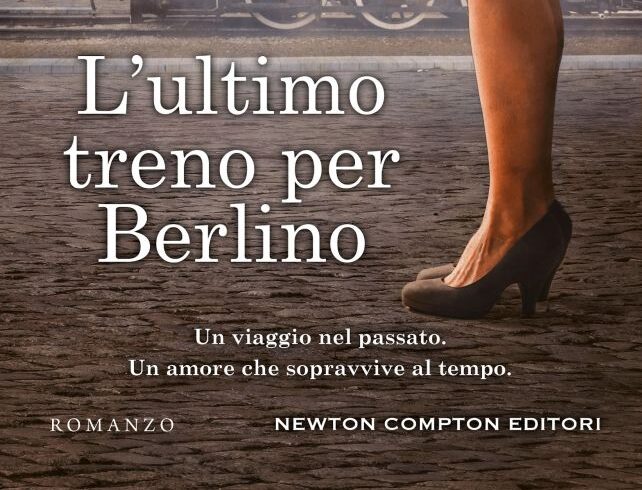Dall’11 al 16 novembre al Teatro Trianon Viviani va in scena Il Testamento di Parasacco (ossia Pulcinella e Felice protetti da un Diavolo sfaticato) per il centenario della morte di Eduardo Scarpetta.
Il Testamento di Parasacco, una delle commedie meno rappresentate di Eduardo Scarpetta, è definita comico-fantastica-spettacolosa e si divide in tre atti. Una scrittura particolarissima, in cui una certa diavolesca magia misteriosa si combina alla commedia, alla farsa, al grottesco e anche all’opera buffa: ossia, una contaminatio di stili e sfumature le quali, riadattate drammaturgicamente nonché dirette sulla scena da Francesco Saponaro, rendono omaggio al padre di una profonda riformulazione del teatro comico napoletano, Eduardo Scarpetta, scomparso ormai cent’anni fa.
Diavolerie di una maschera con un giovane Felice Sciosciammocca

Ci troviamo a Sorrento, nell’età barocca seicentesca: con questa collocazione sia temporale che geografica si apre Il Testamento di Parasacco. Quest’ultimo è una figura leggendaria di cui tutti parlano con terrore, che pare abbia più di cent’anni dopo avere venduto l’anima al Diavolo. Nel frattempo, l’umile famiglia di estrazione popolare appartenente don Macario è alle prese con una vita fatta di stenti e di povertà e soprattutto si ritrova a dovere fronteggiare le angherie del Marchese Asdrubale di Barilotto, che tra l’altro aveva già indotto precedentemente al gioco il capofamiglia ormai suicidatosi per i troppi debiti. Tutto cambia quando nella vita di questa famiglia si presenta un certo Felice Sciosciammocca, un giovane umile e bonaccione pronto a sposare Felicella, una delle nipoti di Macario, con un biglietto vincente alla lotteria che, però, gli viene rubato dagli scagnozzi del marchese. A questo punto, Parasacco si manifesta a Pulcinella lasciandogli come testamento una manciata di pillole da usare cautamente per chiedere aiuto al Diavolo. Così, Pulcinella insieme all’aiuto di un diavolo sfaticato ordisce una vendetta nei confronti del marchese e, tra una serie di equivoci e apparizioni diaboliche, la giustizia viene fatta e tutto finisce con un grottesco lieto fine.
Il Testamento di Parasacco, insomma, ha i tratti di una commedia i cui tratti favolistici, riferendosi a quella sfera grottesca soprannaturale, si combinano in realtà a una concreta satira sociale – pensiamo al continuo scontro tra la società popolare e la società aristocratica che fondamentalmente funge da canovaccio nevralgico. Eduardo Scarpetta scrive la sua commedia nel 1878 per risollevare le sorti del Teatro San Carlino. Tra il vasto repertorio del grande commediografo napoletano, il regista Francesco Saponaro sceglie proprio questa scrittura, nonostante si tratti di una delle meno note, perché si colloca nel solco di un ponte ideale a cavallo tra l’eredità del Pulcinella fino ad Antonio Petito e quella nuovissima del Felice Sciosciammocca di Eduardo Scarpetta; ovvero, si inserisce in quello squarcio di profondo cambiamento della comicità napoletana, tra la centralità della maschera e la centralità dell’attore che ha introiettato la maschera stessa. In virtù di ciò, il testo in questione dimostra di avere una grandiosa apertura, nonché un’evidente ampiezza di forme, per cui si presta allo scopo di rileggere quella lunga e variegata tradizione teatrale napoletana. È il recupero di una radice, di quell’identità così caratteristica che troppo spesso viene in un certo senso abusata. Quella di Saponaro, dunque, non è tanto l’ennesima scelta celebrativa del napoletano quanto, anzi, un’operazione sottile di conoscenza, di consapevolezza e, quindi, di memoria.
Il Testamento di Parasacco: l’arte della memoria

Francesco Saponaro, recuperando una commedia come Il Testamento di Parasacco poco nota e come si è visto fin qui così aperta a molteplici forme e possibilità, affronta il tedioso argomento della memoria quanto mai attuale. In un panorama artistico come quello contemporaneo fatto di concettualizzazioni, effetti speciali e schermi, spesso ci si dimentica di conoscere la radice. La questione riguarda la consapevolezza dell’identità, la conoscenza di ciò che nel solco di una lunga tradizione l’ha forgiata. Non a caso, il regista nei ringraziamenti finali della prima messinscena precisa un doveroso grazie a quei giganti del teatro che ci hanno permesso in qualche modo di stare su quelle tavole del palcoscenico. E ancora, non è un caso neanche che il tutto avvenga nella sala del Teatro Trianon Viviani che, sotto la direzione di Marisa Laurito, da tempo abbraccia il nobile intento di restituire importanza alla tradizione partenopea. Ma la memoria non può essere un procedimento fine a sé stesso, altrimenti il rischio è proprio quello di portare spettacoli polverosi che ricadono sulla loro celebrazione dei fasti antichi. Anzi, essa ha la necessità di un contatto che la riporti nel presente. Per questo motivo il lavoro è interessante, perché si colora anche di riferimenti e di venature pop.
Eppure, c’è sempre un po’ la percezione che questa contaminazione pop resti in superficie, mantenendo il recupero della memoria su un piano filologico e l’intenzione di spolverarla su una verve un po’ timida. L’idea diventa quella di entrare in un museo, cosa importante, sicuramente, ma che se non si intinge di quella giovialità grintosa che coinvolge rischia di diventare distante da un punto di vista emotivo, un’esposizione anche abbastanza eccessiva e ridondante. Sebbene si tratti di uno spettacolo diverso, ma comunque figlio di Scarpetta e delle stesse intenzioni presenti, possiamo fare un paragone con Il medico dei pazzi nella versione di Leo Muscato: nella sua estrema semplicità (che non ha niente a che vedere con il lavoro di equilibrio stilistico e formale de Il Testamento di Parasacco, questo sia per la natura della scrittura e sia per il modo in cui è stata affrontata) è comunque riuscito a incidere un profondo coinvolgimento che a suo modo ha portato la platea a buttare un occhio su alcune riflessioni presenti, senza nulla togliere a quello scopo anche un po’ satirico. Il lavoro di Saponaro, invece, ha una portata molto più corale e complessa, ma ruota su una domanda che pesa quanto un macigno: nell’effettivo, a chi si rivolge?
Fonte immagini: Ufficio Stampa – foto di Pino Miraglia