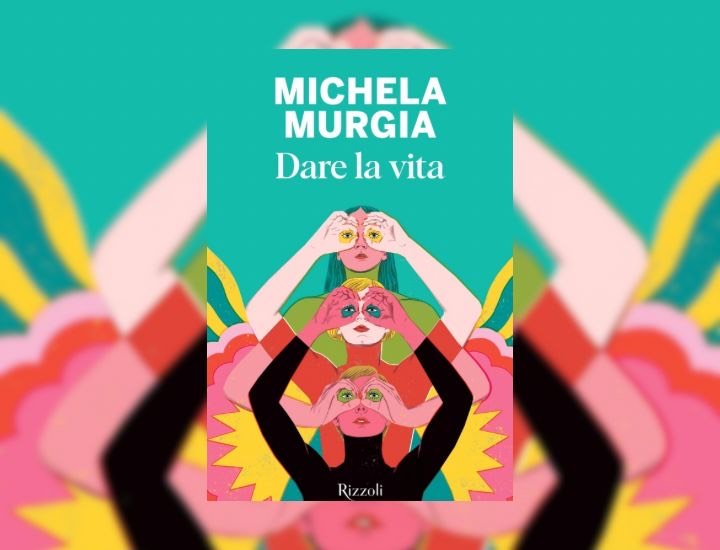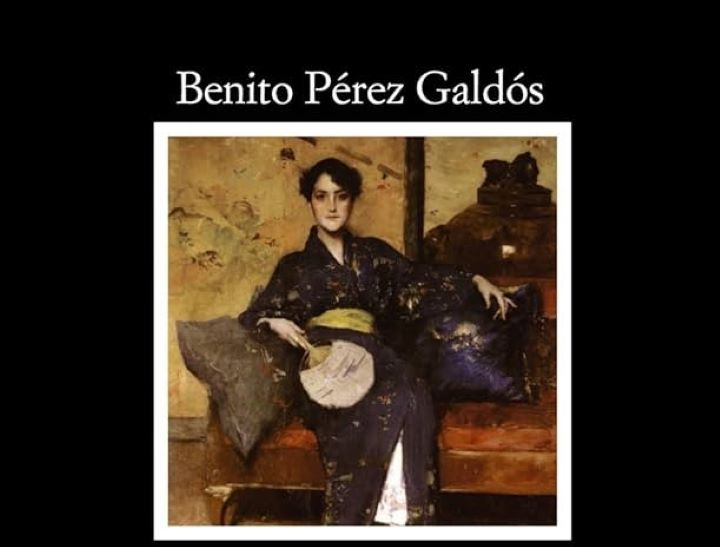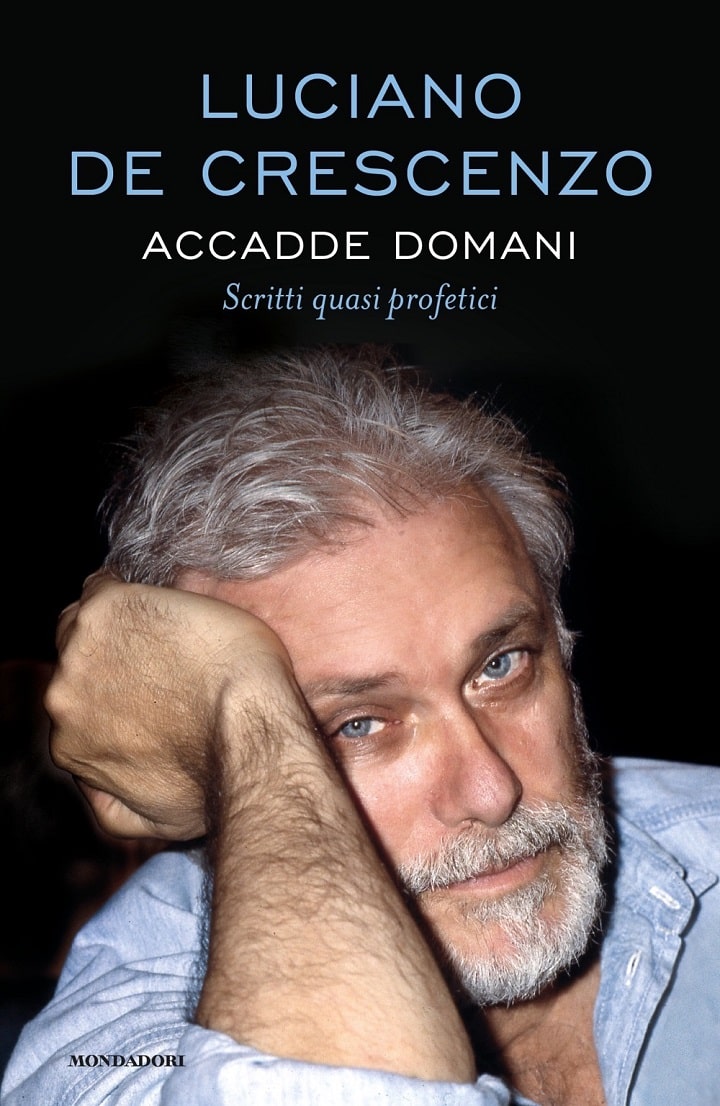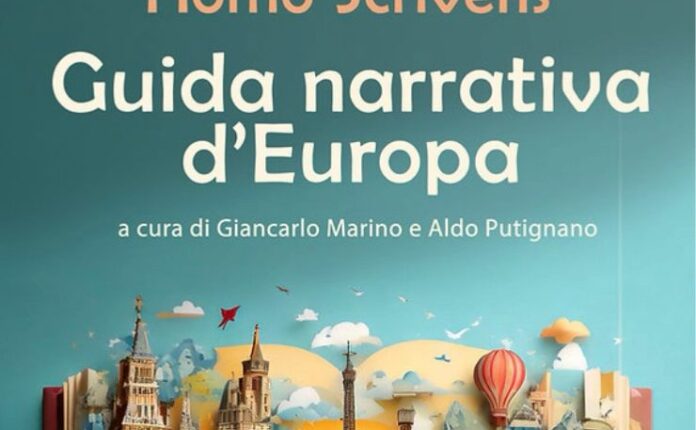All’ora di pranzo di una domenica autunnale che sa ancora d’estate incontriamo Alessio Forgione, scrittore ormai affermato nel panorama nazionale e internazionale, che dopo i successi di Napoli mon amour e Giovanissimi, presenta in occasione della fiera Ricomincio dai Libri, il suo nuovo romanzo, Il nostro meglio edito dalla casa editrice La nave di Teseo. Lorenzo Marone e Antonio Menna ci accompagnano tra le pagine di un libro che porta il lettore in una «Napoli fuori le mura» che sempre Napoli è, però, forse meno luccicante e affollata da tavolini e rivenditori di cibo d’asporto, oltre che di teatri e librerie, che è quella dove i ragazzi attendono che la vita li percorra, li attraversi, ma che, a scapito di quanto si possa immaginare, pure vivono, sognano, magari inconsciamente, ma desiderano. E in questa Napoli ritroviamo Amoresano, che è un ventenne, e in quanto tale «non sa come gestire le sue energie e quindi le spreca» ci racconta Forgione, che infondo poi è un altro modo per dire crescere. Un libro sull’attesa, un’attesa che i titoli dei capitoli scandiscono in un conto alla rovescia che toglie il fiato, e che condurrà al compimento di una sentenza di morte spaventosamente familiare in questi luoghi, in quel flusso ipnotizzante che è la scrittura di Alessio Forgione.
Lo abbiamo intervistato per cercare di scavare un po’ nella struttura e nel laboratorio dello scrittore, in quello che c’è dietro e dentro Il nostro meglio.
-Innanzitutto il titolo del libro, perché lo hai scelto e come nasce? È stato il primo, o ne avevi altri in mente?
«Non tutti i personaggi del romanzo nascono in una condizione di vita agiata, ma cercano comunque di fare del proprio meglio, e poi ci sono alcuni che invece nascono privilegiati, e anche loro cercano di fare del proprio meglio e quindi mi sembrava un po’ quella cosa che accomuna tutte le persone, o almeno quelle oneste, quelle che cercano di avere la vita che desiderano, facendo del proprio meglio appunto. È un titolo che è venuto dopo un po’, uno degli altri era Un altro mondo, ma mi sembrava di escluderne uno, come a dire è esistito ma non esiste più, perduto in un’età dell’oro, e non mi piaceva questo senso di esclusione. Il nostro meglio penso che invece racchiudesse tutto, anche di più.»
-I tuoi personaggi mi sembrano immersi nel presente, e insieme chiusi in una bolla, nella loro individualità; nello specifico Amoresano, il protagonista, è come se in questo libro prendesse la parola dopo aver a lungo taciuto, e la sua voce è come un flusso, che non può interrompersi dopo un lungo silenzio; è giusta questa interpretazione?
«Assolutamente, Amoresano sappiamo, per chi ha letto Napoli mon amour, che si laureerà, che è un giovane colto in un contesto dove non ci sono interlocutori, la madre è diplomata, i nonni hanno la terza elementare, in casa non ci sono libri, gli altri sono delle presenze, ma non puoi parlare di tutto… dei libri non può parlare con nessuno, dell’introspezione, e lui è uno di quelli che quando trova un interlocutore gli fa una capa tanta, l’interlocutore potrebbe essere se stesso o forse Maria Rosaria, che fa la tabaccaia e lui va lì e le porta dei libri, come capita nella vita, sperando di trovare qualcuno con cui parlarne, ma magari non succede, perché comunque per la lettura serve un allenamento, ti serve un percorso precedente, che lui fortunosamente ha fatto, ma lui non ha interlocutori.»
-Il legame con Lessico famigliare, lo riscontri?
«Natalia Ginzburg mi piace tanto ed è un riferimento, non solo per questa storia ma in generale, come lo sono la Morante, la Ortese, per me fondamentali, ma non ci sono veri riferimenti in questo libro. Non volevo scrivere un Lessico famigliare 2.0, volevo scrivere il mio romanzo; ci sono io, c’è la mia persona, e alla mia persona piacciono tante cose, tra cui anche Lessico famigliare, ma non è un riferimento diretto.
Ho letto però che Il nostro meglio veniva definito una sorta di Educazione sentimentale maschile, e mi piace, perché è sicuramente un libro di donne, perché contrariamente ai tempi, Napoli è sicuramente una città dove il patriarcato agisce di meno perché è matriarcale, le donne nelle famiglie sono sicuramente a capo, quindi in un contesto familiare questo ragazzo è l’oggetto protetto di queste donne, che sicuramente gli insegnano a vivere. È questo un po’ il tema; Napoli è sicuramente una città dove le donne hanno lo spazio che si meritano e siamo messi male lo stesso, sicuramente si dovrà fare tanto e tanto altro, ma Napoli è una città dove non ci sono veri stranieri, se non i napoletani per altri napoletani, ma lo straniero non è veramente straniero, come anche per gli omosessuali, che si vivono la città in assoluta normalità, come deve essere, quindi non stiamo così rovinati, ma c’è ancora tantissimo da fare. Non va tutto male, e quel pochino che va bene, teniamolo.»
–I tuoi libri dimostrano che qui c’è tanto bene; tu parli delle periferie…
«Parlo delle periferie, e del centro, ma arrivandoci, come uno spettatore.»
-Un’altra cosa interessante è che tu dici che una storia per essere giusta deve passare per la vergogna, in questo libro c’è qualcosa di cui ti vergogni? Spiegaci meglio questo rapporto.
«Mi vergogno di tutto il libro, perché comunque metti in mostra quelle cose che sono veramente private, e le rendi pubbliche in un mondo che non è un mondo tenero, però la sfida è quella di scrivere un romanzo così tenero in un mondo non tenero che lo tratterà teneramente, quella è la sfida. Però l’argomento di cui uno si vergogna a parlare è quello giusto di cui scrivere, perché quando tu scrivi e sei da solo e scrivi a te stesso, non escludendo il mondo, perché altrimenti diventa una turba psichica non un romanzo, però mettendoti lì davanti, ti rendi conto che la scrittura scava nella direzione che non vorresti prendere e magari lasciarla nascosta, anche a te stesso. Amoresano usa la metafora dello speleologo; devi scendere fino in fondo per vedere cosa c’è e magari non c’è nulla, e scopri che il dolore non serve a nulla, non ti rende migliore, però se ti fermi prima, avrai incertezze, invece scrivere non lascia nulla d’incerto.»
-Sei contro chi dice che ama la scrittura, perché?
«L’amore per la scrittura lo hanno le persone che non scrivono, se a uno scrittore piace scrivere, non è uno scrittore, al 100%, lo scrittore è uno che ha delle cose da dire, e crede di doverle dire, e ha l’arroganza per dirle, ma deve anche avere la modestia di passarci sopra, centinaia e centinaia di volte, per togliere, non mettere, e rendere quella cosa liscia.
Un percorso tormentato, non una cosa bella. A me piace leggere, anche quando il libro è brutto, è sempre bello leggere. Scrivere, invece, non è un’attività piacevole, perché ti mette in faccia alle tue mancanze; è la tua mente che ha deciso cosa scrivere, e a me non piace.
Un romanzo viene fuori quando chi lo ha scritto, ha scritto in maniera scomoda, e allora là risulta qualcosa che ha una dose di sincerità e che le persone leggeranno per sapere una vera verità, e nel mondo non ce ne sono molte, di vere verità, i libri possono esserlo. Io leggo per questo.»
Grazie ad Alessio Forgione per la sua disponibilità e cordialità.