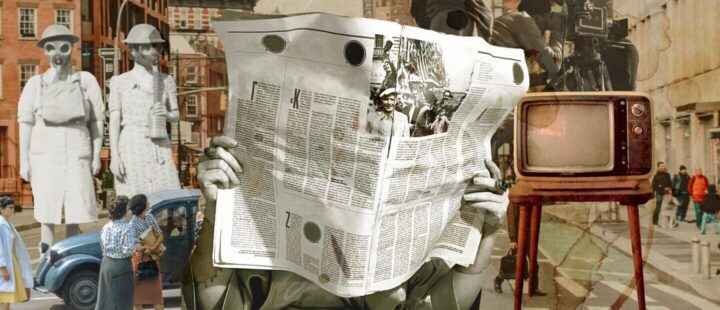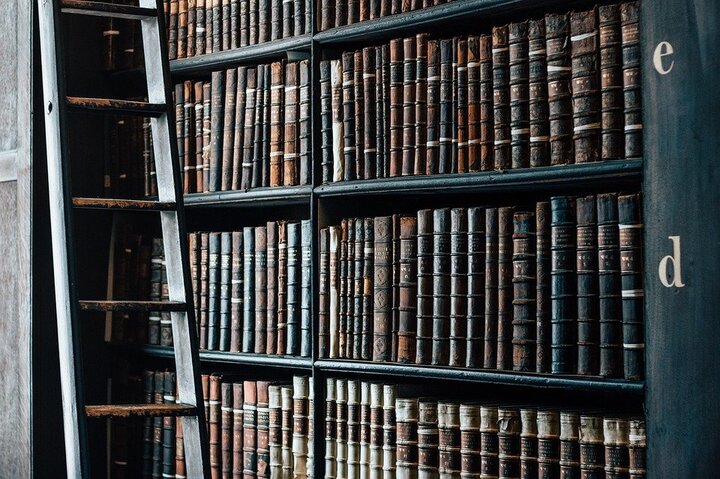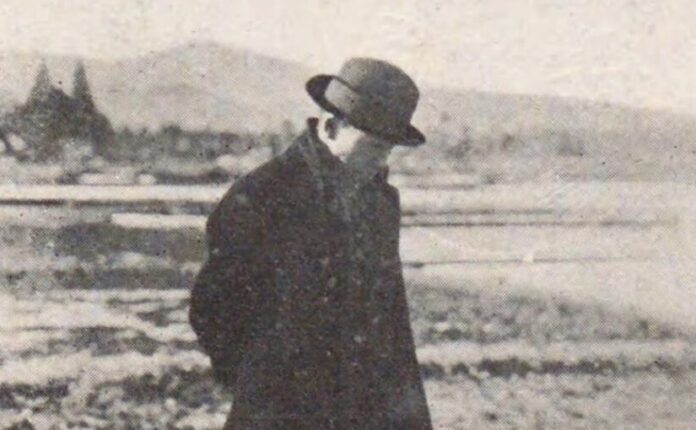Nella storia del pensiero occidentale, il tema della scelta ha occupato un posto centrale. Due figure monumentali che hanno affrontato questo concetto in modi profondamente diversi, ma ugualmente influenti, sono il poeta fiorentino Dante Alighieri e il filosofo danese Søren Kierkegaard. Sebbene separati da secoli, il loro dialogo a distanza offre una visione completa della scelta, da un lato come bivio morale universale, dall’altro come abisso esistenziale individuale.
Indice dei contenuti
Dante Alighieri: la scelta morale e la giustizia divina
Nella Divina Commedia di Dante Alighieri, il tema della scelta morale è l’architrave dell’intera opera. Il viaggio attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso è una rappresentazione allegorica del cammino dell’anima, che deve costantemente operare scelte per raggiungere la salvezza. Queste decisioni sono presentate come bivi netti, che determinano il destino eterno. Un esempio emblematico è la scelta tra la “via di qui” e la “via di là”, dove Dante deve decidere se affidarsi alla guida di Virgilio o cercare una strada alternativa. Il sistema dantesco è governato da una giustizia divina oggettiva: a ogni scelta corrisponde una conseguenza precisa e immutabile.
Søren Kierkegaard: la scelta esistenziale e il peso dell’angoscia
Nel XIX secolo, Søren Kierkegaard affronta il problema della scelta in modo radicalmente diverso, ponendo l’individuo al centro di tutto. In polemica con l’idealismo hegeliano, che vedeva il singolo come una semplice manifestazione dell’Assoluto, Kierkegaard sottolinea l’irriducibile unicità dell’esistenza individuale. Nella sua opera fondamentale Aut-Aut (Enten-Eller), il filosofo danese presenta la scelta non come un problema morale, ma esistenziale. Scegliere significa definire sé stessi. Questo processo genera “angoscia”, il sentimento di vertigine che l’uomo prova di fronte alla possibilità infinita e alla totale responsabilità delle proprie decisioni. Per Kierkegaard, l’individuo è condannato a scegliere, e questa scelta determinerà il corso della sua vita, indipendentemente da una presunta giustizia divina esterna.
Kierkegaard e Dante a confronto: due abissi, un bivio
Mentre Dante si concentra su una scelta morale inquadrata in un sistema di giustizia divina, Kierkegaard esplora la sfera dell’angoscia esistenziale e della soggettività. Entrambi, però, riconoscono che le scelte hanno conseguenze profonde e irreversibili.
| La scelta in Dante Alighieri | La scelta in Søren Kierkegaard |
|---|---|
| Natura della scelta: morale e oggettiva, basata su un ordine divino. | Natura della scelta: esistenziale e soggettiva, basata sulla libertà individuale. |
| Contesto: un universo teologico con premi e punizioni eterne. | Contesto: la vita del singolo, caratterizzata da dubbio, possibilità e angoscia. |
| Conseguenza: salvezza o dannazione, determinate da un giudizio esterno. | Conseguenza: definizione del proprio essere, con piena responsabilità personale. |
| Riferimento chiave: la Divina Commedia. | Riferimento chiave: Aut-Aut (Enten-Eller). |
La condanna della non-scelta: il punto d’incontro
Ciò che accomuna in modo sorprendente questi due pensatori è la ferma condanna della “non-scelta”. Per Dante, chi vive “sanza ‘nfamia e sanza lodo”, ovvero gli ignavi del Canto III dell’Inferno, è più disprezzabile dei peccatori stessi. La loro punizione è inseguire nudi un’insegna senza significato, punti da vespe e mosconi, poiché in vita non hanno mai seguito alcun ideale. La loro pena più grande, come sottolinea Virgilio, è l’oblio: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Anche per Kierkegaard, come evidenziato da fonti accademiche come la Stanford Encyclopedia of Philosophy, non scegliere è già una scelta, la peggiore possibile. È un “salto nel buio” che non porta alla libertà, ma a una condizione di smarrimento e paralisi, tipica dello stadio estetico, in cui l’uomo, per non scegliere, si disperde nelle infinite possibilità senza mai realizzarsi.
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 07/10/2025