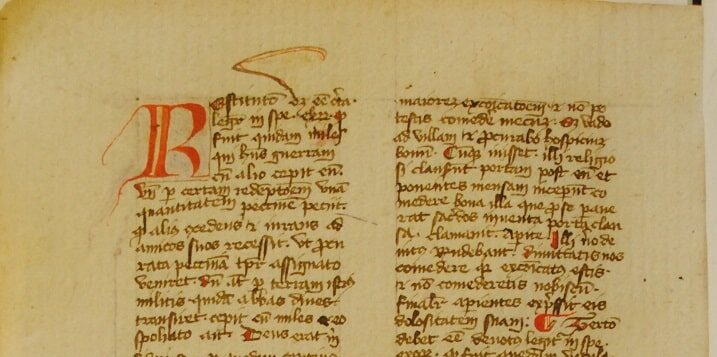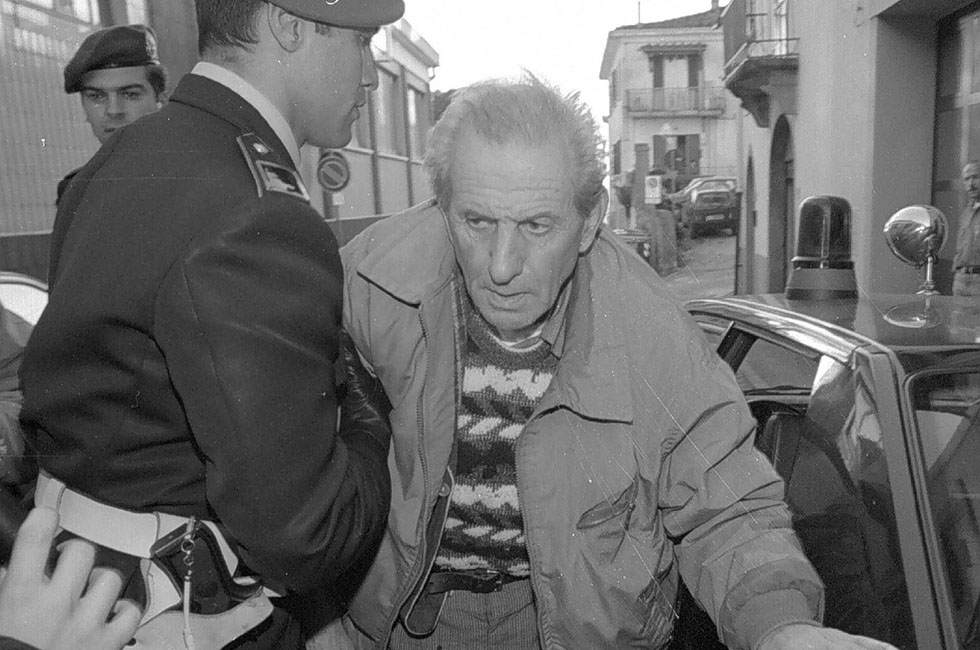La poesia dei trovatori provenzali è un sistema definito di codici e metri che ha gettato le basi della lirica moderna. Il principio fondamentale di questa poesia è l’organizzazione del testo in coblas, ovvero stanze (o strofe) costruite secondo precisi schemi di rime e parole. Tra le varie tipologie, le coblas capfinidas sono una tecnica specifica in cui una parola o un’intera rima che chiude una strofa viene ripresa nel primo verso della strofa successiva, creando un forte legame concettuale e sonoro.
Indice dei contenuti
Le diverse tipologie di Coblas
Per comprendere appieno le capfinidas, è utile conoscere le altre forme di coblas utilizzate dai trovatori, classificate in base alla ripetizione delle rime tra le strofe.
| Tipo di cobla | Schema della rima |
|---|---|
| Singularis | Ogni strofa presenta rime nuove e diverse dalle altre. |
| Doblas | Le rime sono uguali a coppie di strofe (la 1ª con la 2ª, la 3ª con la 4ª, etc.). |
| Ternas | Le stesse rime si ripetono per tre strofe consecutive. |
| Capcaudadas | La rima finale di una strofa diventa la rima iniziale di quella successiva. |
| Capfinidas | Una parola o rima finale di una strofa viene ripresa all’inizio del primo verso della successiva. |
Funzione ed esempi di Coblas Capfinidas
Questa tecnica non è un semplice artificio stilistico; la sua funzione poetica è quella di creare una stretta concatenazione logica e sonora tra le strofe, garantendo continuità al discorso e rafforzando il tema centrale. Molti autori hanno utilizzato questa forma per guidare l’ascoltatore attraverso il componimento. Tra i trovatori provenzali, un esempio noto è Guiraut Riquier, che nella canzone Res no·m val mos trobars (qui il testo completo) struttura le prime cinque coblas come capfinidas. Un altro trovatore, Peire Bremon, usa lo stesso procedimento in Pois lo bels temps renovella (qui il testo completo).
Anche la poesia italiana delle origini, in particolare la scuola siciliana, ha adottato questa tecnica. Uno dei primi a farlo è stato Guittone d’Arezzo nella canzone Ahi lasso, or è stagion de doler tanto, dove l’ultima parola di ogni strofa è la prima di quella successiva, ad eccezione del congedo. Anche il padre del dolce stil novo, Guido Guinizelli, usa un procedimento analogo in Al cor gentile rempaira sempre amore.
La differenza con il Leixaprén galego-portoghese
Una tecnica simile ma distinta si ritrova nella lirica galego-portoghese, sviluppatasi in area iberica tra il XII e il XIV secolo. Si tratta del leixaprén (in italiano “lascia e prendi”), una figura stilistica che consiste nel ripetere il secondo verso di una strofa come primo verso della strofa successiva. La differenza fondamentale con le coblas capfinidas è che nel leixaprén si ripete un intero verso (anche con parole in ordine diverso), mentre nelle capfinidas la ripresa è limitata a una singola parola o a un gruppo di parole in rima. Questo procedimento è tipico delle cantigas de amigo, il cui maggiore rappresentante è Martín Codax.
Nei suoi sette componimenti (qui il testo completo), il filologo Giuseppe Tavani ha notato come il leixaprén serva a enfatizzare lo stato d’animo dell’io poetico, una giovane donna che attende invano il ritorno del suo amato.
Leggi anche: Madrigale, cos’è
Endecasillabi della letteratura italiana: i nove più belli
Versi della metrica italiana: poesia e ritmo
Immagine in evidenza: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 31/08/2025