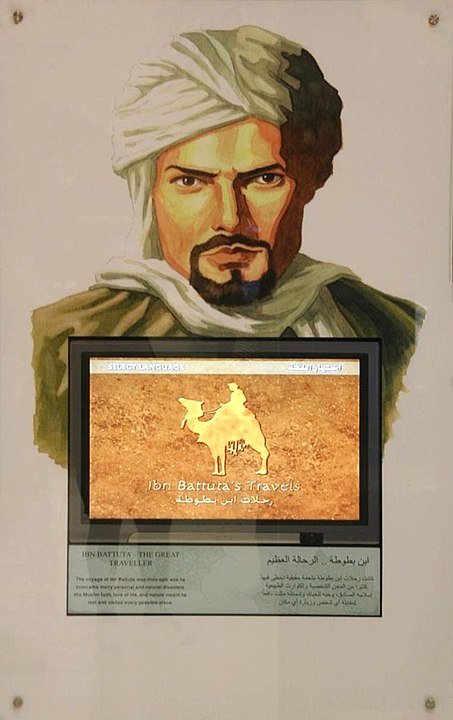Il male di vivere nell’opera di Eugenio Montale.
È il 1925 quando un giovane Eugenio Montale pubblica la sua prima raccolta di versi. L’opera, intitolata Ossi di seppia, esce presso le edizioni di Pietro Gobetti, con cui il poeta genovese aveva iniziato a collaborare già qualche mese prima, scrivendo numerosi articoli e saggi per la rivista gobettiana Il Baretti. In uno di questi, dal titolo Stile e tradizione, Montale delinea i fondamenti della sua raccolta: rifiuta le esperienze avanguardiste – incluse quelle da cui era partito Giuseppe Ungaretti – e afferma che il dovere di un poeta è di portare il proprio linguaggio verso “la semplicità e la chiarezza, a costo di sembrar poveri”.
Il male di vivere: Ossi di seppia
L’essenzialità che il poeta intende raggiungere risiede anzitutto nel titolo della raccolta: gli «ossi di seppia», infatti, simboleggiano l’aridità, l’erosione e il logoramento operato dalla natura. Il paesaggio descritto è arido e brullo, come scavato dai raggi del sole, allucinato e dalle valenze fortemente metafisiche. Inoltre, sin dall’apertura di Ossi di seppia egli non può che mostrarsi critico nei confronti dei “poeti laureati” – cioè della tradizione poetica aulica e ufficiale – che mostrano la loro presunta superiorità utilizzando termini artefatti ed astratti per definire concetti semplici.
A questi, Montale preferisce (in accordo coi crepuscolari o vociani) le “piccole cose”, ossia oggetti ed immagini ben definite che rimandano alla realtà circostante. Non certo i «bossi ligustri o acanti», dunque, ma gli orti ravvivati dal giallo e dalla freschezza dei limoni. Le figure evocate dal poeta ligure, tuttavia, sono ben distanti dall’essere semplici e lineari e rimandano sempre a qualcos’altro: sono veri e propri simboli, e in quanto tali vanno decodificati. In esse è riportato il destino dell’uomo, fatto tanto di incostanti e incerte speranze, quanto, soprattutto, di fragilità e morte.
Un esempio chiaro di questa tecnica – definita dai critici “correlativo oggettivo” – sta nella poesia Spesso il male di vivere ho incontrato, in cui Montale descrive, attraverso delle immagini concrete, la condizione esistenziale dell’uomo moderno, solo, disperato e incapace persino di comunicare con gli altri uomini suoi simili: “il male di vivere” si materializza come una presenza fisica e tangibile (mediante il verbo «ho incontrato») e viene rivelato con «il rivo strozzato che gorgoglia», «l’incartocciarsi della foglia / riarsa» e «il cavallo stramazzato». Alcune di queste figure che, in altri contesti, evocherebbero senz’altro felicità e gioia di vivere diventano, nella poesia di Ossi di seppia, simboli neppure troppo opachi del malessere e del tormento affannoso che attanaglia Montale.
L’epifania del nulla, dell’assurdo di esistere viene descritto dal Montale anche in un altro breve componimento, dal titolo “Forse un mattino andando in un’aria di vento”. Qui, l’aridità della natura («in un’aria di vento / arida») è il correlativo oggettivo di quel vuoto che tormenta gli uomini. La rivelazione avviene all’improvviso, come per «miracolo», e provoca un «terrore» simile a quello di chi, perché «ubriaco», ha perso l’equilibrio e non riesce a reggersi. È la folgorazione di un attimo, dopodiché tornano a profilarsi, dinanzi agli occhi, «aberi case colli», cioè gli oggetti consueti della realtà, che però sono ormai un inganno, nient’altro che illusioni proiettate su uno «schermo».
Non c’è nient’altro da fare – per chi ha scoperto l’inganno della realtà, per chi si trova a dover convivere col “mal di vivere” – che andare «zitto / tra gli uomini che non si voltano» o, in alternativa, affidarsi al «prodigio / che schiude la divina Indifferenza», la quale, riprendendo il pensiero leopardiano, resta passiva e insensibile di fronte ai sentimenti umani. L’unico “bene” – se di bene si tratta – sta nell’assumere l’insensibilità stoica, fredda e marmorea de «la statua nella sonnolenza / del meriggio» oppure nel levarsi alti in cielo, al di sopra della miseria del mondo, come fanno «la nuvola, e il falco».
Fonte immagine: Wikipedia