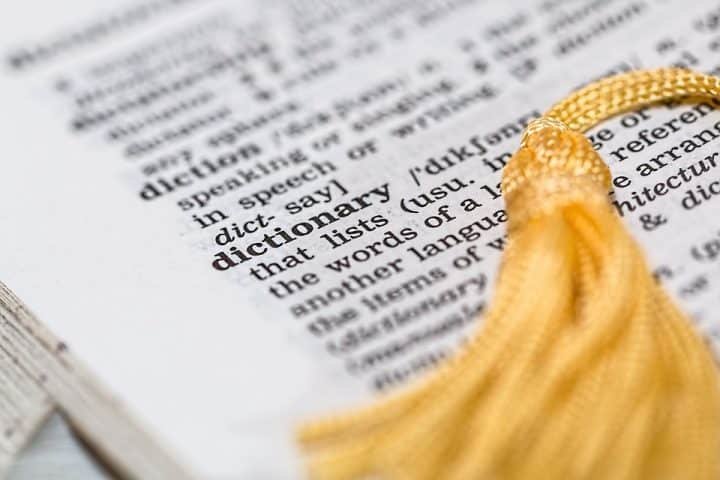Con il nome di crociata dei pastorelli si identificano due distinte insurrezioni popolari, avvenute nel 1251 e nel 1320. Entrambe nacquero spontaneamente, senza l’appoggio di governanti o nobili, come espressione di un profondo malcontento sociale e religioso che attraversava i ceti più umili della popolazione.
Indice dei contenuti
Le due crociate dei pastorelli a confronto
Per comprendere le differenze e le somiglianze tra i due movimenti, la seguente tabella ne riassume le caratteristiche principali.
| Caratteristica | Seconda Crociata (1320) |
|---|---|
| Causa Scatenante | Esasperazione per l’indifferenza della nobiltà francese |
| Leader | Un monaco cistercense detto “Maestro d’Ungheria” |
| Obiettivo Principale | Punire la corruzione del clero e liberare il re |
| Vittime Principali | Clero (accusato di corruzione) |
| Esito | Repressione ordinata da Bianca di Castiglia dopo la scomunica di Papa Innocenzo IV |
La prima crociata dei pastorelli (1251)
Il primo movimento nacque in un contesto di grave crisi politica e sfiducia verso le istituzioni.
Il contesto: la prigionia di Luigi IX e il malcontento
Nel 1250, la notizia che re Luigi IX di Francia era stato fatto prigioniero dai musulmani in Egitto scatenò un’ondata di malcontento popolare in tutta la Francia. La gente comune percepiva la nobiltà e il clero come inerti e corrotti, incapaci di difendere la cristianità e il proprio sovrano.
Chi guidò la crociata dei pastorelli del 1251?
A farsi portavoce di questa rabbia fu un carismatico monaco cistercense noto come Jacob o Maestro d’Ungheria. Con la sua eloquenza, radunò un esercito eterogeneo composto da contadini, pastori, emarginati e anche criminali, convincendoli che solo i puri di cuore avrebbero potuto liberare il re. Persino Bianca di Castiglia, madre di Luigi IX, inizialmente appoggiò il movimento, vedendovi una sincera spinta religiosa.
Come finì la crociata del 1251?
La rivolta si trasformò presto in un attacco violento contro il clero, accusato di corruzione e sodomia. Preti e monaci furono fustigati pubblicamente. Quando il movimento iniziò a saccheggiare chiese e proprietà, la situazione divenne insostenibile. Papa Innocenzo IV scomunicò i rivoltosi e la stessa regina Bianca, resasi conto del pericolo, ordinò alle truppe reali di reprimere l’insurrezione, che fu soffocata nel sangue.
La seconda crociata dei pastorelli (1320)
Circa settant’anni dopo, durante il regno di Filippo V il Lungo, un nuovo movimento spontaneo, anch’esso detto dei pastorelli, infiammò la Francia.
Il saccheggio e le violenze contro gli ebrei
Anche in questo caso, la rivolta partì da gente comune esasperata dall’indifferenza dei governanti. Tuttavia, la violenza di questo secondo movimento si diresse principalmente contro le comunità ebraiche. I “pastorelli” (circa 40.000 persone) saccheggiarono Parigi, l’Aquitania e altre regioni, accusando gli ebrei di essere usurai e nemici della fede, spesso con il sostegno delle popolazioni locali. A Verdun-sur-Garonne, circa 500 ebrei si tolsero la vita per non cadere nelle mani dei rivoltosi.
Come finì la crociata del 1320?
Per fermare le violenze, Papa Giovanni XXII, da Avignone, lanciò la scomunica contro il movimento. I rivoltosi, per tutta risposta, presero la scomunica come una sfida e marciarono verso la sede pontificia. Furono però intercettati dalle truppe del siniscalco di Carcassonne e dispersi nelle paludi della foce del Rodano, dove fame e retate militari posero fine alla loro rivolta.
Un’analisi del fenomeno: rivolta sociale e religiosa
A differenza delle crociate ufficiali, quelle dei pastorelli non furono primariamente spedizioni militari in Terrasanta. Esse rappresentarono piuttosto una potente valvola di sfogo per il malcontento dei ceti più bassi. Furono un fenomeno complesso in cui la fede religiosa si mescolava a una profonda istanza di rivolta sociale contro un sistema percepito come ingiusto, incarnato da un clero corrotto, da una nobiltà assente e da minoranze usate come capro espiatorio.
Immagine in evidenza Crociata dei pastorelli: Wikipedia
Articolo aggiornato il: 01/09/2025