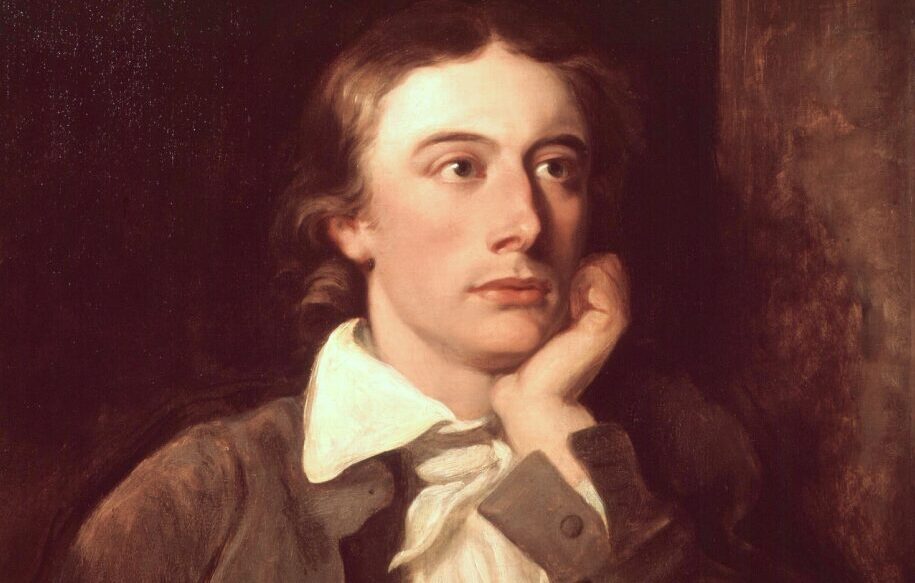I superstiti della Shoah sono le persone sopravvissute al genocidio e alle persecuzioni razziali e politiche portate avanti dalla Germania nazista di Hitler e dall’Italia fascista. Le vittime furono principalmente gli ebrei, ma anche chiunque fosse considerato “inferiore” alla razza ariana, come rom, omosessuali e oppositori politici. Secondo un report del 2024 della Claims Conference, oggi si contano circa 245.000 superstiti nel mondo, un numero che diminuisce ogni anno, rendendo le loro testimonianze ancora più preziose.
Salito al potere nel 1933, Hitler iniziò subito la sua opera di isolamento e successiva eliminazione di tutte le persone che non considerava degne di vivere. Il suo primo obiettivo furono i disabili, con il programma Aktion T4, poi la comunità rom e infine gli ebrei, contro i quali si scatenò una persecuzione sistematica.
Indice dei contenuti
Riepilogo dei superstiti della Shoah
| Nome del superstite | Dati salienti |
|---|---|
| Liliana Segre | Nata nel 1930. Deportata ad Auschwitz-Birkenau (n. 75190). Testimone instancabile e senatrice a vita. |
| Primo Levi | Nato nel 1919. Deportato ad Auschwitz (n. 174517). Chimico e autore di “Se questo è un uomo”. |
| Otto Frank | Nato nel 1889. Deportato ad Auschwitz. Unico sopravvissuto della sua famiglia, pubblicò il diario della figlia Anna. |
| Samuel Modiano | Nato nel 1930. Deportato ad Auschwitz-Birkenau (n. B7455). Attivo testimone della Shoah. |
| Viktor Frankl | Nato nel 1905. Deportato in vari campi tra cui Auschwitz. Psichiatra e fondatore della logoterapia. |
Il contesto storico: dalle leggi di norimberga alla “soluzione finale”
Nel 1935 vennero promulgate le leggi di Norimberga. La prima, la “legge per la protezione del sangue e dell’onore tedeschi”, introduceva una serie di divieti per preservare la presunta purezza della razza, vietando i matrimoni misti tra tedeschi ed ebrei e stabilendo una rigida casistica genetica per definire chi fosse ebreo. Anche l’Italia fascista adottò una propria legislazione antisemita con il Regio decreto-legge del 17 novembre 1938, che diede inizio alla persecuzione sistematica degli ebrei italiani.
La seconda legge di Norimberga, la “legge sulla cittadinanza del Reich”, stabiliva chi potesse godere della piena cittadinanza, escludendo di fatto sia gli ebrei sia i cosiddetti mischlingen (mezzosangue). Queste due leggi costituirono l’ossatura normativa che, negli anni successivi, portò alla progressiva privazione di tutti i diritti civili per la popolazione ebraica.
Il passo ulteriore si ebbe il 20 gennaio 1942, durante la Conferenza di Wannsee. In una villa alla periferia di Berlino, fu pianificata scientificamente l’eliminazione degli ebrei d’Europa, la cosiddetta “soluzione finale“. Venne stilato un elenco che contava circa 11 milioni di persone da sterminare.
Nel 1945, la Seconda Guerra Mondiale terminò con la sconfitta della Germania, che non riuscì nel suo intento di sterminio totale. Le storie dei sopravvissuti, molti dei quali si sono distinti in vari ambiti dopo la liberazione, rimangono una testimonianza fondamentale di quegli orrori.
Le storie di alcuni sopravvissuti
I testimoni della Shoah sono uomini e donne che hanno vissuto l’orrore dei campi di concentramento e hanno scelto, spesso dopo anni di silenzio, di raccontare la loro esperienza per preservare la memoria. Di seguito sono riportate le storie di alcuni dei nomi più conosciuti.
Liliana Segre
Nata a Milano nel 1930 da una famiglia laica di origine ebraica, si rese conto della sua identità solo con le leggi razziali del 1938, che la espulsero da scuola. Nel 1944, a soli tredici anni, dopo un fallito tentativo di fuga in Svizzera, venne deportata ad Auschwitz-Birkenau. Lì le venne assegnato il numero 75190 e fu costretta a lavorare in una fabbrica di munizioni. Trasferita in diversi campi, fu liberata dall’Armata Rossa nel maggio del 1945 dal campo di Malchow, una dei soli 25 ragazzi sopravvissuti del suo gruppo. Per molti anni ha mantenuto il silenzio sulla sua esperienza, ma a partire dagli anni ’90 è diventata un’instancabile testimone della Shoah. Nel 2018 è stata nominata senatrice a vita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Primo Levi
Scrittore, partigiano e chimico, Primo Levi è forse uno dei superstiti della Shoah più conosciuti. Nato in una famiglia ebrea piemontese, si unì a gruppi antifascisti e fu catturato nel 1943. Deportato ad Auschwitz il 22 febbraio 1944, vi arrivò dopo cinque giorni di viaggio e fu registrato con il numero 174517. Sopravvisse grazie alla sua intelligenza e all’aiuto di altri prigionieri, rimanendo nel campo fino alla liberazione da parte dell’Armata Rossa nel gennaio 1945. La sua esperienza è raccontata nel capolavoro memorialistico Se questo è un uomo. Nonostante il successo letterario e scientifico, i traumi della prigionia non lo abbandonarono mai e l’11 aprile 1987 fu trovato morto nella sua casa di Torino, molto probabilmente suicida.
Otto Frank
Tra i superstiti della Shoah, Otto Frank è noto per essere stato il padre di Anna Frank e l’unico sopravvissuto della sua famiglia. Dopo l’arresto nel nascondiglio di Amsterdam, trascorse cinque mesi nel campo di Auschwitz, riuscendo a sfuggire alla “marcia della morte” nascondendosi nell’infermeria. Fu lui a decidere di pubblicare il diario della figlia nel 1947, trasformandolo in una delle testimonianze più potenti dell’Olocausto. Morì nel 1980 per un cancro ai polmoni.
Nina Weil
Aveva solo dieci anni quando, nel 1942, venne deportata insieme alla madre. Ricorda di aver visto i tedeschi arrivare con i carri armati e l’imposizione della “stella gialla” a tutti gli ebrei. Il numero tatuato sul suo braccio era il 71978. Di quel momento racconta: «non piansi per il dolore ma per il numero che mi stavano assegnando». Riuscì a sopravvivere insieme ad altre 36 persone del suo gruppo e fuggì in Svizzera, dove si è ricostruita una nuova vita senza mai dimenticare il passato.
Samuel Modiano
Detto Sami, è un attivo testimone tra i superstiti della Shoah. Nato nel 1930, a otto anni fu espulso dalla scuola a causa delle leggi razziali. Deportato il 23 luglio 1944, il suo nuovo nome divenne un numero: B7455. Nei campi conobbe Piero Terracina, con cui strinse «un’amicizia vera, profonda e fraterna». Si salvò il 26 gennaio 1945, un giorno prima dell’arrivo dei soldati sovietici.
Ingrid Pitt
Nata da padre tedesco e madre ebrea polacca, fu deportata da bambina nel campo di concentramento di Stutthof, a cui riuscì a sopravvivere. Dopo la guerra, si trasferì a Berlino, sposò un militare americano e si trasferì in California. Lì scoprì il mondo del cinema, ottenendo un piccolo ruolo ne Il dottor Zivago (1965). Raggiunse il successo recitando in film horror, diventando un’icona per gli appassionati del genere.
Viktor Frankl
Neurologo e psichiatra austriaco di fama mondiale, Frankl proveniva da una famiglia ebrea agiata. Dopo l’annessione dell’Austria alla Germania, cercò di ostacolare l’Aktion T4, il programma di “eutanasia” nazista contro i malati psichiatrici. Nel 1942 fu deportato ad Auschwitz con tutta la sua famiglia. Durante la prigionia, elaborò le basi della logoterapia, una forma di analisi psicologica basata sulla ricerca di un senso nel proprio vissuto. Liberato nel 1945, tornò a Vienna e divenne primario del policlinico neurologico per 25 anni.
Elisa Springer
Scrittrice ungherese di origine ebraica, visse a Vienna fino all’arresto della sua famiglia. Rimasta sola, si trasferì a Milano, ma nel 1944 fu tradita da una spia fascista, arrestata e condotta ad Auschwitz, dove conobbe personalmente Anna Frank. Liberata nel 1945, si trasferì definitivamente in Italia, dove visse per decenni in silenzio, finché non decise di raccontare la sua storia nel libro Il silenzio dei vivi.
Cosa è successo dopo la liberazione: il difficile ritorno alla vita
Il ritorno alla normalità per i sopravvissuti di Auschwitz e degli altri campi fu un percorso segnato da traumi fisici e psicologici profondi. Molti trovarono le loro case distrutte e le loro famiglie sterminate. La società stessa faticava a comprendere la portata dell’orrore che avevano vissuto. Per questo, alcuni scelsero un lungo silenzio, come Elisa Springer, mentre altri, come Primo Levi, sentirono il dovere di raccontare immediatamente. Questo impegno a testimoniare è diventato per molti una ragione di vita, un modo per onorare le vittime e per educare le nuove generazioni affinché l’orrore della Shoah non si ripeta mai più.
Articolo aggiornato il: 11/01/2026