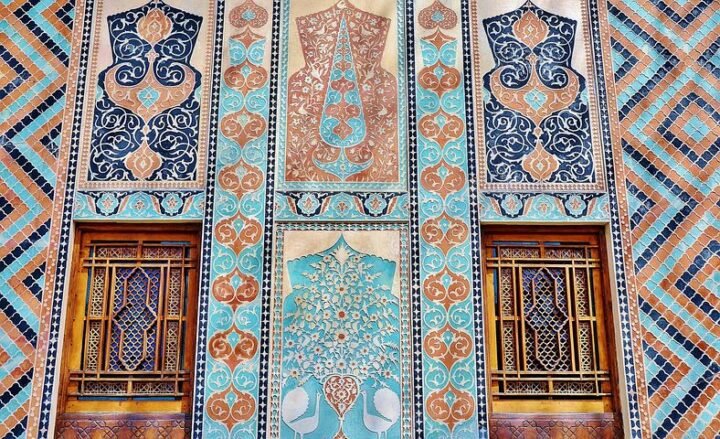A Sarno, la preparazione della Settimana Santa è lunga: i quadri e le statue in tutte le chiese sono coperti da panni viola, le campane non suonano, al loro posto c’è la tronola, uno strumento di legno e ferro che richiama alla preghiera col suo suono stridulo. Vengono preparati i sepolcri, simulacri della morte del Cristo, circondati da fiori e piante di grano, le quali crescono al buio per lunghi giorni e venivano decorate, soprattutto in passato, da nastri rossi del colore della passione e del sangue di Gesù Cristo; il grano rappresenta invece il pane, il Suo corpo. Per ogni sepolcro a Sarno c’è una “guardiana”, solitamente una donna anziana che si occupa di raccogliere fondi per allestire il sepolcro, sovrintende alla sua costruzione e/o vi partecipa. Il Giovedì Santo rappresenta il prologo del doloroso Venerdì Santo. Durante il tardo pomeriggio del Giovedì ha inizio lo struscio, un rito antico a cui partecipano tutti: consiste nel visitare i sepolcri (3, 5 o 7 a scanso di sfortuna), ed è chiamato così perché si camminava strusciando i piedi in segno di umiltà. La notte, invece, si prepara il focarone, per riscaldare il gruppo di fedeli che veglierà fino all’alba e all’arrivo della prima croce dei Paputi, e il pignatiello di fagioli.
Indice dei contenuti
Guida alle Croci dei Paputi
| Croce / Confraternita | Colore Veste | Colore Cordone/Dettagli |
|---|---|---|
| San Matteo | Rossa | Rosso |
| San Francesco | Marrone (Saio) | Canapa (volto scoperto) |
| Episcopio | Bianca | Rosso |
| San Teodoro | Bianca | Rosso scuro |
| Tre Corone | Bianca | Nero (con fascia rossa) |
| Immacolata | Bianca | Celeste |
| San Sebastiano | Bianca | Bianco (frangia su fondo rosso) |
| Sant’Alfonso | Bianca | Viola |
| Sant’Alfredo | Bianca (lunga) | Bianco |
Le regole antiche
Dal Giovedì al Sabato Santo vigevano delle regole antiche, ancora oggi rigorosamente rispettate dai più anziani. Ad esempio, si mangiava cibo leggero senza tovaglia, le donne non potevano usare la scopa e quindi spazzare la casa, non si battevano i piedi a terra e nemmeno vi si sputava perché si dice che in questi giorni “Gesù sta a terra”. Non era ammesso ridere, cantare, scherzare. Tutti vestivano a lutto, con colori scuri; tutti attendevano l’alba dei Paputi.
Le Confraternitas o Croci
La nascita delle Confraternite religiose a Sarno risale al 1200 ed è da queste che si svilupperanno le Croci dei Paputi. Le più antiche Confraternite sarnesi, di cui fanno parte i confratres (popolarmente “fratielli”), sono quelle di San Giovanni Battista, di Santa Maria Maddalena e di San Bernardino. Già dal loro numero iniziale, il 3, se ne può intuire il carattere iniziatico ed esoterico, confermato dalla successiva nascita di altre due Confraternite nel XVI secolo, di Episcopio e San Matteo, che prendono insieme il nome di Confraternite del Santissimo Sacramento; si arriva quindi al numero 5, altrettanto sacro per i cristiani. Nel corso dei secoli successivi, le Croci hanno subito altri cambiamenti, fino alla nascita recente della Confraternita o Croce di Sant’Alfonso e quella ancor più recente di Sant’Alfredo, giungendo al numero 7. Anche i sepolcri che il fedele deve visitare durante lo struscio del Giovedì Santo devono essere 7. Le parole di Gesù morente sulla croce sono 7, così come i giorni della Creazione e i gradi della perfezione. Oggi, però, le Croci sono di numero pari.
I Paputi e il Venerdì Santo
In seguito a numerose tracce, il termine “paputo”, nella zona di Sarno, stava ad indicare una persona pacchiana e sciocca. In realtà, però, il significato reale è molto più misterioso: nello spagnolo arcaico esisteva il termine “paputo” come sinonimo di diavolo; proprio per questo divenne un termine per indicare l’aiutante del boia, significato collegato subito alla religione, per cui coloro che avevano portato Gesù Cristo alla crocifissione non potevano che essere boia, Paputi. In effetti, le processioni della Settimana Santa in Spagna, sono molto simili a quella sarnese.
I colori delle vesti e le diverse Croci
Il colore delle vesti dei Paputi di tutte le Croci è il bianco, simbolo della morte e della risurrezione. L’unica eccezione è rappresentata dalla Croce di San Matteo, i cui Paputi indossano una veste rossa, simbolo probabilmente della supremazia dell’antica Collegiata in questione, su tutte le altre chiese. Negli anni ’90 nasce un’altra nuova Croce, quella della chiesa di San Francesco, caratterizzata da sai francescani, quindi marrone scuro, che non coprono il volto.
Ogni croce, comunque, ha il suo tratto distintivo, oggi rappresentato dai cingoli penitenziali che stringono alla vita le vesti dei Paputi, o in pochi casi, dalle frange delle vesti. Le Croci sono:
- Croce di Episcopio: veste bianca e cordone rosso;
- Croce di San Teodoro: veste bianca e cordone rosso scuro;
- Croce di San Matteo: veste rossa e cordone rosso;
- Croce di San Francesco: saio francescano e cordone di canapa;
- Croce delle Tre Corone: veste bianca con frangia bianca su fascia rossa e cordone nero;
- Croce dell’Immacolata: veste bianca e cordone celeste;
- Croce di San Sebastiano: veste bianca con frangia bianca su fondo rosso, anche alle maniche, e cordone bianco;
- Croce di Sant’Alfonso: veste bianca e cordone viola;
- Croce di Sant’Alfredo: veste bianca più lunga e cordone bianco.
I canti antichi delle Croci dei Paputi
Ogni Confraternita è guidata da un Gran Cerimoniere, “‘a Mazza ‘e cerimonia” (dialett.). Solitamente è il più anziano, che porta in processione un’asta di metallo, sulla cui cima c’è una croce posta su una sfera; all’interno di quest’ultima ci sono, invece, pezzetti di metallo che risuonano ad ogni movimento. Il Gran Cerimoniere batte l’asta per terra ogni volta che la Croce deve fermarsi o camminare. I Paputi sono divisi in due file parallele, hanno passo strusciante e non possono scoprirsi il volto durante il cammino. All’inizio della processione ci sono il portatore della Grande Croce e i lampioni. Infine, in fondo, ci sono i Paputi che portano le crocelle, croci più piccole tenute sulla spalla.
I cantori (in passato ‘’le Pie Donne’’), durante la processione, intonano antichi canti strazianti, come lamenti di dolore. Questi sono stati tramandati oralmente, quindi hanno subito molti cambiamenti nel corso degli anni, ma oggi tutti risalgono ad un linguaggio tipicamente settecentesco.
Uno dei canti:
Di mille colpe reo,
lo so, Signore, io sono:
non merito perdono
né più il potrei sperar.
Ma senti quella voce,
che per me prega; e poi,
lascia Signor se puoi,
lascia di perdonar.
Fonte immagine: DOphotography
Articolo aggiornato il: 20 Gennaio 2026