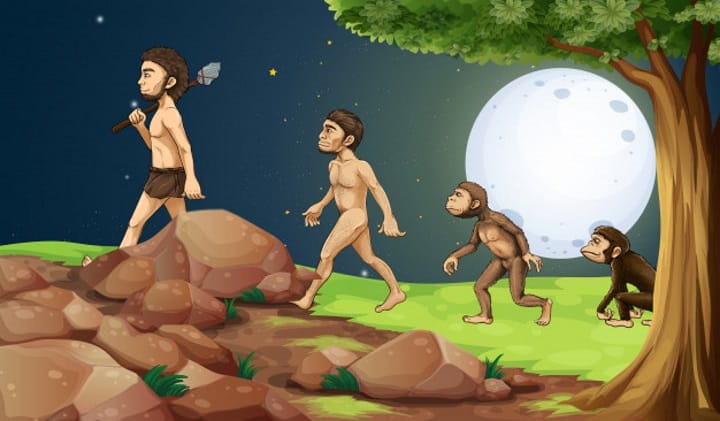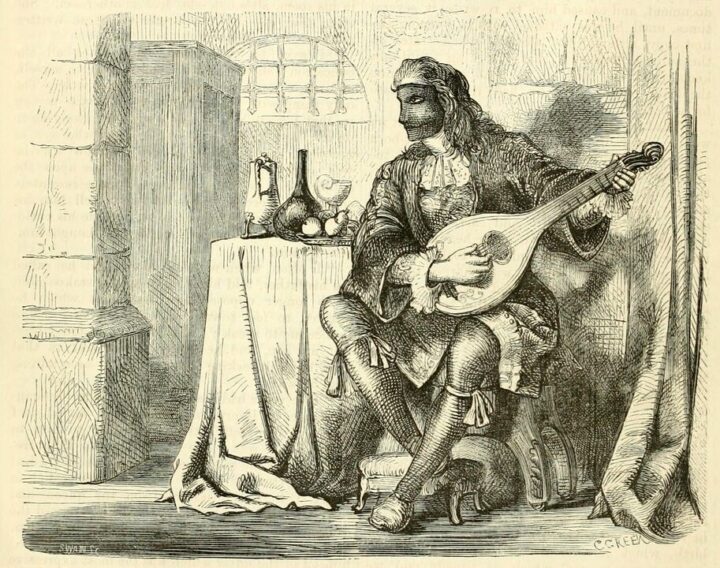Spesso il mito si confonde con la realtà, fino a dimenticare dove inizia l’uno e termina l’altra. Così è avvenuto per i cosiddetti uomini del bosco, o uomini selvatici, miticamente conosciuti per essere creature schive e scontrose che vivono nei boschi, lontano dalla civiltà, allo stato brado. Spesso viene loro conferita una dimensione quasi divina; nelle favole, infatti, le creature del bosco hanno caratteristiche magiche o spaventose, legate al loro vivere appartate, avvolte da un alone di mistero e oscurità, attributi tipici del bosco archetipo, luogo dell’incognita ma anche dell’avvicinamento alla natura originaria e ancestrale.
Scopriamo insieme le caratteristiche di queste emblematiche figure, che si muovono spesso tra realtà e leggenda.
Indice dei contenuti
Uomini del bosco tra realtà e tradizione mitica
Gli uomini del bosco sono figure topiche presenti in numerose culture. In quella europea, per esempio, popolerebbero le Alpi italiane, svizzere e austriache, ma anche i monti polacchi e catalani. Anche nella cultura asiatica sono presenti creature simili, quali lo Yeti (tibetano), nonché nel Nord America (Bigfoot) e in Oceania. È importante notare che non sempre questi personaggi assumono le caratteristiche tipiche dell’uomo selvatico europeo, ma divengono veri e propri primati poco evoluti.
Nella cultura europea, l’uomo del bosco ha un suo antenato nel fauno della cultura romana, personaggio mitico dell’ambiente agreste, o nel satiro, che però si avvicina maggiormente a un animale. Le caratteristiche tipiche degli uomini del bosco si stabilizzano nel Medioevo, diventando archetipiche per le tradizioni successive.
| Uomo selvatico (folklore europeo) | Primate ominide (criptozoologia) |
|---|---|
| È un essere umano che ha scelto o è stato costretto a vivere fuori dalla civiltà. | È una creatura scimmiesca, un animale la cui esistenza non è provata scientificamente. |
| Possiede conoscenze umane (agricoltura, caseificazione) che può insegnare. | Mostra un comportamento puramente istintivo e animale. |
| Rappresenta l’archetipo dell’uomo a contatto con la natura primordiale. | Esempi noti sono lo Yeti himalayano e il Bigfoot nordamericano. |
Le caratteristiche tipiche dell’uomo selvatico
Gli uomini del bosco vanno configurandosi come immagini simboliche tipicamente distaccate dalla civiltà, che vivono in maniera selvaggia e primitiva, isolati da tutti o in clan. Le caratteristiche fisiche sono accentuate dal contatto con la natura, mentre l’isolamento porta le qualità psichiche a una progressiva attenuazione. La loro immagine è imbarbarita, la pelle è spesso descritta come ricoperta di peluria simile al manto degli animali. Non hanno una dimora fissa, sono nomadi e si riparano in rifugi naturali o di fortuna. Spesso, però, si specializzano nella lavorazione e nella coltivazione di alcuni alimenti, oltre che nella caccia.
Il mito del buon selvaggio e la visione filosofica
Nei poemi dei classici latini, tra cui le opere di Orazio e di Virgilio, queste figure assumono caratteristiche positive, diventando simili a protettori, più vicine al mito del buon selvaggio. Questo concetto diventerà determinante con la teoria del Primitivismo e poi durante il Romanticismo, in particolare nelle opere di Jean-Jacques Rousseau. Secondo il filosofo ginevrino, il “selvaggio” è un modello positivo, inteso come creatura che vive in uno stato di natura, incontaminata e pura, ma soprattutto non corrotta dal progresso e dalle storture della società civilizzata.
La figura dell’uomo del bosco nella letteratura
Personaggi di questo genere diventano topici in letteratura. In Francia assumono spesso connotazioni positive: nel romanzo Yvain, il cavaliere del leone di Chrétien de Troyes, per esempio, il protagonista, dopo aver perso il senno per amore, si allontana dalla corte e vive nel bosco allo stato brado. È proprio questa esperienza a permettergli di ritrovare sé stesso e ridiventare un uomo degno. Caratteristiche prettamente negative assumono invece gli uomini del bosco nell’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, che ne fa una descrizione seguendo gli stereotipi della tradizione, così come avviene in alcune delle fiabe dei fratelli Grimm e di Calvino.
Fonte immagine: https://it.freepik.com/vettori-gratuito/evoluzione-dell-uomo-in-cima-alla-collina_5037822.htm#page=1&query=uomini del bosco&position=6
Articolo aggiornato il: 05/09/2024