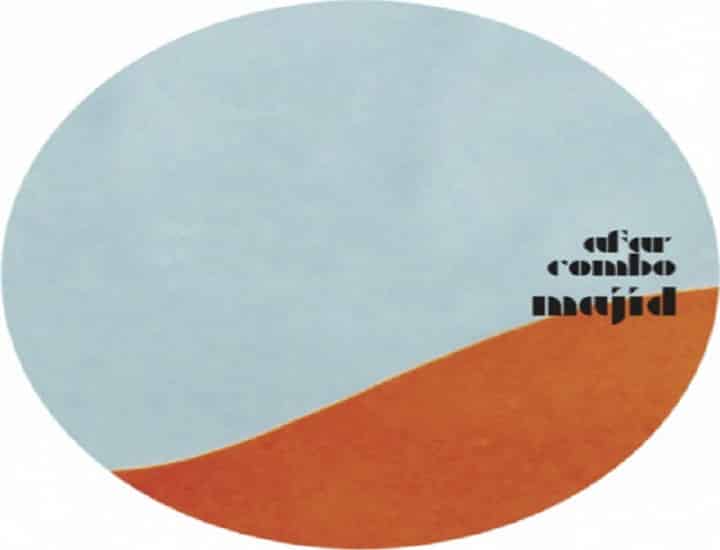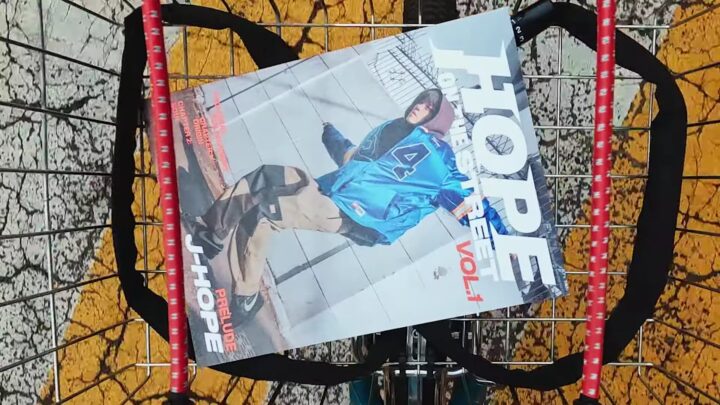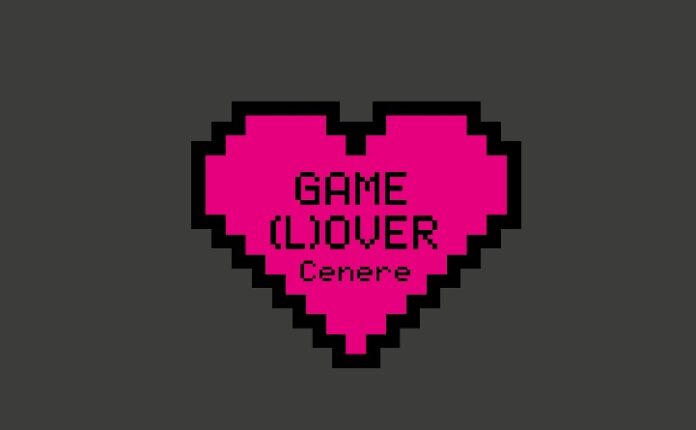La musica venezuelana, come quella tipica del centro-sud America, è un elemento culturale ed identificativo vero e proprio: la storia, la tradizione e anche la quotidianità sono impregnate di musica e in Venezuela, nello specifico, è poetica e malinconica, nonostante spesso colorata da ritmicità allegra e ballabile. Le sue origini risiedono nella fusione, forzata e violenta, di culture indigene, europee e africane che ha però regalato ai posteri una sonorità ormai riconoscibile a livello globale e su diversi livelli, da quello più tipicamente popolare e fruibile dalle masse alle rese straordinarie di Gustavo Dudamel, uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.
Indice dei contenuti
La musica venezuelana: un po’ di storia delle origini
Prima dell’arrivo degli spagnoli, la musica nelle civiltà indigene era legata al rapporto con la natura e le divinità: gli strumenti che venivano utilizzati erano tamburi in pelle, flauti di canna e le maracas e venivano suonati durante celebrazioni rituali e spirituali. Come per tutte popolazioni indigene delle Americhe, la musica era legata al ritmo della terra, della natura e della vita comunitaria. Con l’arrivo dei conquistadores spagnoli nel XVI secolo iniziò un lungo e forzato momento di cambiamento, sociale, culturale e quindi anche musicale: la musica iniziò a fondersi con quella europea che portava con sé altri strumenti, come il violino e la chitarra classica, e un altro tipo di fruizione, quello dell’intrattenimento. L’arrivo poi degli schiavi africani consegnò ancora un altro contributo a quella sonorità: la ritmicità, quella scandita dalle congas e dal tambor. Fu questa la fusione principale su cui poi nel corso dei secoli hanno iniziato a farsi strada le ramificazioni principali della tipica musica venezuelana e non solo.
La musica de los llanos: el joropo
L’joropo è la danza e la musica tradizionale del Venezuela. Nasce ne los llanos, le vaste pianure della parte interna del Venezuela, caratterizzate da estese savane, fiumi e una straordinaria biodiversità. Los llanos, insieme a los llaneros (gli abitanti di quelle aree immense) rappresentano una parte più che significativa dell’identità culturale venezuelana: los llaneros, ovvero i mandriani del luogo, sono quasi figure leggendarie, simbolo di forza e resistenza (si distinsero per il loro coraggio nelle guerre d’indipendenza dagli spagnoli nella prima metà dell’ ‘800) e los llanos, oltre alla loro bellezza incontaminata, sono tutt’oggi importanti per l’allevamento estensivo di bestiame, ma stanno anche diventando una meta interessante per l’ecoturismo, grazie alla possibilità di fare safari fotografici, birdwatching e tour fluviali.
Il termine joropo originariamente indicava una festa popolare, ma nel tempo ha iniziato ad essere identificativo di una danza e un tipo di musica specifica: caratterizzato da un ritmo rapido e complesso, è tipicamente eseguito con strumenti come l’arpa llanera, el cuatro (una chitarra acustica a quattro corde) e le maracas che creano insieme un tessuto musicale vivace e coinvolgente. Il canto poi è uno degli elementi più distintivi del genere: è spesso improvvisato ed è proprio dall’improvvisazione che nasce (come variante) il “contrapunteo”, un sorta di duello vocale tra due cantanti che si sfidano in versi improvvisati. L’joropo è anche una danza, decisamente energica e vivace, caratterizzata da passi veloci e sincronizzati dei ballerini. Tra i maggiori e indimenticabili compositori di joropo vanno citati Simón Diaz, autore dell’intramontabile “Caballo viejo”, Reynaldo Armas autore della splendida “Muerte del Rucio Moro” e Cristobal Jimenez, noto per mantenere uno stile molto fedele alla tradizione con testi che celebrano la vita rurale e l’identità llanera. Tutt’oggi, in città come El Tigre, nell’”interior”, è possibile assistere a festival dedicati al genere e durante i quali sfide di danza e poesia in musica riverberano tra le immense pianure, in celebrazione di un legame viscerale col passato e con la terra.
Gli anni d’oro delle grandi orchestre (1940–1970)
Tra gli anni ’40 e ’70, il Venezuela, e nello specifico la bellissima città di Caracas, visse un’epoca d’oro della musica orchestrale, segnata dalla nascita delle grandi “Orquestas bailables” che dominarono le sale da ballo, le radio e la nascente televisione. Queste orchestre mescolavano con eleganza stili come mambo, bolero, guaracha, swing e jazz, creando un’identità musicale urbana, festosa ma raffinata, grazie anche all’influenza di sonorità vivaci e drammatiche come quelle cubane di Pérez Prado ma anche de La Sonora Matancera con Celia Cruz. In quartieri come Altamira, o Chacao a finire all’hotel Humboldt situato sul Pico Naiguatà (montagna della catena montuosa dell’Avila), Sabana Grande e allo storico Hotel Tamanaco (centro nevralgico della vita notturna e musicale della città di Caracas di quegli anni), era possibile assistere ad esibizioni dal vivo delle orchestre più iconiche del settore, tra le quali spiccano la “Billo’s Caracas Boys”(1940) che con il suo stile elegante e un repertorio che andava da boleri romantici alla musica da ballo, conquistò presto insieme il pubblico venezuelano e quello latinoamericano. Altra formazione leggendaria è quella del Los Melodicos (1958) che si impose con un sound più moderno e versatile. A queste si aggiunsero anche l’orchestra de Los Satélités (1966) e quella di Federico y su Combo (1965), che iniziarono a rinnovare il repertorio popolare con le influenze non solo caraibiche ma anche statunitensi.
Salsa e Merengue tra gli anni’60 e ‘80
Fu tra gli anni ‘60 e ‘80 che la salsa iniziò a spopolare in Venezuela. Le forti influenze cubane e portoricane si fecero strada tra i suoni venezuelani e il carico di energia e passione che portavano con sé divenne identificativo di tutta una nuova generazione di musicisti. Tra i suoi massimi esponenti spicca senza ombra di dubbio Oscar D’León, conosciuto come il “Sonero del Mundo” che, con la sua voce potente, il suo carisma e talento ha regalato brani diventati oggi pietre miliari nella salsa non solo venezuelana, ma mondiale: “Lloraras” e “Yo quisiera”. Anche il merengue conquistò la stessa popolarità, grazie ad artisti come Roberto Antonio e Diveana, che durante gli anni ‘80 contribuirono a rendere il merengue più pop e soprattutto più ballabile.
La rivoluzione musicale de “El Sistema” e Gustavo Dudamel
Fu negli anni ’70 che la scena musicale venezuelana visse una grande rivoluzione che la coinvolse su diversi livelli: la nascita de “El Sistema”. Fondato nel 1975 dal maestro José Antonio Abreu, El Sistema si presentava come un programma educativo che si proponeva di utilizzare la musica come strumento di inclusione sociale, offrendo la possibilità a tutti i bambini venezuelani di imparare a suonare uno strumento e suonare in un’orchestra, a prescindere dal loro ceto sociale. Un progetto certamente ambizioso, che però col tempo ha non solo permesso la formazione di centinaia di orchestre sinfoniche giovanili ma è anche diventato modello imitato a livello internazionale per il suo rigore ma anche perché rappresenta una forma di riscatto e crescita personale per i musicisti.
Uno dei frutti più straordinari de El Sistema è certamente Gustavo Dudamel. Nato a Barquisimeto nel 1981, Dudamel è entrato ne El Sistema da bambino e subito mostrò un talento fuori dal comune, sia come violinista che come direttore d’orchestra. Già a 18 anni guidava l’Orquesta Sinfónica Simón Bolívar e nel 2009 divenne direttore musicale della Los Angeles Philharmonic. Dudamel è oggi uno dei direttori d’orchestra più riconosciuti e apprezzati al mondo, noto per la sua energia, la passione e il suo impegno sociale. Il suo repertorio spazia da Beethoven a compositori contemporanei venezuelani, e ha portato in palcoscenici prestigiosi l’orgoglio della musica venezuelana e della gioventù del suo paese, suonando anche brani come “Que rico mambo” di Pérez Prado che infiammano il pubblico (ma anche gli stessi musicisti!) riportandolo alle notti caraqueñe degli anni ‘50.
La musica venezuelana: un’ultima canzone
“Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas…“ sono le splendide parole che aprono l’”Alma llanera”, un brano così amato in Venezuela da essere considerato “L’inno nazionale non ufficiale” del Paese. Scritto nel 1914 da Rafael Rodrigo Coronado (scrittore e drammaturgo) e musicato da Pedro Elias Gutiérrez (direttore d’orchestra e compositore), il brano è un joropo la cui melodia intreccia influenze indigene e africane, musica classica e musica popolare europea, elementi tipici della cultura creola del Venezuela. Riconosciuta dall’UNESCO come parte del patrimonio culturale immateriale del Venezuela, l’Alma llanera è un bravo evocativo e nostalgico che celebra il profondo legame del venezuelano con la terra, immerso nel paesaggio degli sconfinati llanos. La canzone è sempre presente nella celebrazione di cerimonie, eventi, festival e spettacoli, ma viene anche eseguita in ambienti molto formali, come l’Opera, dove proprio Dudamel l’ha diretta sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. Nella sfera privata invece, l’Alma llanera segna “la despedida”, il saluto: è quando una festa sta per finire che in genere la si fa suonare, per salutare quindi le persone che hanno condiviso insieme un momento di gioia e amore, quelle persone che si lasciano all’alba di una notte di allegria e vengono così accompagnate verso un giorno nuovo. È l’ultimo saluto insieme poetico e malinconico a chi si ama e si continuerà ad amare per sempre.
Artisti chiave della musica venezuelana
| Artista | Genere | Contributo principale |
|---|---|---|
| Simón Díaz | Joropo | Autore di “Caballo Viejo”, icona della musica llanera. |
| Oscar D’León | Salsa | Il “Sonero del Mundo”, ambasciatore della salsa venezuelana. |
| Billo’s Caracas Boys | Musica tropicale | Simbolo delle orchestre da ballo degli anni ’40-’70. |
| Gustavo Dudamel | Musica classica | Direttore d’orchestra di fama mondiale, figlio de El Sistema. |
Fonte immagine: Pixabay
Articolo aggiornato il: 09/01/2026